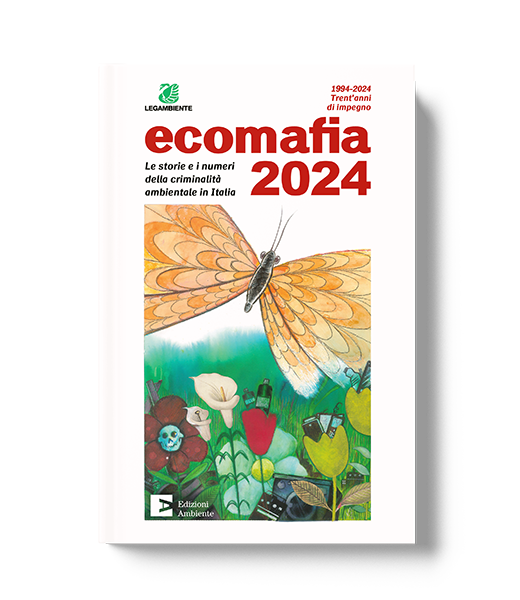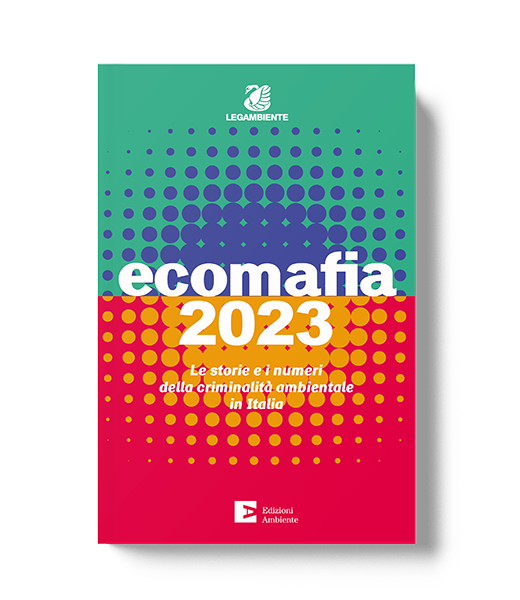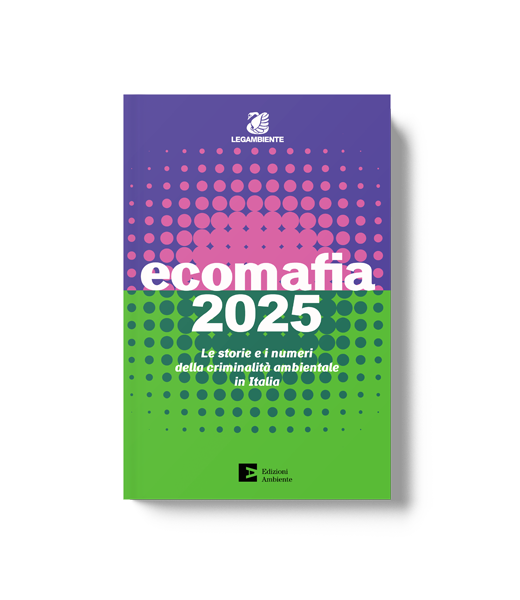Ecomafia 2025
Intervista a Enrico Fontana
111 al giorno: è la media dei reati contro l’ambiente in Italia nell’ultimo anno. Il Rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente restituisce anche quest’anno un quadro allarmante che conferma quanto la criminalità ambientale sia strutturata, diffusa e radicata nei territori ed è dedicato al 30° anniversario della scomparsa del Capitano di Fregata Natale De Grazia, morto tra il 12 e il 13 dicembre del 1995 mentre indagava sugli affondamenti sospetti nel Mediterraneo di navi con il loro carico di rifiuti.
Ne parliamo con Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente e curatore del Rapporto dalla prima edizione del 1994.
Ecomafia 2025
Le storie e i numeri della criminalità ambientale
a cura di Osservatorio nazionale ambiente e legalitàDa oltre 30 anni il Rapporto Ecomafia denuncia i reati contro l’ambiente commessi in Italia, cosa è cambiato nel tempo?
È cresciuta enormemente la consapevolezza della gravità dei fenomeni criminali che denunciammo con il primo Rapporto, realizzato allora in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Eurispes. Nel 1994 non c’era la percezione del ruolo delle mafie nei traffici illegali di rifiuti, anche tra chi indagava. Ma lo stesso discorso vale per l’abusivismo edilizio piuttosto che per i combattimenti tra cani e le corse clandestine di cavalli. Erano tutti reati di “serie B”, anche dal punto di vista delle sanzioni a cui andava incontro chi li commetteva, come tutti i reati contro l’ambiente. Dopo quel primo lavoro di ricerca, dal 1997 in poi, ogni anno, con la collaborazione di tutte le Forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto, il Rapporto Ecomafia è diventato uno strumento di analisi, denuncia e soprattutto proposta per rafforzare la prevenzione e la repressione dell’illegalità ambientale e degli interessi delle mafie.
Che cosa racconta il Rapporto Ecomafia 2025?
Innanzitutto, che l’illegalità ambientale, purtroppo, cresce. Abbiamo superato il muro dei 40.000 reati contro l’ambiente, cresciuti del 14,4% nel 2024 rispetto al 2023, quando erano già aumentati di quasi il 20%. Una progressione impressionante, anche perché cono quasi tutti reati d’impresa. Quelli più diffusi, pari a circa un terzo del totale, rientrano nel ciclo illegale del cemento, dall’abusivismo edilizio alle cave illegali fino ai reati connessi agli appalti per opere pubbliche. Ma a crescere sono soprattutto i reati nel ciclo dei rifiuti, dagli smaltimenti illegali ai traffici organizzati, che registrano un 19,9% in più rispetto al 2023. È significativo, inoltre, che il 42,6% dei reati si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, Campania, prima in assoluto da sempre, Puglia, Sicilia e Calabria. Non a caso abbiamo registrato ben 11 clan in più coinvolti in queste attività criminali rispetto al precedente Rapporto e cresce anche il fatturato illegale, arrivato a 9,3 miliardi. Sono fenomeni che s’intrecciano sempre di più anche con la corruzione: da maggio 2024 ad aprile 2025 abbiamo censito ben 88 inchieste per le mazzette relative agli appalti ambientali ma anche alla certificazione delle imprese.
Ci sono storie che l’hanno colpita durante la redazione del Rapporto?
In generale l’arroganza, la vera e propria protervia di chi saccheggia l’ambiente in cui viviamo, senza curarsi delle conseguenze, anche per la salute dei cittadini. Un caso emblematico è quello della provincia di Foggia, a cui dedichiamo un paragrafo del Rapporto, dove si susseguono gli smaltimenti illegali di rifiuti, a cui spesso viene dato fuoco, abbandonati direttamente nei terreni agricoli. Ma nel Rapporto vengono anche raccontate, grazie ai contributi scritti direttamente da tutte le Forze dell’ordine, la Dia, le Capitanerie di porto i risultati delle attività che hanno svolto nel 2024. A colpirmi è stata anche la crescita, esponenziale, dei reati e dei sequestri di pesticidi illegali compiuti nel nostro Paese, in linea con quanto sta accadendo i Europa: veleni che finiscono direttamente nei terreni agricoli e, quindi, nei prodotti messi in commercio, puntando sulla difficoltà dei controlli e, soprattutto, sull’assenza di sanzioni adeguate. Abbiamo ricordato, poi, due documenti molto importanti pubblicati prima che chiudessimo la redazione del rapporto: la relazione annuale della Direzione investigativa antimafia e quella dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, guidata da Giuseppe Busia.
Perché sono importanti?
La relazione della Dia relativa al 2024 descrive un sistema collaudato da parte delle mafie che consente anche di sviluppare relazioni e affari con la politica, grazie al voto di scambio, ma soprattutto con il mondo imprenditoriale, attraverso il riciclaggio di capitali di provenienza illecita e l’evasione fiscale. Viene registrata una vera e propria “accentuazione della vocazione economica delle consorterie”, afferma la Dia, che “si sposa, soprattutto nelle regioni trainanti per l’economia ove maggiore è la presenza imprenditoriale e più vivaci gli scambi finanziari, con la determinazione di evadere il fisco da parte di alcuni titolari di imprese che tendono ad aggirare le regole della libera concorrenza, ignorando i comportamenti fiscalmente corretti”. Insomma, le “tangenti frutto della prevaricazione delle consorterie vengono coperte da fatture fittizie, trasferendo il costo della mazzetta sul piano fiscale, si ottiene la convenienza da parte dell’imprenditore vittima a non denunciare l’estorsione”. E questo accade soprattutto in tante attività analizzate dal Rapporto, a partire dai traffici di rifiuti e non solo. L’interesse crescente delle mafie a “infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico dei territori, controllandone i meccanismi produttivi”, prosegue la relazione della Dia, arriva persino “ad orientare l’erogazione di alcune forme di servizi, sfruttando situazioni di emergenza quale, ad esempio, la grave carenza idrica che da qualche tempo affligge, per vari motivi, la Sicilia. In alcuni documentati casi ed in specifici territori della Regione, la distribuzione dell’acqua ad uso irriguo – afferma la Dia – è risultata di fatto, controllata dalla famiglia mafiosa ‘batanese’ (della provincia di Messina, ndr) che subordina l’erogazione idrica alla dazione di un “prezzo maggiorato da parte dei conferitari”. In altri casi, in seguito all’operazione “Feudo” conclusa nel mese di gennaio 2024, sono emerse prove della gestione abusiva della rete idrica per la distribuzione dell’acqua ad uso civile, da parte del boss della famiglia mafiosa di Carini (Pa)”. Davvero impressionante.
E che cosa accade sul versante della lotta alla corruzione?
Nel Rapporto Ecomafia, insieme alle tante inchieste, rilanciamo quello che ha denunciato il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, nella relazione annuale relativa al 2024, presentata il 20 maggio alla Camera dei deputati, che ha ricordato il segnale d’allarme “venuto dall’arretramento dell’Italia nell’indice di percezione della corruzione di Transparency International, con la perdita, nel 2024, di due punti e ben dieci posizioni, dopo tredici anni di risultati positivi o stabili”. Tra le diverse ragioni della crescita del “pericolo corruzione”, sempre il presidente Busia ne ha segnalato alcune più volte denunciate da Legambiente, a cominciare dagli affidamenti diretti per gli acquisti di servizi e forniture, pari al 98% del totale. “Numerosi risultano, in tale contesto, i frazionamenti artificiosi degli appalti – si legge nella relazione – finalizzati a mantenere gli importi al di sotto della soglia di legge e, spesso, anche ad eludere l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti”. Le conseguenze sono facilmente immaginabili: “Un proliferare di comportamenti anche opportunistici dietro i quali si nascondono sovente sprechi irragionevoli e purtroppo qualche volta anche infiltrazioni criminali e mafiose”. Stazioni appaltanti poco qualificate e corruzione s’intrecciano, spesso, con un’altra gravissima emergenza: quella degli incidenti nei cantieri, anche questi purtroppo in crescita. “È inammissibile – afferma sempre Busia nella sua relazione sulle attività dell’Anac – che si continuino a registrare ancora troppi incidenti e troppe morti sul lavoro. Preoccupano i dati del nostro Casellario delle imprese: 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nel 2024, con un incremento del 43% rispetto al 2023 e del 87% rispetto al 2022. In questo contesto, i rischi maggiori vengono dai subappalti, specie se realizzati a cascata”. Un’altra modifica del Codice dei contratti stigmatizzata più volte da Legambiente.
Legambiente richiede a gran voce una risposta politica: a che punto siamo sul recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente entro il 21 maggio 2026?
È la prima delle dodici proposte che abbiamo inserito nel Rapporto Ecomafia. Il Parlamento ha approvato la legge delega e ora il governo deve presentare prima possibile il decreto legislativo di recepimento di questa direttiva fondamentale. L’Italia ha fatto passi in avanti importanti, con l’introduzione nel 2015 dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale, di cui abbiamo ricordato insieme a Libera durante la conferenza nazionale “ControEcomafie”, che si è svolta a Roma nel maggio scorso, i risultati straordinari ottenuti in dieci anni di applicazione, rilanciati anche nel Rapporto Ecomafia. Con il recepimento della direttiva vanno inseriti i nuovi delitti ambientali previsti, come il saccheggio delle risorse idriche e quelli contro le specie protette. Ma deve anche essere definito un piano nazionale di lotta all’abusivismo e vanno finalmente introdotti mel Codice penale i delitti contro le agromafie, compreso quello di produzione, commercializzazione e utilizzo di pesticidi illegali. Sentenze recenti, come quella del 26 giugno che ha visto la condanna fino a 17 anni di reclusione dei responsabili dell’inquinamento di Pfas causato dallo stabilimento Miteni in provincia di Vicenza, un’altra delle storie raccontate nel Rapporto Ecomafia, fanno capire come l’impegno per l’ecogiustizia, per quanto difficile e faticoso, sia capace di dare frutti.
Immagine: Gio Bartlett (Unsplash)