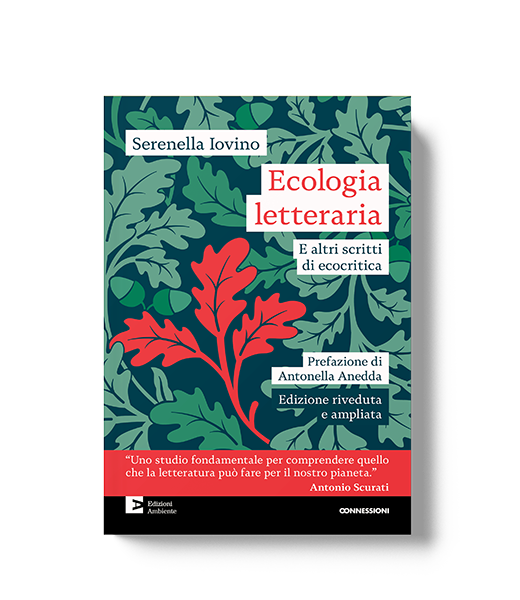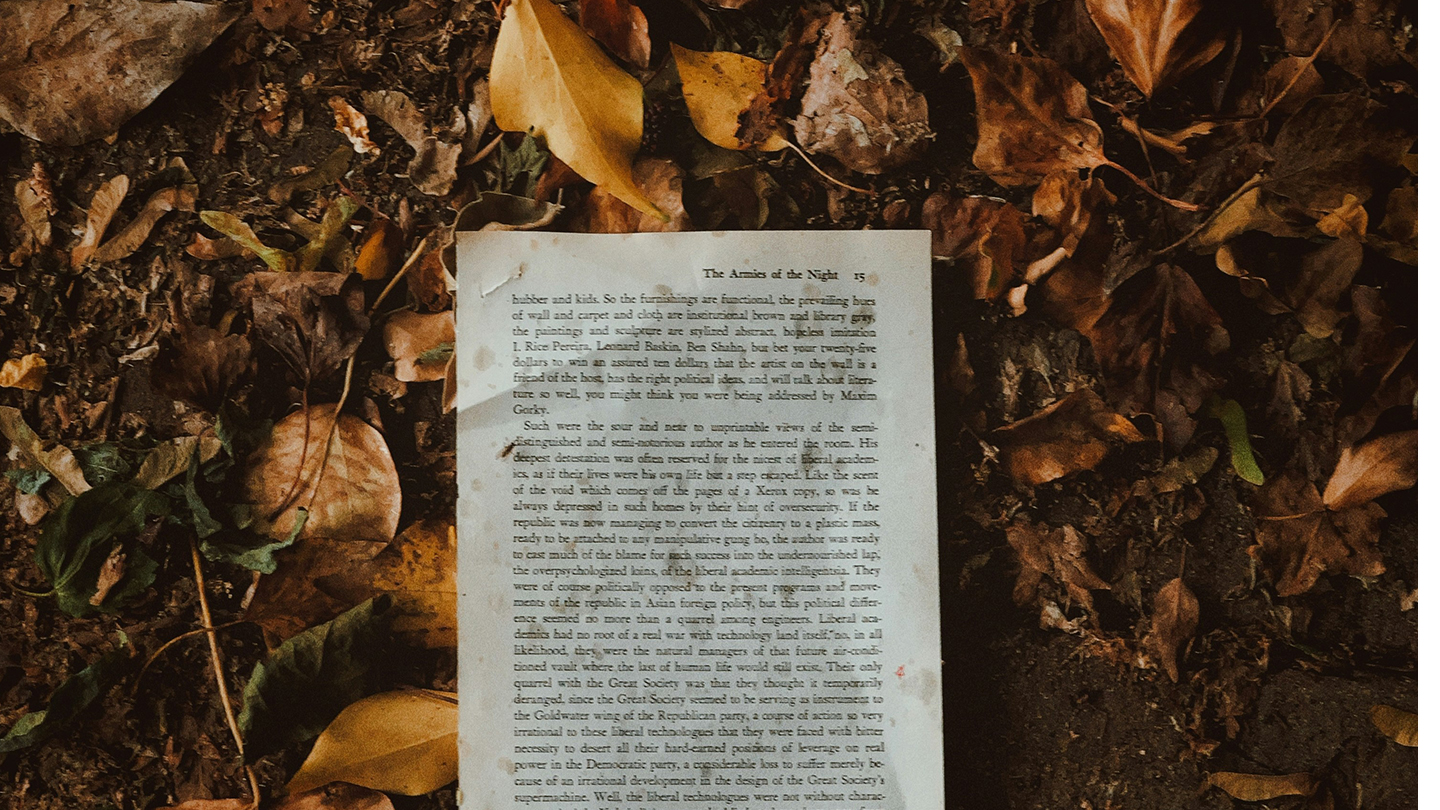
Il ruolo del romanzo e l’ecologia letteraria
Un interessante articolo uscito da poco sulla newsletter “Appunti” si interroga sul ruolo della fiction letteraria nel dibattito pubblico e come veicolo per la comprensione degli eventi sociali. L’oggetto principale è l’opera M il figlio del secolo di Antonio Scurati, il cui successo in un momento di risveglio generalizzato dei fascismi non può passare inosservato. L’autore dell’articolo si sofferma sul fatto che in Italia per la comprensione di fenomeni che interessano la società ci si affida più ad “autori e autrici che nascono o sono principalmente romanzieri. Dunque, persone che lavorano con il registro della finzione e non con quello dei fatti.”
E cita a titolo di esempio Pasolini assunto a riferimento per “capire” gli anni Cinquanta e Sessanta, Saviano per la mafia, Murgia per i problemi di genere ecc. Per il fascismo (passato e risorgente), evidentemente, il riferimento oggi è Scurati.
Nell’articolo però la risposta alla domanda su quale debba essere il ruolo del romanzo nel dibattito pubblico rimane aperta. Scrive l’autore dell’articolo: “Provvisoriamente, direi che è importante riconoscere i limiti dei testi letterari nella comprensione che abbiamo del mondo. È importante renderci conto e domandarci se le nostre intuizioni sui fenomeni sociali sono state influenzate o modellate su testi letterari, più che su testi scientifici. Ed è importante definire i limiti delle competenze e dell’autorità intellettuale delle persone che popolano il dibattito pubblico. Questo non vuol dire che i romanzi e i romanzieri non debbano avere un ruolo o debbano avere un ruolo secondario. Ma questo ruolo non deve essere quello di spiegare o analizzare i fatti. Perlomeno, non può esserlo in forza dell’essere romanzieri. Se lo possono avere, è per altre competenze, acquisite in altri modi”. Punto di vista condivisibile e uno spunto di riflessione che arriva con perfetto tempismo nel momento in cui pubblichiamo l’edizione rivista e ampliata di Ecologia letteraria, long-seller di Serenella Iovino, guarda caso, con un significativo endorsement in copertina a firma proprio di Antonio Scurati.
Ecologia letteraria
E altri scritti di ecocritica
Serenella IovinoEcologia letteraria è il libro che ha introdotto in Italia l’ambito di ricerca delle environmental humanities, scienze umane per l’ambiente, come ricorda l’autrice nella nota introduttiva alla nuova edizione. La creazione letteraria è l’ambito da cui si è sviluppato questo campo di ricerca che non propone un ecologismo letterario, ma indaga “la letteratura come parte dell’ecologia della mente e del mondo”.
La domanda che si pone l’autore dell’articolo spinge quindi a una ulteriore riflessione. Il romanzo, come ogni prodotto della creatività, è esso stesso un fenomeno sociale, a sua volta partecipe di fenomeni sociali più ampi. Se il fare creativo è una lettura, una interpretazione della realtà e a volte una proiezione verso il futuro, il romanzo, la creazione letteraria, ha una legittimità come strumento per la comprensione dei fenomeni sociali, ma come suggerisce l’approccio ecocritico, è il modo in cui lo leggiamo che lo può rendere tale. Gli autori richiamati nel libro di Serenella Iovino – Ortese, Levi, Lispector, Pasolini, Borges e altri – non vengono arruolati in un improbabile ruolo di “scrittori ecologisti”, ma delle loro opere si evidenzia l’essenza di “elemento operativamente funzionale alla nostra sopravvivenza” per la capacità di aiutarci a pensare il nostro rapporto con il mondo. A patto di leggerli, naturalmente.
Tornando al punto iniziale, sulla sovraesposizione degli autori di romanzi nell’informare il dibattito pubblico credo perciò vada fatta una distinzione. Una cosa è l’effettiva lettura dei libri e il suo impatto sulla società, altra cosa è la visibilità dell’autore. Questa ritengo vada in buona parte ricondotta alle attitudini e modalità di altri media e ambiti della comunicazione che utilizzano gli scrittori come opinion maker. Non può essere considerato un fattore negativo di per sé, anche se ovviamente può esserlo, ma soprattutto, non ne farei una questione di genere, perché scrivere saggi invece di romanzi non è necessariamente garanzia di qualcosa, basta guardare alla visibilità di pseudo esperti negazionisti che sono anche autori di saggi su molti tra i temi che trattiamo con i nostri libri.
Se ci fermiamo alla figura dello scrittore come generico opinion maker e trascuriamo il fatto che questo ruolo deriva dall’aver scritto qualcosa, e che questo qualcosa andrebbe letto per farci un’idea di chi abbiamo davanti quando compare, per esempio, in un talk show o nella conduzione di un programma, in un podcast ecc., allora la preoccupazione verso la sovraesposizione dei romanzieri acquista un senso. L’antidoto è comunque la lettura, che più di una “strategia di sopravvivenza”, come recitava il sottotitolo della prima edizione di Ecologia letteraria, diventa una vera e propria forma di resistenza in una fase storica in cui le modalità di formazione dell’opinione pubblica sono sottoposte a un processo di enorme semplificazione e controllo. In un presente dominato da quella che un altro autore ha definito “società dell’iperspettacolo”, della distrazione continua che divora il tempo del ragionamento e della costruzione di consapevolezza, leggere un libro è recuperare uno spazio dove è ancora possibile costruire pensiero critico e immaginazione del futuro, fuori dal presente infinito delle piattaforme social.
A monte, infine, la grande questione riguarda il “dibattito pubblico”: che cos’è oggi, di cosa è fatto, che forme assume? Da cosa trae sostanza, come e dove si manifesta? È ciò che propongono i media mainstream (social in primis) o esistono, nonostante tutto, altri spazi in cui si forma conoscenza che si traduce in opinione pubblica? Spazi abitati, per esempio, da saggi come Ecologia letteraria?
Immagine: Jon Tyson (Unsplash)