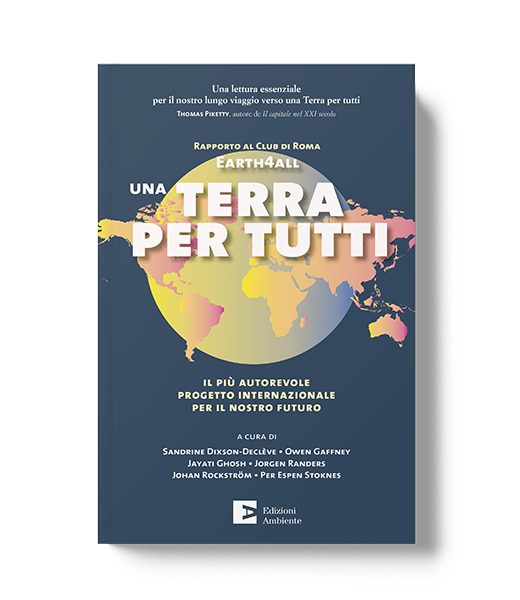Il grande disordine
Sulla transizione energetica si sono fatti passi avanti, ma ci sono ostacoli all'orizzonte
Transizione energetica. La sensazione che abbiamo in questi tempi è che sia passata in secondo piano, con il clima, viste le crisi e gli shock degli ultimi anni. Nonostante ciò si sono registrati segnali incoraggianti. Negli ultimi anni le fonti rinnovabili hanno continuato a crescere raggiungendo quote record di generazione elettrica, con oltre il 30% a livello mondiale, e il 50% in Europa nel 2025. Gli investimenti globali nel settore delle rinnovabili hanno superato, in termini di valore assoluto, quelli nelle fonti fossili, mentre l'innovazione in settori cruciali come l'accumulo energetico sta accelerando.
Tuttavia, in questo panorama che potrebbe (il condizionale è d'obbligo) svilupparsi, gli ostacoli sono molti e interconnessi: da un lato guerre, conflitti commerciali e rivalità tra potenze rendono il contesto geopolitico instabile, minando la cooperazione e la sicurezza delle forniture energetiche, mentre dall'altro lato problemi economici come l'inflazione, l'alto costo del denaro e le disuguaglianze, sia interne ai paesi del Nord del Pianeta, sia tra il Nord e il Sud, rallentano gli investimenti necessari a proseguire e creano resistenze politiche.
Circa la decarbonizzazione, inoltre, sono le sfide tecnologiche – dall'integrazione delle rinnovabili nei sistemi, all'estrazione di minerali critici, fino alle soluzioni ancora immature per settori come trasporti pesanti – e industriali che definiscono il ritmo massimo a cui potremo realisticamente decarbonizzare. Sopra tutto ciò, la dimensione sociale è sia un freno, sia un potenziale acceleratore. Senza consenso e partecipazione, la transizione rischia battute d'arresto, mentre con il giusto coinvolgimento della società e una serie di politiche di equità può invece guadagnare slancio, innescando un circolo virtuoso di sostegno pubblico. Certo, sarà necessario ridurre la forchetta sociale che, come ha affermato l'economista Thomas Piketty, ha raggiunto il massimo livello dal 1914.
Una Terra per tutti
Il più autorevole progetto internazionale per il nostro futuro
a cura di Jørgen Randers, Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève, Owen Gaffney, Jayati Ghosh, Per Espen StoknesOltre a ciò sarà fondamentale adottare strategie che affrontino insieme i vari aspetti, come, per esempio, piani di transizione che coniughino sicurezza energetica e clima riducendo le dipendenze geopolitiche attraverso le rinnovabili, pacchetti di incentivi “verdi” disegnati anche per creare posti di lavoro nelle comunità colpite dal phase-out dal fossile, accordi internazionali su materie prime critiche per evitare che la competizione si tramuti in ostilità.
Il World Economic Forum (WEF), analizzando il rimbalzo dell'indice di transizione energetica nel 2025 (i punteggi dell'Energy Transition Index 2025 del WEF sono cresciuti dell'1,1%, il doppio rispetto alla media triennale), avverte che i progressi restano fragili e soggetti a possibili ricadute se gli effetti di secondo livello degli shock geopolitici recenti dovessero manifestarsi appieno. Per esempio, una recrudescenza delle guerre commerciali o una recessione globale severa potrebbero distogliere ulteriormente risorse dalla decarbonizzazione.
La transizione energetica globale, quindi, ora è un percorso a ostacoli, visto che quattro grandi capitoli, geopolitica, economia, tecnologia e società, pongono sfide difficili. Sfide che interagiscono tra loro e talvolta si amplificano a vicenda. Riconoscerle e gestirle in modo sistemico è l'unica strada per mantenere l'obiettivo climatico in vita. Ma la visione sistemica stessa è a rischio.
Secondo un recente rapporto di JP Morgan Chase, invece di una transizione energetica globale unificata, si prevede una frammentazione e la formazione di blocchi regionali. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, "queste sfide, sicurezza energetica, impatti macroeconomici, divario Nord-Sud e disponibilità di minerali, avranno effetti significativi sul modo in cui la transizione si dispiegherà. Nessuna è facile da affrontare e oltretutto interagiranno tra loro, cosa che potrebbe amplificarne l'impatto".
E i segnali non sono per niente incoraggianti. Con i nuovi obiettivi circa i contributi climatici determinati a livello nazionale (NDC) la Cina si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra tra il 7% e il 10% entro il 2035, rispetto al picco massimo che dovrebbe arrivare tra breve, e il Commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra, ha definito l'obiettivo «chiaramente deludente». Una riduzione del 7-10% nel giro di dieci anni, per un'economia gigante, globalizzata e in crescita, fondata su un alto tasso di fonti fossili, ma impegnata a fondo sullo sviluppo della decarbonizzazione e delle rinnovabili, non è un obiettivo da sottovalutare. E stupisce la reazione del Commissario che rappresenta un continente, l'Europa, che deve parte del suo successo nella riduzione delle emissioni alla delocalizzazione della produzione industriale in Asia. E infatti la reazione di Pechino non si è fatta attendere.
"Alcune persone fanno orecchie da mercante e restano in silenzio quando sentono affermazioni come 'il cambiamento climatico è una bufala', ma invece ignorano e fanno commenti irresponsabili sulle azioni responsabili e proattive della Cina per affrontare il cambiamento climatico", ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri in una risposta scritta al commento di Hoekstra. Poco prima alle Nazioni Unite il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva definito il cambiamento climatico "la più grande truffa della storia" nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione non è eccellente.
Articolo pubblicato su Nextville.it, 6 ottobre 2025
Immagine: Greg Rosenke (Unsplash)