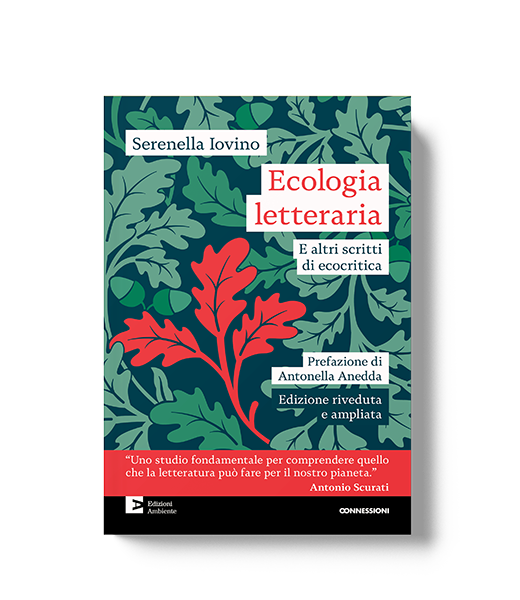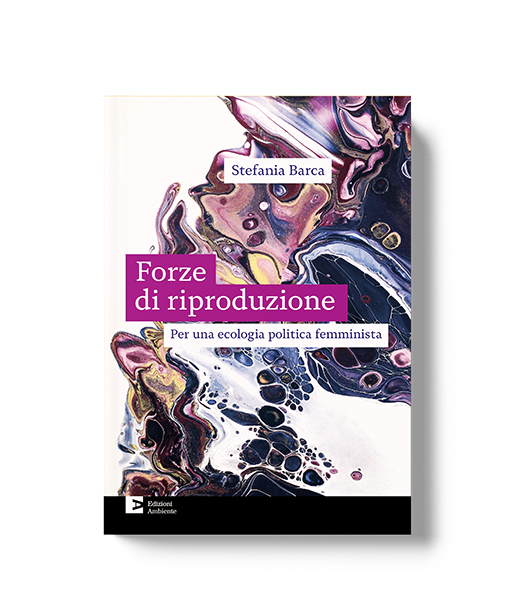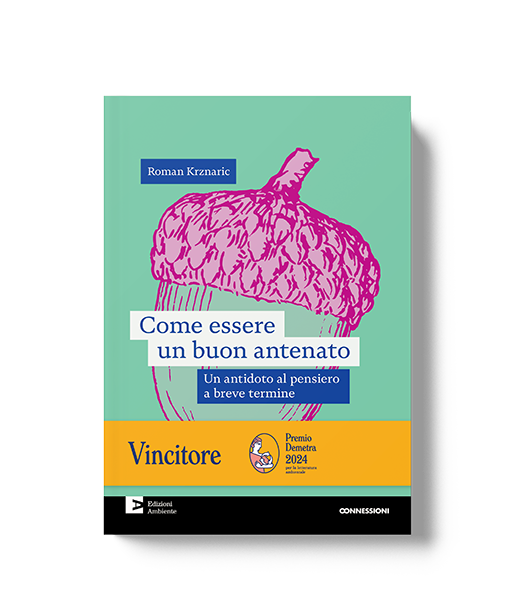Letteratura, arte e ambiente
Intervista a Serenella Iovino
Con Ecologia letteraria, uscito nel 2006, Serenella Iovino ha portato per la prima volta in Italia la voce dell’ecocritica, aprendo un campo di studi allora quasi sconosciuto. Quel libro, diventato presto un riferimento imprescindibile, mostrava come la letteratura e le arti siano parte integrante della vita della nostra specie: non astrazioni separate dalla materialità, ma forme di immaginazione capaci di ridefinire il nostro rapporto con il mondo.
Oggi quel volume è divenuto un classico della cultura ambientale: “uno studio fondamentale per comprendere quello che la letteratura può fare per il nostro pianeta”, per dirla con le parole di Antonio Scurati. E dopo quasi vent’anni torna in libreria. L’edizione riveduta e ampliata, con Prefazione della poetessa Antonella Anedda, affianca al testo originale un’ampia appendice dedicata agli sviluppi più recenti: dal material ecocriticism al pensiero dell’Antropocene, fino alle pratiche artistiche dei media digitali – nuove strategie di resistenza per ripensare il rapporto tra corpi, paesaggi, linguaggi e responsabilità.
Ecologia letteraria
E altri scritti di ecocritica
Serenella IovinoPerché “ecologia letteraria”? Ci spieghi brevemente di cosa si tratta? Come si lavora su un testo con l’approccio ecocritico?
Ho scelto “ecologia letteraria” per rendere immediatamente chiaro il senso dell’ecocritica: uno sguardo che mette in relazione letteratura e ambiente. Si tratta di leggere i testi non solo in rapporto a se stessi o alla loro tradizione, ma al mondo materiale che li produce e a cui parlano: paesaggi, animali, corpi, società, crisi ecologiche. In pratica, si tratta di vedere come la letteratura racconta l’ambiente e come l’ambiente entra nella costituzione materiale dei racconti. L’ecocritica ci dà strumenti teorici che ci aiutano a vedere queste dinamiche. E quindi ci mette in condizione, per esempio, di analizzare libri come Uomini, boschi e api di Mario Rigoni Stern alla luce degli studi sull’etnografia multispecie e il Decameron pensando alle implicazioni ecologiche e sanitarie delle pandemie, oppure di leggere La vegetariana di Han Kang connettendo ecofemminismo e gli studi sull’intelligenza delle piante. Ma le applicazioni e gli intrecci possibili sono innumerevoli.
Cosa intendi con “ecocritica della materia”?
La materia è tutto ciò che di solito consideriamo muto, e che invece parla. Parlano i nostri corpi – attraversati da sostanze inquinanti, segnati da contaminazioni invisibili, collegati ad altri corpi umani e non umani. Parlano le terre e i paesaggi, che custodiscono cicatrici e memorie. Ogni corpo conserva tracce della propria storia, e leggere la letteratura insieme a questi “testi materiali” ci aiuta a decifrarle, a riconoscere connessioni che altrimenti ignoriamo. E parlano anche i nostri rifiuti. Tra i saggi della nuova appendice di Ecologia letteraria ce n’è uno dedicato al chewing gum di cui scrive Primo Levi: una sostanza apparentemente banale, ma indistruttibile, capace di sopravvivere al tempo più di noi. In quel piccolo oggetto Levi vedeva già il simbolo di un’umanità che imprime al pianeta la propria traccia artificiale. L’Antropocene è la somma di tutte queste tracce.
Come può la letteratura agire sul mondo?
La letteratura ci abitua a immaginare connessioni che non vediamo e a vivere esperienze surrogate di ciò che non conosciamo direttamente. Generi come la climate fiction o la petrofiction ci insegnano che anche il clima e il petrolio sono protagonisti delle nostre storie: leggendo Shakespeare riscopriamo le tracce della Piccola era glaciale, mentre in Pasolini il petrolio diventa un soggetto che plasma politica e potere, oltre che la carne e la psiche delle persone. Philip Roth ha detto che dopo Se questo è un uomo nessuno può dire di non essere stato ad Auschwitz. Penso che valga anche per certi romanzi ambientali: da Gomorra di Roberto Saviano a Il sussurro del mondo di Richard Powers, o Solar Storms della scrittrice nativa americana Linda Hogan. Dopo averli letti, non puoi più dire di non sapere cosa significhi vivere in territori devastati dalla criminalità, dall’industria, dalla deforestazione o dall’inquinamento. E, tornando a Levi, non dimentichiamoci una cosa: anche la guerra ha una sua ecologia. Il “paesaggio” straziante e infernale del Lager, amplificato dalla sua scrittura, diventa ancora più materiale e vivo nella nostra percezione.
Insomma, un testo può agire sul mondo perché ci cambia lo sguardo. La letteratura non basta da sola, ma è una palestra per il pensiero: ci allena a leggere le trame della realtà. Sta a noi ricordarci che in queste trame c’è anche la nostra vita.
L’ecocritica è un metodo di analisi del testo o una forma di attivismo politico?
È entrambe le cose, o forse nessuna delle due in senso stretto. È uno sguardo. Un esercizio critico che non si accontenta di restare dentro la letteratura ma che ci mette in relazione con il mondo. È interdisciplinare, creativa, a volte persino spericolata. Non ha un’unica scuola, ma ha il rigore di chi sa che i testi non vivono in un vuoto astratto. E in questo senso, sì: ha sempre una valenza politica, perché ci mostra ciò che altri linguaggi – quelli del potere, per esempio – cercano di rimuovere.
Nella nuova Appendice dedichi un brano al museo torinese PAV, Parco Arte Vivente, frutto del genio di Piero Gilardi. Ci puoi anticipare qualcosa su quest’incontro tra giardino, arte ed ecologia?
Il PAV è un laboratorio straordinario: è arte, giardino e politica insieme. In una città postindustriale come Torino significa ricucire ferite e restituire respiro a un paesaggio segnato dall’industria, creando immaginari ecologici condivisi. Ma un giardino è anche altro: un artificio che ordina il caos naturale e può implicare costi nascosti o esclusioni. Calvino parlava del “rovescio del sublime” dei giardini zen dell’imperatore giapponese: dietro ogni pietra, storie di povertà e sacrificio al servizio del potere. Per questo un “giardino planetario” è ipotizzabile solo se, come per Gilles Clément, diventa un progetto politico: valorizzare la capacità della natura di proporre i suoi percorsi co-evolutivi, intrecciandoli al desiderio umano di respiro, salute e bellezza. Una visione che Piero Gilardi, invitando proprio Clément al PAV, aveva intuito benissimo.
Nel 2006 insegnavi all’Università di Torino, ora sei James G. Hanes Distinguished Professor alla University of North Carolina. Nel panorama italiano c’è qualcuno che lavora su questi temi? E cosa può fare l’istruzione per ricostruire una visione ecosistemica della realtà?
In Italia ci sono ottimi studiosi, e c’è una nuova generazione che si muove su questi temi, ma le istituzioni accademiche sono ancora indietro. La prima cattedra di Letteratura e ambiente è nata negli Stati Uniti negli anni ’90, oggi ce ne sono centinaia. In Italia siamo ancora agli inizi, anche se le cose stanno cambiando. L’istruzione può fare molto: insegnare a leggere testi letterari insieme al “testo” della realtà, mostrare che i saperi non sono separati, ma intrecciati. Ai miei studenti cerco di trasmettere questo: che ogni storia – sia scritta, sia vissuta – ci parla di un mondo materiale, ecologico, umano e non umano. E che imparare a leggere queste storie insieme è il primo passo per prenderci cura della Terra.
Immagine: credits Mario Amura