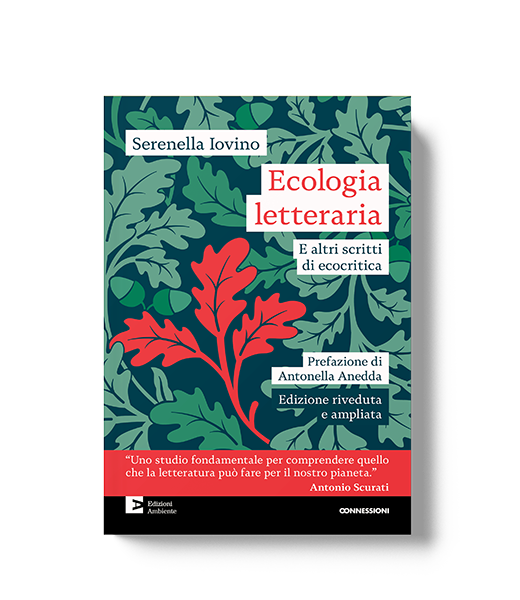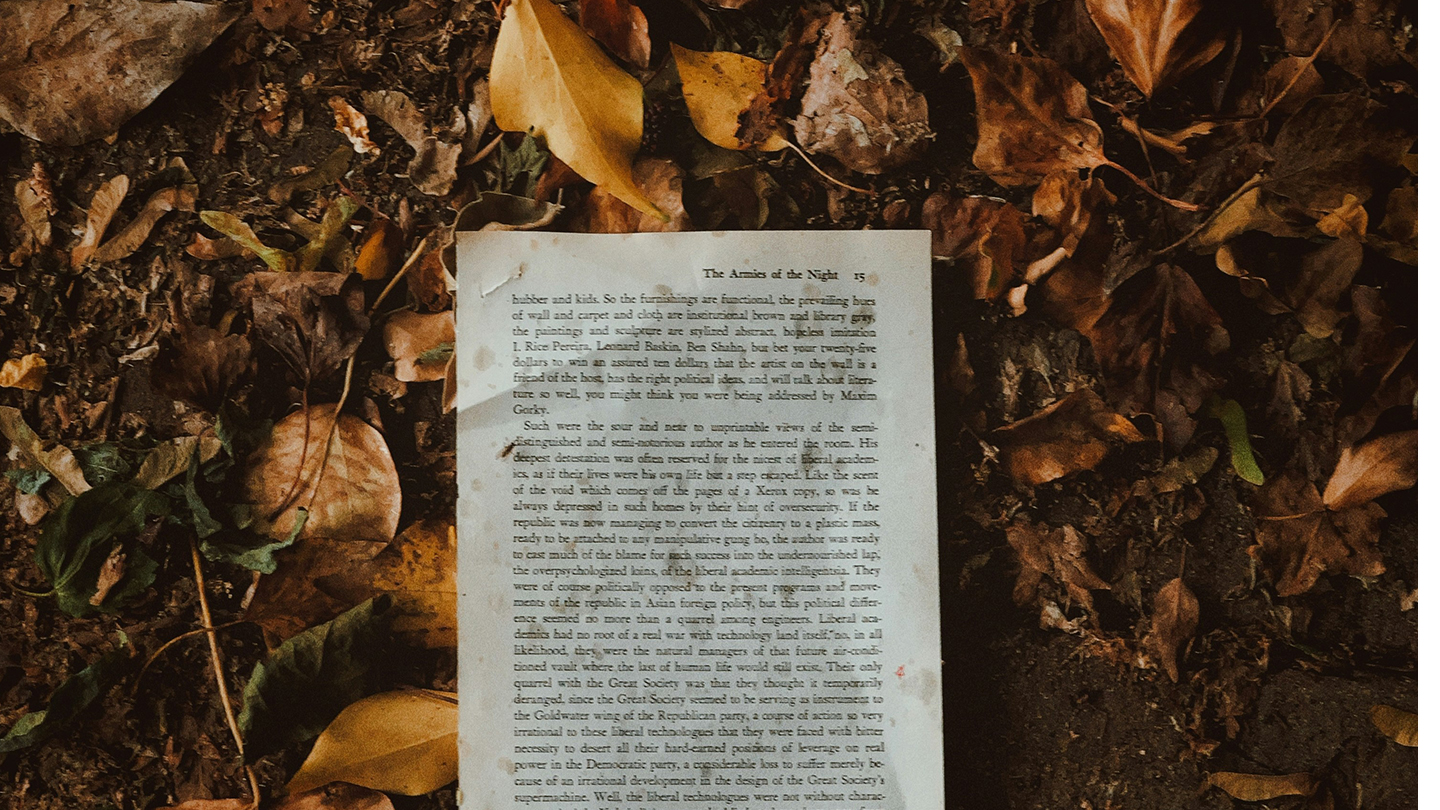Il giorno in cui nacque l’ecocritica
È il 1992, siamo in Nevada. Un gruppo di giovani studiosi di letteratura si dà convegno a Reno, in un grand hotel con casinò. Fuori c’è il deserto, fa un caldo micidiale. Dentro: roulettes, croupiers, slot machines. Luce artificiale, tappezzeria geometrica, aria condizionata. Neanche un orologio. In quell’ambiente sintetico che sa di polvere, fumo e Coca-Cola, loro parlano di ecologia e di wilderness, la natura selvaggia che tormenta da secoli l’identità e l’inconscio americani. Aleggiano come spiriti su acque invisibili i nomi di Thoreau, John Muir, Rachel Carson, insieme ai trascendentalisti e i poeti della beat generation. Quei giovani, e pure qualche veterano, hanno capito che la letteratura e il mondo non comunicano. O meglio: comunicano benissimo, comunicano da sempre. Il problema è come il mondo della letteratura – quello che si definisce tale nelle università – comunica con il mondo fuori, il mondo in carne e ossa: la Terra insomma. Quella Terra in pericolo che nel 1989 il Time Magazine ha messo in copertina come “uomo dell’anno”.
Ecologia letteraria
E altri scritti di ecocritica
Serenella IovinoAlla fine della conferenza nasce ufficialmente l’Association for the Study of Literature and the Environment, ASLE per gli amici. Sarà la casa di una nuova disciplina: l’ecocritica, oggi insegnata in tutto il mondo e anima delle environmental humanities, le scienze umane per l’ambiente.
Ma che cos’è l’ecocritica? E come ci erano finiti quegli accademici in un casinò? Alla prima domanda basta (per ora) una definizione: è lo studio del rapporto tra letteratura e ambiente. Alla seconda si risponde con un nome: Cheryll Glotfelty. Durante il dottorato alla Cornell si accorge che nei dipartimenti di letteratura c’è una teoria per tutto – classi, generi, razze, poteri – ma niente che riguardi l’ambiente. È come se il pianeta, la crisi socio-ecologica, gli altri animali non esistessero. Altrove, intanto, si protesta, si marcia, si canta, si digiuna, si scrive. Con la sua ostinazione e quel pizzico di rispettosa sfacciataggine tipica degli studenti americani, Cheryll manda una lettera a duecento studiosi. C’è scritto: “che possiamo fare, noi letterati, per salvare il pianeta? Se non trovo una risposta, giuro, cambio mestiere”. In allegato una bibliografia, destinata a diventare l’ossatura di quello che lei già chiama ecocriticism. Molti le rispondono; e di lì, passando per Reno, comincia l’avventura.
All’inizio l’ecocritica lavora soprattutto su testi anglo-americani, dove la componente naturalistica è forte e il messaggio etico immediato. Quasi subito però il campo si allarga. Fioriscono gli intrecci con l’ecofemminismo, gli animal studies, la giustizia ambientale, l’ecologia politica, gli studi postcoloniali. E si moltiplicano i dialoghi con altri linguaggi – cinema, arti visive, nuovi media, giornalismo – mentre prende forma un crogiuolo di teorie: postumaniste, biosemiotiche, neomaterialistiche, narratologiche, eco-cognitive, ontologiche object-oriented. In parallelo, l’ecocritica ha varcato i confini ed è approdata in Asia, in India, in Australia, in Europa (sì, anche in Italia), e infine in Africa. Oggi parla tutte le lingue e attraversa tutte le letterature e i periodi. Ci sono interpretazioni ecologiche dell’epopea di Gilgamesh e delle Metamorfosi di Ovidio, di Flaubert e dei Fratelli Grimm, di Han Kang e Murakami Haruki. Esistono studi sulla poesia cinese contemporanea e sulla Mahābhārata, sulla fantascienza italiana e l’ecosaudade brasiliana. C’è un’ecocritica mediterranea, vittoriana e perfino bizantina. Non tutto ha lo stesso peso, ma il semplice fatto che questi studi esistano mostra l’energia e la necessità di uno sguardo ecologico sulla letteratura.
Perché non è una moda, ma un bisogno. Il bisogno di vedere il corpo delle idee, di capire come la letteratura possa raccontare il solco – più spesso, la ferita – che si apre tra umano e non umano. Con i suoi dialoghi interdisciplinari, l’ecocritica ci insegna a seguire il filo teso tra parole e sostanze, a immaginarci il tempo, le relazioni, le trasformazioni. A riconoscere l’intreccio che lega i nostri corpi agli altri corpi e la violenza lenta delle contaminazioni invisibili che attraversano territori e vite.
L’ecocritica infatti non è solo un modo per leggere un testo in riferimento a se stesso, ma anche al mondo che lo produce e a cui parla. Si può fare ecocritica guardando come in un romanzo vengano rappresentati animali, paesaggi o questioni ambientali, ma questo è fermarsi sulla soglia. La vera sfida è indagare l’intreccio tra le rappresentazioni culturali e le realtà fisiche a cui si riferiscono. In una battuta: l’ecocritica legge il testo nel mondo e il mondo come testo. Significa scoprire che le trame non stanno solo nei libri, ma anche nella realtà – trame di materia e discorsi, spesso invisibili. Non è un esercizio confinato alla letteratura, ma una palestra per il pensiero.
L’ecocritica ci porta a vedere l’ambiente anche quando non lo vediamo. Anzi, soprattutto quando non lo vediamo – o non lo vediamo più. Adesso, per esempio. Prima del Covid non si parlava che di ecologia. Poi di colpo l’abbiamo rimossa. Al suo posto sono arrivate le guerre, l’intelligenza artificiale, la post-democrazia. Ma che cosa sono queste, se non emergenze ambientali? Lo è la guerra, con le sue distruzioni di vite e paesaggi, i suoi inquinamenti ed ecocidi (il termine, ricordiamolo, fu coniato durante il conflitto in Vietnam per denunciare gli effetti dell’Agente Orange). Lo è l’intelligenza artificiale, che oltre ai costi energetici e minerari apre scenari geopolitici e biopolitici (pensiamo al suo uso militare), e ci costringe a interrogarci sul significato stesso dell’umano. Quanto ai regimi post-democratici, è evidente che i loro progetti di gestione dei territori, delle risorse e delle migrazioni impattano non solo sulla vita delle persone, ma di interi ecosistemi.
Anche a questo serve l’ecocritica: a illuminare quello che l’attualità e l’agenda politica confinano nell’ombra. Perché comprendere il sottotesto ecologico nella letteratura ci insegna a farlo con la realtà; e sono importanti, la letteratura e la realtà. Basta riuscire a metterle insieme: era questa la scommessa di Cheryll Glotfelty e di quei professori riuniti nel casinò di Reno.
A proposito: Glotfelty. Evidentemente, non ha cambiato mestiere. È stata la prima docente al mondo di letteratura e ambiente. Oggi, in pensione, si dedica allo slacklining. Sospesa nel vuoto, cammina su un filo tra le montagne, collegando picchi come faceva con le discipline. Quando si dice una vita spericolata.
Articolo apparso nella rubrica "Letture", su Robinson, supplemento culturale di Repubblica, il 14 settembre 2025
Immagine: Alan Wouda (Unsplash)