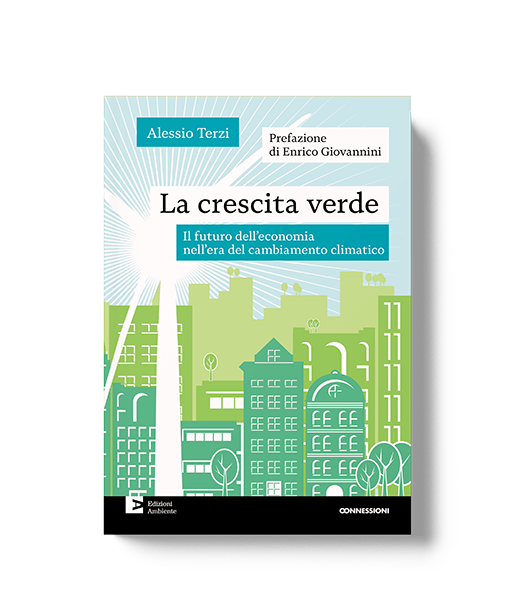
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
2. La crescita e la meccanica del capitalismo
1. Genesi 26, 12-13: “Isacco fece una semina in quella terra e raccolse quell’anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto. E l’uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a divenire ricchissimo”.
2. Isaia 60:5.
3. È importante notare che il Pil è un sistema di misurazione che risponde a una serie di convenzioni statistiche, progettata per misurare e quindi rendere operativo il concetto più astratto di reddito nazionale. Per saperne di più, si vedano Coyle (2014) e Terzi (2021, “Economic Policy-Making beyond GDP”).
4. Notoriamente, e forse più formalmente, Lionel Robbins definì l’economia come “la scienza che studia il comportamento umano come relazione tra fini e mezzi scarsi che hanno usi alternativi” (Robbins 1932, p. 15).
5. Si noti che, in condizioni particolari, l’aria che respiriamo acquista valore monetario soprattutto dove è più scarsa, cioè sott’acqua. Le bombole di ossigeno per le immersioni subacquee hanno un prezzo e anche la loro produzione contribuisce alla crescita economica.
6. Coyle (2019).
7. I calcoli del Pil si basano su un’ampia serie di presupposti. Si noti, per esempio, che oltre ai servizi digitali gratuiti, anche quelli forniti dal settore pubblico, come la difesa e l’istruzione, non hanno prezzi di mercato espliciti; è necessario fare delle ipotesi per stimare indirettamente il loro valore. Lo standard internazionale per la misurazione del Pil è contenuto nel System of National Accounts, SNA – Sistema di contabilità nazionale, (1993), redatto da Fondo monetario internazionale, Commissione Europea, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Nazioni Unite e Banca Mondiale. Il prossimo aggiornamento del SNA è previsto per il 2025 e si concentrerà sul miglioramento delle modalità di contabilizzazione dei dati e sull’inserimento del capitale naturale (ovvero il valore dei cosiddetti servizi ecosistemici, cioè le funzioni svolte dai processi naturali a beneficio dell’economia).
8. Wiedmann, et al. (2020).
9. Sebbene abbia suscitato un ampio dibattito la questione se il capitalismo abbia un intrinseco “imperativo di crescita”, i contributi alla letteratura provengono principalmente da studiosi delle scienze sociali marxisti e post-keynesiani. Si vedano, per esempio, Binswanger (2009), Gordon e Rosenthal (2003), Klitgaard e Krall (2012), Fotopoulos (2010), Richters e Siemoneit (2017), Jackson e Victor (2015).
10. Nelle parole dell’economista della decrescita Herman Daly, “Il mercato, ovviamente, funziona solo all’interno del sottosistema economico, dove fa una cosa sola: risolve il problema dell’allocazione fornendo le informazioni e gli incentivi necessari. E lo fa molto bene" (citato da Klitgaard e Krall, 2012).
11. Per approfondire il potenziale scontro tra la post-crescita e l’economia politica delle istituzioni dello stato sociale, si veda Bailey (2015).
12. Questo punto è riconosciuto anche da Serge Latouche (2009, p. 16): “I posti di lavoro, le pensioni e l’aumento della spesa pubblica (istruzione, ordine pubblico, giustizia, cultura, trasporti, sanità ecc.) presuppongono tutti un aumento costante del Prodotto interno lordo".
13. Il sociologo catastrofista Wolfgang Streeck (2016) osserva che, nel periodo della forte crescita degli anni Sessanta, i governi hanno fatto enormi promesse di sicurezza sociale al grande pubblico. Ora che i Baby Boomers vanno in pensione, queste promesse sono una bomba a orologeria per il capitalismo stesso, poiché gli impegni presi risulteranno insostenibili.
14. In tutti i paesi dell’Ocse, dal 2007 al 2017, le uniche due voci di spesa pubblica a espandersi (in percentuale del Pil) sono state la sanità (con un aumento dell’1,1%) e la protezione sociale (con un incremento dell’1,5%). Tutte le altre voci, comprese difesa, cultura e istruzione, sono rimaste stabili o sono diminuite (Ocse, 2019, p. 71).
15. Questo è il motivo per cui generalmente si esprime il debito pubblico come quota del Pil, per dare agli investitori un’idea approssimativa della dimensione del bacino potenziale da cui lo stato, attraverso la tassazione, può trarre le risorse per ripagare i propri creditori.
16. Per un approfondimento su questo tema, si veda Terzi (2020, “Macroeconomic Adjustment in the Euro Area”).
17. Si veda, per esempio, Easterly e Fischer (2001).
18. Si può tracciare un interessante parallelo con l’attuale differenza nell’accesso ai mercati finanziari tra i paesi avanzati e quelli in via di sviluppo. Concentrandosi sull’America Latina, Gavin, et al. (1996) dimostrano che i mercati emergenti non sono molto in grado di regolare il ciclo economico, in quanto perdono immediatamente credibilità nel momento del bisogno, ovvero durante una recessione. Questo a sua volta si traduce in una maggiore esposizione agli shock macroeconomici, un’elevata volatilità che, come è stato dimostrato, mina le possibilità di studio, danneggia la distribuzione del reddito e in particolare i poveri (Gavin e Hausmann, 1998).
19. Ball, Leigh e Loungani (2020).
20. Raghuram Rajan, governatore della Reserve Bank of India, “Going Bust for Growth”, discorso all’Economic Club di New York, 19 maggio 2015, https://www.bis.org/review/r150526g.pdf
21. Kelton (2020).
22. Boushey (2019).
23. Bailey (2015).
24. In pratica è molto difficile separare gli aumenti di capitale dall’innovazione. Per esempio, acquistare nuovi macchinari e quindi modificare i processi di produzione comporta di fatto entrambe le azioni: aumento di capitale e innovazione.
25. Schumpeter (1942, cap. 3).
26. Marx (1867, vol. 3, cap. 24, par. 3)
27. Si noti che i salari elevati possono essere corrisposti non solo in denaro, ma anche prevedere una serie di importanti benefit: accesso alla formazione, un ambiente d’ufficio confortevole, un asilo nido per i figli, una buona mensa, palestre e luoghi per il benessere e così via. Tutti questi elementi aiutano le aziende a posizionarsi in cima alle classifiche dei migliori datori di lavoro, attirando i migliori talenti.
28. Hall e Soskice (2001).
29. In generale, i principali modelli economici neoclassici sono orientati all’analisi del processo di crescita – in particolare dagli anni Cinquanta, grazie alla disponibilità di dati – ma mostrano uno scarso interesse verso le origini degli impulsi alla crescita. Per quanto riguarda gli elementi trainanti fondamentali della crescita, che si tratti di investimenti in infrastrutture, innovazione (produttività totale dei fattori), tasso di risparmio o capitale umano, la conclusione sintetica è stata che, se una variabile si azzera, la crescita si esaurisce, e nel modello non c’è nulla di intrinseco che imponga di continuare a crescere. Tuttavia, empiricamente, la regolarità è chiara: a partire dalla rivoluzione industriale, l’Occidente ha conosciuto la crescita, occasionalmente interrotta da recessioni. Non ci sono stati lunghi periodi di crescita piatta e questo richiede una spiegazione. Se, come suggerisce Solow, è solo una questione di preferenze (comprese le scelte intertemporali di consumo e investimento), allora tali preferenze dovrebbero essere esaminate più da vicino. Solow, citato in Steven Stoll, “Fear of Fallowing: The Specter of a No-Growth World”, Harper’s Magazine, marzo 2008, 92; Richters e Siemoneit (2017, “Fear of Stagnation?”).
30. Questa espressione è presa in prestito da Ferguson (2011).
31. Adam Smith non si rese conto, quando scrisse The Wealth of Nations (1776), che l’innovazione stava per diventare l’elemento centrale della crescita economica. Si noti che l’incipit del suo libro descrive una fabbrica di spilli, e non un cotonificio, anche se le prime macchine a vapore vennero applicate alla filatura proprio in quel periodo.
32. Ciò può includere una migliore protezione della proprietà privata, l’applicazione dei contratti o l’accesso ai finanziamenti, tutti elementi che consentono al meccanismo dei prezzi di funzionare senza problemi. Naturalmente, la realtà potrebbe non essere così netta e potrebbero esserci alcuni punti di contatto tra i due modelli di crescita. Gli assi portanti della crescita smithiana sostengono anche il progresso tecnologico. Allo stesso tempo, Mokyr (2016) mostra che questi elementi non hanno fatto sì che l’Europa si distinguesse rispetto ad altre aree del mondo, come la Cina, prima della rivoluzione industriale.
33. Questo può essere visto come “l’approccio allo studio della natura attraverso un’attenta misurazione, una formulazione precisa, esperimenti ben progettati, test empirici, utilizzo di formule matematiche e, soprattutto, la convinzione che tali attività fossero virtuose, rispettabili e potessero portare a una ricompensa economica e sociale”, Mokyr (2016, p. 223).
34. Come scrive Joel Mokyr (2016, p. 319), “Le vacche sacre dell’intelletto venivano sempre più spesso condotte al macello dell’evidenza”. Si veda anche Strevens (2020, p. 242).
35. Nelle parole di Mokyr (2016, p. 248): “La fede nel progresso [...] era un segno distintivo dell’Europa illuminista, e forniva lubrificazione culturale alla macchina che creava innovazione”.
36. Jones (2005, p. 1065), spiegando la distinzione di Paul Romer tra oggetti e idee, osserva che “a un certo livello, le idee sono istruzioni per disporre gli atomi e per utilizzare queste disposizioni per produrre utilità”.
37. Max Weber (1917, p. 10) ha osservato che “ogni ‘realizzazione’ scientifica dà vita a nuove ‘domande’ e chiede di essere superata e resa obsoleta [...] In linea di principio, questo progresso è infinito”. È un punto che Julian Simon amava sottolineare nei propri dibattiti con la prima ondata di sostenitori della decrescita, come Paul Ehrlich.
38. Per riprendere un’osservazione di Daniel Cohen (2018), crescita e innovazione tecnologica sono le due facce della stessa medaglia.
39. Vale la pena notare che circa il 70% della spesa per l’innovazione viene attualmente effettuata dalle aziende sia negli Stati Uniti sia in Europa, rispondendo quindi in larga misura ai meccanismi di mercato. Solo negli anni Ottanta, al culmine della Guerra fredda, gli investimenti del governo statunitense si sono avvicinati a quelli del settore privato.
40. La loro influenza si manifesta nelle parole del filosofo ottocentesco Auguste Comte: “Ogni progresso umano, politico, morale o intellettuale, è inseparabile dal progresso materiale” (Comte, 1896, p. 266).
41. Insieme al concetto di progresso, le idee sul potere politico come contratto sociale, i limiti formali al potere esecutivo, la libertà di espressione, la tolleranza religiosa, i basilari diritti legali umani e la sacralità dei diritti di proprietà sono stati cristallizzati durante l’Illuminismo e, in varia misura, rimangono il fondamento della cultura occidentale. Questi hanno a loro volta portato alla codifica e alla formalizzazione delle istituzioni che hanno supportato lo slancio tecnologico (Mokyr 2016, p. 315).
42. Mokyr (2016, p. 19).
43. Secondo le parole di Rousseau, dopo lo sviluppo dell’agricoltura, “l’uguaglianza è scomparsa, è stata introdotta la proprietà, il lavoro è diventato indispensabile, e vaste foreste si sono trasformate in campi ridenti, che l’uomo ha dovuto innaffiare con il sudore della fronte, e dove la schiavitù e la miseria sono presto state viste germogliare e crescere con i raccolti” (Friedman 2005, p. 30). Si noti l’impressionante parallelismo con molti degli odierni studiosi simpatizzanti della decrescita, come Suzman (2020) e Bregman (2020). All’epoca, il filosofo francese Voltaire ribatté alle idee di Rousseau, osservando che se gli esseri umani si fossero accontentati di soddisfare i soli bisogni, non avrebbero mai compiuto alcun progresso sociale, materiale o artistico (Voltaire, 1764). Desiderare, produrre e godere di bisogni non fondamentali (cioè i lussi) accompagna naturalmente il progresso, come causa e come effetto (Westacott, 2016, p. 146-147).
44. Friedman (2005, p. 54).
45. Dickens (1854).
46. Hansen (1932). Ciò presenta alcuni parallelismi con l’argomentazione di Bob Gordon (2016). Allo stesso modo, è stato Hansen (1938) a parlare per la prima volta di “stagnazione secolare”, un concetto resuscitato da Larry Summers all’indomani della Grande recessione. La teoria secondo cui un’economia in crescita finisce per raggiungere uno stato stazionario è stata recentemente riproposta (e celebrata come un segno di successo) da Vollrath (2020).
47. Si veda, per esempio, come Ripple, et al. (2017, p. 1026), nel loro “monito all’umanità”, inseriscano con disinvoltura la necessità di “rivalutare il ruolo di un’economia radicata nella crescita” in un elenco di misure urgenti che include anche imperativi per incentivare le energie rinnovabili, ridurre l’inquinamento e così via. Allo stesso modo, il biologo marino Enric Sala (2020) si schiera duramente contro il Pil e la crescita economica, ma dà l’impressione di non essersi soffermato a considerare tutte le implicazioni del rifiuto della crescita.
48. Klein (1972) lo dice più chiaramente: “Parlare di puntare a un equilibrio economico senza discuterne le implicazioni politiche e sociali significa indulgere in una retorica senza senso”.
49. Si vedano, per esempio, Newell e Paterson (2011, 2010); Pollin (2019, 2018); Mann (2019).