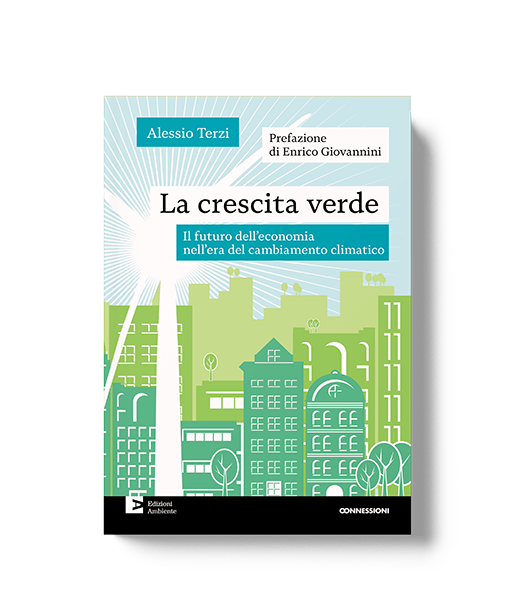
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
4. Il campanello d’allarme di un’Italia senza crescita
1. La maggior parte delle informazioni contenute in questo paragrafo sono tratte dal Better Life Index dell’Ocse, utilizzando i dati pubblicati nel luglio 2021: https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/italy/
2. Una statistica nota alla maggior parte degli italiani, perché viene citata in ogni occasione possibile, è che il paese ospita il maggior numero di siti UNESCO al mondo.
3. Secondo la Convention on Biological Diversity (Convenzione sulla diversità biologica), l’Italia ha il più alto numero e la più alta densità di specie animali e vegetali all’interno dell’Unione Europea, nonché un alto tasso di endemismo. I dettagli sono disponibili su https://www.cbd.int/countries/profile/?country=it
4. La classifica dell’influenza culturale è un derivato della classifica annuale “Best Countries” di US News and World Report, che utilizza una metodologia di indagine sviluppata da BAV Group e David Reibstein della Wharton School dell’Università della Pennsylvania. L’Italia ottiene sempre i punteggi più alti in questa sottoclassifica, compreso un primo posto nel 2021. Per quanto riguarda il soft power, si veda per esempio Jonathan McClory, “The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power”, Portland Communications, 2015, https://portland-communications.com/pdf/The-Soft-Power_30.pdf
5. Per una spiegazione del modo in cui l’economia e la politica italiana si siano sempre più distaccate dal resto dell’Europa, si veda Merler (2020).
6. L’Italia non ha sperimentato, in senso stretto, una recessione acuta o prolungata come quella che ha colpito l’Argentina nei primi anni Duemila o la Grecia durante la crisi dell’eurozona. L’economia italiana è stata, invece, incredibilmente stagnante per un lungo periodo di tempo. Ciò è in contraddizione con chi, come Binswanger (2009), sostiene che il capitalismo sia sostenibile solo con tassi di crescita medi sul lungo termine almeno del 3%.
7. Molti studi avallano questa tesi. Particolarmente utili sono Pellegrino e Zingales (2017) e Calligaris, et al. (2016). I lettori più appassionati al tema possono anche consultare Terzi (2016) su contrattazione salariale, eterogeneità regionale e produttività.
8. Per approfondire, si veda Terzi, “The Great Fiscal Lever: An Italian Economic Obsession”, Bruegel Blog, 21 agosto 2018, https://www.bruegel.org/2018/08/the-great-fiscal-lever-an-italian-economic-obsession/
9. È difficile dire se si tratti di una caratteristica particolare italiana o di un’indole umana ampiamente condivisa, ma l’impulso a cercare colpevoli esterni è stato frequente, e questa ricerca di capri espiatori ha impedito agli italiani di identificare correttamente l’origine sistemica delle vulnerabilità del paese e le soluzioni giuste per rimettersi in piedi.
10. Sullo scarso rendimento degli investimenti pubblici in Italia, si veda De Jong, et al. (2017) e Fiorino, et al. (2012). Considerazioni simili si applicheranno alla nuova Recovery and Resilience Facility istituita a livello europeo per dare il via alla ripresa post-COVID nei vari stati membri dell’UE. Questo strumento può rivelarsi un moderno Piano Marshall, se i fondi vengono utilizzati per scopi produttivi e promuovono le riforme tanto necessarie, oppure un’altra fiammata a breve termine, alimentata dagli investimenti pubblici, che si aggiunge al debito a lungo termine (nazionale ed europeo).
11. A. Terzi, “Clouds Are Forming over Italy’s Elections”, Bruegel Blog, 28 febbraio 2018, https://www.bruegel.org/2018/02/clouds-are-forming-over-italys-elections/
12. L’Italia è uno dei paesi più pessimisti sul futuro. Solo il 19% degli italiani crede che i propri figli staranno meglio in futuro, una percentuale molto più bassa rispetto ai mercati emergenti, ma anche sorprendentemente bassa rispetto agli standard delle economie avanzate (dove la mediana era del 34%). Bruce Stokes, “Expectations for the Future”, parte del Pew Report “A Decade after the Financial Crisis”, 18 settembre 2018, https://www.pewresearch.org/global/2018/09/18/expectations-for-the-future/
13. Il saldo primario è il saldo di bilancio al netto del pagamento degli interessi. Dal 1995 al 2019, l’Italia ha registrato il più grande avanzo primario medio al mondo.
14. Eichengreen e Panizza (2014).
15. Tra i paesi ricchi, l’Italia ha il più alto rapporto tra ricchezza privata netta e reddito nazionale netto. Fissato al 250% nel 1970, ha superato il 700% nel 2015. World Inequality Database, “Income Inequality, Italy, 1980-2019” https://wid.world/country/italy/
16. Il 10 luglio 1992, il governo guidato da Giuliano Amato introdusse nottetempo un’imposta patrimoniale sui depositi in conto corrente per riequilibrare i conti pubblici e garantire il successo della candidatura dell’Italia all’euro. Sebbene l’imposta avesse un’aliquota del 6‰, e siano passati oltre 30 anni, questo episodio rimane un ricordo orribile per la maggior parte degli italiani, allontanando perciò ogni tentativo di discutere nuove imposte patrimoniali e minando la percezione che i depositi bancari siano sicuri.
17. Dati per il 2019 della banca dati dell’Ocse basati sulla retribuzione media dei dipendenti.
18. Dati da PayScale, https://www.payscale.com/research/IT/Job=Mechanical_Engineer/Salary
19. L’alto grado di frammentazione e l’instabilità dei governi sono un dato permanente della politica italiana. Dal 1945, il paese ha avuto 68 governi diversi. Sicuramente gioca un ruolo il fatto che i poteri esecutivi siano così deboli, una limitazione voluta dai redattori della Costituzione dopo il fascismo e la Seconda guerra mondiale.
20. Per una discussione più approfondita delle dinamiche della trappola dei cattivi lavori e delle basse qualifiche, si veda Snower (1994).
21. Questo punto viene sottolineato da Milanovic (2019, p. 186), che cita Firenze e Venezia come luoghi in cui le popolazioni autoctone vengono rimpiazzate da ricchi di altre nazionalità.
22. Naturalmente, questo dato lascia i giovani italiani esposti a facili battute da parte di chi li definirebbe “mammoni” che non hanno fretta di cavarsela da soli, una tentazione anche per ministri delle Finanze di alto livello intellettuale. Nel 2007, Tommaso Padoa-Schioppa ha descritto una proposta di sgravio fiscale per gli affittuari come rivolta ai “bamboccioni” che avevano bisogno di un incentivo extra per uscire di casa. Anche se forse c’è una componente culturale, la tendenza suggerisce che esistono diversi motivi. Secondo l’Istat, l’Istituto nazionale di statistica italiano, nel 1983, tra gli adulti di età compresa tra i 18 e i 34 anni, il 49% era single e viveva ancora in famiglia; nel 2000 questa quota raggiungeva il 60,2% e nel 2020 il 65%. Nel 2016, tra i giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni, il 43,6% ha indicato una di queste tre ragioni per cui vive con i genitori: l’essere studente, la difficoltà di trovare un lavoro adeguato e la scarsa possibilità di far fronte ai costi dell’alloggio. La quota di coloro che percepiscono la vita con i genitori come una situazione comoda e piacevole si è quasi dimezzata, dal 17,4% nel 2009 al 9,9% nel 2016; questa motivazione è passata dal primo al quarto posto (Istat, 2019, cap. 3).
23. L’emigrazione dall’Italia sta prosciugando il talento imprenditoriale (Anelli, et al., 2020).
24. Una dinamica simile si è verificata a Londra rispetto al resto del Regno Unito e, direttamente o indirettamente, è probabile che abbia influenzato molti voti nel referendum sulla Brexit del 2016. Si veda Terzi, “How to Make the Single Market More Inclusive after Brexit”, Bruegel Blog, 18 agosto 2016, https://www.bruegel.org/2016/08/how-to-make-the-single-market-more-inclusive-in-the-aftermath-of-brexit/
25. Questo effetto potrebbe aumentare nei prossimi anni grazie ai progressi della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni, con i servizi sempre più esposti alla delocalizzazione, come sostenuto da Baldwin (2019).
26. Il “reddito di cittadinanza” italiano non è un vero e proprio reddito minimo universale, in primo luogo perché non viene distribuito a tutti ma solo a coloro che hanno un introito basso e, in secondo luogo, perché per poterlo ottenere i beneficiari devono documentare di essere alla ricerca attiva di un lavoro e di esserne esclusi. In quanto tale, si tratta di un programma di sussidi mirato ai disoccupati di lungo periodo. In alcune province del sud, tuttavia, dove l’economia informale è molto diffusa, il programma ha un livello di utilizzo talmente alto da avvicinarsi a un reddito minimo a tempo.
27. Poiché le donne scelgono o si sentono costrette a ritardare la gravidanza per motivi di instabilità economica, il rischio di infertilità involontaria aumenta e il tasso di fertilità della nazione diminuisce.
28. La spesa in ricerca e sviluppo effettuata da imprese, istituti di ricerca e laboratori universitari e governativi rappresenta l’1,4% del Pil in Italia, contro una media Ocse del 2,4%, è del 2,2% in Francia e del 3,2% in Germania. I dati Ocse sono disponibili su https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
29. Per approfondire l’argomento, si veda Terzi (2015).
30. Un’osservazione simile è stata fatta per quanto riguarda la politica verde: “Ciò che accade in Italia raramente rimane in Italia”, suggerendo che il recente spostamento verso un discorso di politica verde darà il tono ai dibattiti politici nazionali in Europa nei prossimi anni. Bergamaschi, “Italy’s Green Moment”, Politico Europe, 18 marzo 2021, https://www.politico.eu/article/italy-green-draghi-cop26/
31. A questo proposito, e in particolare come reazione ai sentimenti di superiorità del Nord, si assiste a un’affascinante rinascita dell’attaccamento al regno borbonico. Secondo i neoborbonici, il Sud è povero non per colpa propria, ma perché, con l’unificazione nazionale, il Nord gli ha sottratto tutte le risorse. Così, un eroe nazionale come Giuseppe Garibaldi viene trasformato in un nemico pubblico. L’ennesimo capro espiatorio, l’ennesima dinamica che incrina la società e la nazione.
32. È evidente che la diffusa evasione fiscale e la rilevante economia sommersa, entrambe circa il doppio della media europea, contribuiscono a minare le fondamenta dello stato e del contratto sociale.
33. Directorate-General for Communication (2019). Un’altra indagine con risultati simili è stata condotta nel 2013 dall’Istituto Affari Internazionali, che conclude: “Gli italiani prestano attenzione alla politica estera, ma le questioni globali occupano una posizione subordinata nella scala delle loro priorità. Le questioni diventano rilevanti per loro solo quando toccano direttamente gli interessi del paese, come nel caso dell’immigrazione e della sicurezza delle frontiere. Gli italiani vedono inoltre il proprio paese come un attore debole nell’arena internazionale" (CIRCaP/LAPS e IAI 2013, 4). I dati di marzo-aprile 2021 confermano che gli italiani sono tra i meno interessati agli affari esteri in un gruppo di undici paesi Ocse (GMF e Bertelsmann 2021).
<34. Terzi, “Italian Populism Calls for Hard Choices”, Bruegel Blog, 31 maggio 2018, https://www.bruegel.org/2018/05/italian-populism-calls-for-hard-choices/
35. Chiari esempi ne sono l’accesso all’acqua e l’efficienza idrica. L’infrastruttura idrica italiana è vecchia e necessita di aggiornamenti urgenti. Le perdite ammontano al 30-40% dell’acqua prelevata, con punte anche del 50% in alcune regioni. Se a questo si aggiungono i probabili effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici, come la siccità e la potenziale desertificazione in alcune aree del paese, è chiaro che la mancanza di accesso all’acqua potabile è un disastro in agguato. Tuttavia, dati gli ingenti investimenti necessari per riparare la rete attuale, altri problemi più a breve termine hanno sempre la priorità.
36. Uno di questi esempi riguarda i terremoti. L’Italia si trova purtroppo su una faglia importante, che la espone a frequenti sismi, a volte di grande magnitudo. In Giappone, esposto in modo analogo, le morti e i danni associati a terremoti di magnitudo simile sono molto minori. Ciò che fa la differenza sono i notevoli investimenti fatti dal Giappone nell’ingegneria antisismica. Per esempio, un terremoto di magnitudo 6,2 e una certa profondità dell’epicentro a Kurayoshi (Giappone), nel 2016, ha causato il crollo di alcuni edifici e il ferimento di sette persone, ma non ci sono stati morti. Un terremoto molto simile, avvenuto nel 2009 all’Aquila (Italia), ha causato la perdita di 80.000 abitazioni e il ferimento di 1.600 persone. Cosa ancora più grave, il sisma ha causato la morte di 309 persone.
37. I riferimenti alla decrescita sono apparsi nel programma elettorale del Movimento Cinque Stelle già nel 2013.
38. L’esperimento è anche il titolo di un libro acuto (e molto critico) di Iacoboni (2018).
39. Per esempio, “Se la decrescita felice diventasse un obiettivo nazionale, come potremmo sapere se stiamo andando bene? Potremmo chiederci anche perché alcuni paesi, come il Giappone o Cuba, hanno mantenuto il benessere pur non (o de)crescendo” (Kallis, et al., 2012, 175). Si veda anche Büchs e Koch (2019).
40. Nell’indice di efficacia dei governi stilato dalla Banca Mondiale, che combina misurazioni della qualità dei servizi statali, della funzione pubblica, della formulazione e dell’attuazione delle politiche, e della credibilità dell’impegno del governo a migliorare queste qualità o a mantenerle elevate, il Giappone si è classificato al 15° posto nel mondo nel 2019. Per una trattazione approfondita del famoso alto grado di coesione sociale del paese (anche se da una prospettiva critica), si veda Hirata e Warschauer (2014).
41. Recenti testimonianze aneddotiche suggeriscono tuttavia che, operando in un contesto di minore crescita, i giovani giapponesi sono diventati fortemente avversi al rischio, pessimisti sul futuro e inclini ad aggrapparsi a ciò che hanno. Questa dinamica è condivisa con l’Italia. Lewis, “Japanese Youth Search for Stability in a World without Growth”, Financial Times, 27 novembre 2020, https://www.ft.com/content/e5b9e75a-a8b8-4899-a0e4-4aea19d97ff6