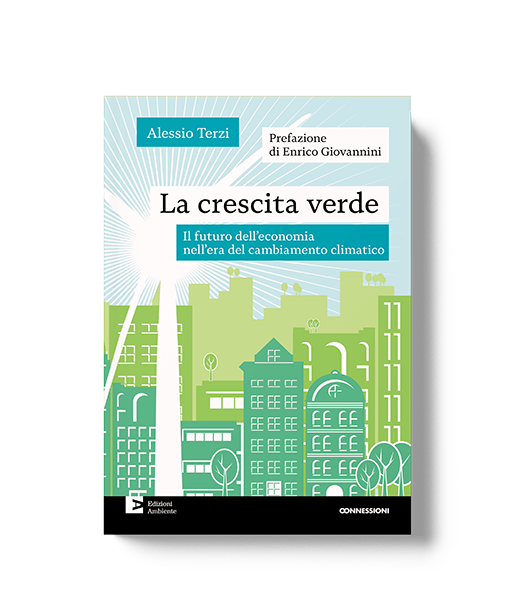
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
6. Capire i venti del cambiamento
1. Rifkin (2019).
2. Nordhaus (2021).
3. Robert Solow ha notoriamente osservato che: “L’era del computer si vede ovunque, tranne che nelle statistiche sulla produttività”. Solow, “We’d Better Watch Out”, New York Times Book Review, 12 luglio 1987. A distanza di quasi quattro decenni, la sua osservazione sembra tutt’ora attuale.
4. Ogni tecnologia richiede tempo per diffondersi, ma i big data e l’Ia sono particolarmente difficili da applicare ai processi aziendali creati per l’economia analogica (si vedano Coyle, 2014, p. 84; Brynjolfsson e Hitt, 2000). Di conseguenza, la tecnologia si diffonde lentamente e vediamo che pochi leader dell’innovazione si distanziano dai molti ritardatari, con uno scarso effetto complessivo sulla produttività aggregata (si vedano anche Andrews, et al., 2019; Aghion, et al., 2021, p. 118-123).
5. Diamandis e Kotler (2012).
6. L’energia eolica risale almeno al 5000 a.C. e alle prime imbarcazioni a vela sul fiume Nilo. Si veda anche Tagliapietra (2020, Global Energy Fundamentals).
7. Nel linguaggio della biologia evolutiva e dell’evoluzione culturale, la trasmissione della conoscenza avviene in tre modi: verticale, dai genitori ai figli (o dalle società ancestrali alle società attuali); orizzontale, tra individui della stessa generazione (o tra società contemporanee); obliqua, da parte di individui non genitori nella generazione dei genitori (o da società passate non ancestrali). Si veda Gould (2011) o Christakis (2019, p. 367). In quello che è forse l’esempio storico su più vasta scala di trasmissione culturale orizzontale/obliqua, la Restaurazione Meji del Giappone fu caratterizzata da una forte imitazione di ciò che era considerato il meglio dell’Occidente. Dalla Francia arrivarono il sistema educativo e il codice giuridico; dalla Prussia la struttura dell’esercito e la costituzione (il modello americano era considerato troppo liberale); dagli inglesi la marina e dagli Stati Uniti la regolamentazione commerciale.
8. La prova della superiorità tecnologica delle armi da fuoco occidentali può essere dedotta dalla preferenza degli asiatici del Sud-Est per l’acquisto di armi occidentali (Sharman, 2019, p. 74). Hoffman (2015, p. 13) lo conferma e nota che gli esperti europei di armi da fuoco erano così richiesti in Medio Oriente e in Asia che “nella Cina del XVII secolo, persino i missionari gesuiti furono costretti a prestare servizio per aiutare l’imperatore cinese a produrre cannoni migliori”.
9. Il capitalismo può essere considerato una di queste idee, come descritto nella sua irresistibile diffusione globale da Milanovic (2019) e, adattato al contesto locale, come spesso discusso da Dani Rodrik a proposito delle “tigri” asiatiche o del miracolo della crescita cinese (Rodrik, 2009). Si veda Mokyr (2016, p. 22-33) sui principi evolutivi biologici applicati ai processi di accrescimento culturale. Si veda anche Cavalli-Sforza e Feldman (1981) per un lavoro pionieristico sull’argomento.
10. Questo vale anche per l’elaborazione delle politiche. Come ho sentito dire una volta: Le cattive politiche di oggi sono in genere decisioni efficaci del passato che non sono state adattate ai tempi. Ecco perché non c’è fine al policymaking, che è proprio il costante adeguamento di leggi e pratiche alle esigenze attuali e a una realtà che cambia.
11. Un’altra ragione dell’importanza dell’ammoniaca nel periodo che precede la Prima guerra mondiale è il crescente interesse per la produzione di esplosivi su vasta scala.
12. Sul lavoro manuale a Sulawesi 45.000 anni fa come frutto di membri della nostra specie “moderni” dal punto di vista cognitivo, si veda Brumm, et al. (2021). Per un’argomentazione più generale, si veda Gould (2011).
13. Data la crescente nostalgia verso un passato spesso idealizzato, dalle abitudini alimentari alle cure mediche, vale la pena sottolineare che è improbabile che sia vero anche il contrario. Lungi dal proclamare che la modernità è sempre migliore di ciò che l’ha preceduta, vale la pena riflettere ogni volta sul motivo per cui una determinata innovazione è nata e si è diffusa. Nella maggior parte dei casi, si trattava di risolvere un problema specifico creato dalla pratica precedente.
14. Per una panoramica sulla diffusione tecnologica, si veda Hall (2006). Sulla lenta diffusione della filatura meccanizzata in Francia, si veda Juhász, et al. (2020). In questo caso è importante sapere che la diffusione è stata lenta fino all’avvento dei cotonifici e all’organizzazione dei processi di filatura e tessitura su vasta scala. La transizione ecologica dovrà affrontare delle sfide, ma almeno farà leva su strutture produttive sviluppate precedentemente.
15. Per saperne di più sulle basi evolutive del tasso di sconto iperbolico si veda, per esempio, Gowdy, et al. (2013).
16. Nel linguaggio dell’economia, tutte queste caratteristiche sono utili in quanto consentono al capitalismo di ridurre l’“allocazione inefficiente” delle risorse, avvicinando l’economia alla frontiera delle proprie possibilità. Ciò include anche una migliore distribuzione dei talenti (Jones, 2016). Gli economisti interessati alla macroeconomia, alla politica pubblica e alla crescita a lungo termine dedicano gran parte del proprio tempo a migliorare questi meccanismi di allocazione ottimale delle risorse, che spesso rientrano nel termine “riforme strutturali”. Per un approfondimento, si veda Terzi e Marrazzo (2020).
17. Quando gli obiettivi di produzione erano solo quantitativi, che è ciò che poteva realisticamente essere monitorato attraverso la pianificazione centralizzata, il risultato era che non importava più che le scarpe fossero durevoli, comode o anche della misura giusta per la maggior parte di chi le indossava, né che i televisori funzionassero ancora dopo qualche mese. Più in generale, la pianificazione centralizzata lasciava poco spazio ad aggiustamenti rapidi in caso di errori di valutazione o di fattori esterni al di fuori del controllo dello stato, per non parlare del tinkering e del costante learning-by-doing. Quando un fornitore compiva degli errori, gli altri seguivano a ruota (Coyle, 2014, p. 69). In un grande classico, Fukuyama (1992) ha espresso considerazioni simili sull’impossibilità della pianificazione centrale sovietica di gestire la grande quantità di informazioni necessarie per l’innovazione.
18. Questo è vero anche se, come meccanismo allocativo relativamente efficiente, un sistema capitalistico aumenta le possibilità che i geni finiscano in posizioni che consentono loro di esprimere il proprio talento. Per una discussione sulla cattiva allocazione dei geni nei paesi in via di sviluppo, si veda Agarwal e Gaule (2020). Al di là del capitalismo, la discriminazione rappresenta una sfida per questo meccanismo, come sostenuto tra l’altro da Jones (2016).
19. Basandosi su una vasta letteratura sulla crescita a lungo termine, Jones (1999, p. 41) suggerisce che “L’ascesa e il declino di istituzioni come i diritti di proprietà potrebbero essere responsabili del successo e del regresso delle grandi civiltà del passato”. Certamente, nel corso della storia i cambiamenti nei diritti di proprietà sono stati un fattore decisivo fondamentale della crescita economica. La rivoluzione industriale non fa eccezione.
20. Ciò potrebbe essere particolarmente importante in quanto è dimostrato che le nuove idee sono sempre più difficili da trovare, il che significa che il progresso tecnologico ed economico può essere sostenuto solo attraverso un maggiore impegno nella ricerca. Si veda Bloom, et al. (2020).
21. I primi paesi per spesa in R&S, in percentuale del Pil, sono questi dieci: Israele, Corea del Sud, Giappone, Svezia, Finlandia, Taiwan, Austria, Danimarca, Svizzera e Germania. Nove di questi sono paesi Ocse, e tutti sono ad alto reddito.
22. Abbiamo visto in azione questo meccanismo nel 2020, con lo sviluppo di nuovi vaccini contro il virus COVID-19 a ritmo serrato, sostenuto da quasi 40 miliardi di dollari di investimenti pubblici, privati e di Ong. Quando il virus è diventato il problema a breve termine più urgente per l’umanità, le risorse sono confluite e i programmi di ricerca sono stati adattati per garantire questi finanziamenti.
23. Per quanto riguarda la politica industriale per la transizione ecologica, Rodrik (2014) sostiene che un fallimento occasionale è indicativo di una politica industriale di successo, a riprova del fatto che ci si assumono alcuni rischi che altrimenti non verrebbero finanziati.
24. Il capitalismo non esclude affatto un ampio coinvolgimento del settore pubblico, anche nella R&S. In genere, però, è minore rispetto a quello del settore privato, soprattutto nei paesi ricchi dell’Ocse (in media il 71% del totale nel 2018). Dal 1950 al 1980, il governo federale è stato il principale finanziatore della R&S negli Stati Uniti e circa la metà della spesa è stata destinata alla difesa. Questa situazione, tuttavia, poteva essere sostenuta politicamente solo nel contesto della Guerra fredda con l’Unione Sovietica. La spesa pubblica in R&S ha iniziato a ridursi dopo l’era lunare del programma spaziale. Si veda Jones (2016).
25. Si vedano, per esempio, Hickel (2020, Less is More, p. 198); Jackson (2009, p. 151, p. 166-168).
26. Questo è il processo che Dani Rodrik ha in mente quando parla di percorsi multipli di innovazione, con l’idea che la società, attraverso il governo, possa orientare il focus e la direzione dell’innovazione. Rodrik (2011); D. Rodrik, “Thecnology for All”, Project Syndicate, 6 marzo 2020, https://www.project-syndicate.org/commentary/shaping-technological-innovation-to-serve-society-by-dani-rodrik-2020-03
27. Il petrolio era noto e utilizzato già nell’antichità. Il bitume era ampiamente utilizzato dal 4000 a. C. per impermeabilizzare barche, bagni o vasellame. Nel Libro della Genesi (6:14-16), Dio ordina a Noè di costruire la famosa arca e di spalmarla di bitume. Il bitume era usato anche come legante da costruzione e lo storico greco Erodoto ne descrive l’uso nella costruzione delle possenti mura di Babilonia. Nel IX secolo, i chimici arabi e persiani distillavano già dal petrolio il cherosene per le lampade. Nell’Europa medievale, il petrolio veniva utilizzato per le sue presunte proprietà mediche.
28. La moderna lampada a cherosene, inventata nel 1854, ha creato la prima domanda su vasta scala di prodotti petroliferi. All’inizio il cherosene veniva ottenuto dal carbone, ma alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo la maggior parte era ricavata dal petrolio grezzo.
29. Morris (2013). Questo apre un interessante dibattito su quale sia il futuro della domanda di energia in un’economia planetaria in crescita. In base alla proiezione delle tendenze passate, si direbbe che le tecnologie future, alimentando la crescente complessità della società, continueranno a far aumentare la domanda di energia, soprattutto se si considera che non sembra che ci stiamo avvicinando ai limiti dell’offerta (si veda Fouquet, 2008). Il dibattito è comunque aperto, e diversi esperti di energia e clima hanno suggerito che la domanda di energia pro capite potrebbe benissimo raggiungere a un certo punto un plateau, come abbiamo visto nei paesi Ocse negli ultimi decenni. La domanda aggregata di energia è rimasta praticamente stabile nella media Ocse dal 2000 al 2016, nonostante un aumento del 32% del Pil (Tagliapietra, 2020, Global Energy Fundamentals, p. 170). Per approfondire questo punto di vista, si veda Smil (2017, p. 14). Nel complesso, la relazione tra crescita economica e domanda di energia sembra positiva, anche se non necessariamente lineare.
30. I sondaggi condotti in tutti i paesi per misurare le principali priorità politiche degli elettori mostrano che il cambiamento climatico è emerso solo di recente come risposta. Si veda, per esempio, Pew Research Center, “As Economic Concerns Recede, Environmental Protection Rises on the Public’s Policy Agenda”, 13 febbraio 2020, https://www.pewresearch.org/politics/2020/02/13/as-economic-concerns-recede-environmental-protection-rises-on-the-publics-policy-agenda/. In gran parte, ciò è dovuto al fatto che le emissioni di CO2 hanno un effetto ritardato, generando costi enormi ma solo nel lungo periodo. Sono anche un “male” pubblico globale, in quanto le mie emissioni non riguardano solo me ma pure gli altri intorno a me, anche in altri paesi. Gli economisti definiscono una situazione come questa un “fallimento del mercato”, perché i prezzi non possono trasmettere le informazioni necessarie per un’allocazione efficiente.
31. Per maggiori dettagli sul trattamento delle scoperte legate al clima da parte di Exxon, si veda Hasemyer e Cushman (2015).
32. Si veda Keynes (1936, p. 384). Ciò riecheggia il romanziere ottocentesco Victor Hugo, a cui si attribuisce la frase “Nulla è più potente di un’idea della quale è giunto ormai il momento”.
33. Per un’avvincente e approfondita narrazione del periodo in cui avvenne l’introduzione dell’automobile, si veda Standage (2021). Questa percezione dell’inquinamento atmosferico come fastidio minore rimase prevalente fino alla metà del XX secolo (McAfee, 2019, p. 55).
34. I divieti normativi veri e propri, come quello dell’UE sulla plastica monouso nel 2021, rimangono uno strumento a disposizione dei governi. Dovrebbero, però, essere mirati ai prodotti finali, per evitare le sfide legate alla comprensione e alla regolamentazione di processi produttivi complessi.
35. Come documentato dalla letteratura sull’economia dell’innovazione, la curva di adozione di nuovi prodotti e tecnologie assume una forma a S: inizia lentamente, poi accelera in modo esponenziale e infine si stabilizza quando il mercato è saturo (Hall, 2006). Il concetto di punto di svolta appare quindi rilevante.
36. Questo aspetto è discusso, tra gli altri, in SDSN (2019). In modo simile, Systemiq (2020) sostiene che è stato raggiunto un punto di svolta verde.
37. L’episodio della scommessa è tratto da Coyle (2014, p. 71-72). Jones (2016) analizza il prezzo di un paniere di materie prime industriali, composto da alluminio, carbone, rame, piombo, zinco e minerale di ferro, corretto per l’inflazione. Nel corso del XX secolo, la domanda mondiale di queste materie prime industriali è esplosa con l’avvento dell’automobile, dell’elettrificazione, dell’urbanizzazione e dell’industrializzazione in generale. Il prezzo reale di queste materie prime è tuttavia diminuito di quasi l’80% nel corso del XX secolo.
38. In senso astratto, il riciclo può essere visto come un modo per convertire l’energia in materiale, il che solleva una domanda: se il problema non è l’esaurimento dei materiali, allora possiamo esaurire l’energia? Anche questo sembra estremamente improbabile. A parte l’ovvio lavoro pionieristico sulla fusione nucleare, che per scopi pratici genererebbe una quantità illimitata di energia, anche solo guardando alla tecnologia attuale, il limite dell’offerta sembra molto lontano. Prendiamo in considerazione solo una delle fonti rinnovabili: un totale di 173.000 terawatt di energia solare colpisce continuamente la Terra. Si tratta di oltre 7.500 volte il consumo energetico totale del pianeta.
39. Si veda, per esempio, Quah (2019).
40. Nei paesi del G7, per esempio, l’area coperta da foreste è aumentata ogni anno tra il 2001 e il 2015. Per quanto riguarda l’Europa, nel 1990 il 28% della Spagna era coperto da foreste; nel 2020 la percentuale era del 37%. Nello stesso periodo, Grecia e Italia sono passate dal 26% al 32%. “State of Europe’s Forests 2020”, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf
41. Si noti che per la maggior parte della storia dell’umanità l’innovazione è avvenuta più che altro attraverso semplici prove ed errori o per scoperte casuali. Il salto di qualità nell’innovazione può essere comunque ricondotto a un approccio scientifico di tipo positivistico, ovvero alla consapevolezza che la natura è organizzata secondo alcune regole fondamentali e che bisogna sfruttarle, o piegarle, a proprio favore. Come afferma Mokyr (2016, p. 41), “Le invenzioni non sono per lo più eventi accidentali. La probabilità che un’invenzione si verifichi è legata alla base epistemica che la sostiene, cioè alla comprensione delle regolarità naturali e dei fenomeni che fanno funzionare la tecnica. Alcune invenzioni richiedono una conoscenza piuttosto approfondita della scienza che vi è sottesa: i reattori nucleari non sono costruiti per caso”. Questo più ampio principio è applicabile anche all’agricoltura. I nostri antenati hanno fatto aumentare la resa dei raccolti attraverso la selezione artificiale e gli incroci, attraverso un processo di prove ed errori durato millenni. Solo nel 1866, quando Gregor Mendel presentò le regole di base della trasmissione intergenerazionale dei caratteri, gettando le basi della genetica, si arrivò a programmi di selezione più efficaci.
42. Stephen Jay Gould osserva che la conoscenza umana è esplorativa e teleologica, per cui la conoscenza si accumula più velocemente e si trasmette più ampiamente di quanto non facciano i cambiamenti genetici nei processi evolutivi biologici. In termini evolutivi, l’accumulo di conoscenza segue un processo lamarckiano piuttosto che l’ereditarietà mendeliana. Gould afferma che il concetto di progresso e di miglioramento continuo o di aumento della complessità ha senso in un contesto culturale umano, ma non nell’evoluzione biologica. Si veda Gould (2011).
43. Il dibattito scientifico su questo tema infuria da tempo. Per alcuni, l’aumento della diversità e della complessità è un risultato necessario del processo di divergenza, che implica un progresso. Per altri, tra cui Stephen Jay Gould, questo è tutt’altro che necessario e dovrebbe essere addebitato a quello che lui chiama il cosiddetto “muro di sinistra”: l’idea che, partendo dalla vita unicellulare, ci si possa muovere solo in direzione di una maggiore complessità. Inoltre, Gould sostiene che siamo ingannati dal fatto di concentrarci sull’estremità più stretta della distribuzione della complessità (cioè noi esseri umani), ignorando in gran parte che gli organismi più comuni sul pianeta sono sempre stati, e sono tuttora, semplici batteri (Gould, 2011).
44. Romer (2016). Per una trattazione simile del problema, si veda Weitzman (1998, p. 359), il quale conclude che “I limiti ultimi alla crescita potrebbero risiedere non tanto nelle nostre capacità di generare nuove idee, quanto nelle nostre capacità di mettere a frutto un’abbondanza sempre maggiore di idee potenzialmente proficue”.
45. Questo concetto chiarisce la motivazione economica degli investimenti pubblici nella R&S. Poiché gli investitori del settore privato non tengono conto dei benefici più ampi che la società trae dalle invenzioni, le imprese capitalistiche investono meno di quanto sia socialmente ottimale.
46. Nelle candide parole del premio Nobel per la fisica Frank Wilczek: “Quando ero un adolescente e cercavo di comprendere la realtà, pensavo che la vita fosse una questione di trovare la risposta alle domande e basta. Ora sto imparando che le buone risposte portano a domande migliori e che il ciclo non finisce mai”. Citato in Claudia Dreifus, “A Prodigy Who Cracked Open the Cosmos”, Quanta Magazine, 12 gennaio 2021. Si veda anche Weber (1917).
47. Le conquiste tecnologiche dell’Europa medievale, come gli aratri pesanti, gli orologi meccanici, gli occhiali, la fusione del ferro, le armi da fuoco, la progettazione di navi e le attrezzature per la navigazione, erano di incredibile importanza (Mokyr, 2016, p. 143). Tuttavia, non ci fu alcuna “rivoluzione industriale medievale”, perché non furono associati a un’approfondita conoscenza propositiva che spiegasse perché funzionavano. Non si stabilì il tipo di dinamica innovativa auto-rafforzante che, secoli dopo, portò alla Grande divergenza.
48. Questo spiega anche come sia possibile che civiltà del passato ricche di abili artigiani, in Medio Oriente, Asia meridionale e Asia orientale, siano comunque cadute nella stasi tecnologica. La presenza di tali artigiani è una condizione necessaria ma non sufficiente per un progresso sostenuto e accelerato.
49. Sulla base di un’ampia revisione della letteratura, Bloom, et al. (2019) traggono la stessa conclusione: la globalizzazione e l’apertura del commercio sono positive per la concorrenza e l’innovazione, ma possono esacerbare le disuguaglianze tra le persone e tra i luoghi.
50. Mokyr (1994) la chiama legge di Cardwell, in onore dello storico Donald Cardwell, che ha osservato che nessuna nazione è stata molto creativa per più di un “periodo storicamente breve”. Tra le proteste più note della storia contro lo sviluppo tecnologico sono annoverate la rivolta luddista e i Captain Swing Riots in Gran Bretagna all’inizio del XIX secolo. Recenti ricerche hanno stabilito un nesso causale tra l’adozione delle trebbiatrici e la frequenza delle rivolte locali negli anni Trenta del XIX secolo (Caprettini e Voth, 2020). Lo stesso vale per l’elettrificazione in Svezia, che ha avuto l’effetto di risparmiare sulla manodopera e ha portato a conflitti e scioperi locali (Molinder, et al., 2021). Naturalmente, tutto ciò si ricollega agli attuali timori per l’automazione, l’IA e i robot, e per i loro effetti sui posti di lavoro e sul futuro del lavoro.
51. Juma (2016). Non possiamo escludere che il sistema di welfare relativamente generoso prevalente in Inghilterra all’epoca dell’inizio della rivoluzione industriale, le cosiddette Poor Laws, abbia contribuito a contenere le tensioni sociali in seguito all’introduzione di tecnologie che riducevano il lavoro, consentendone una più rapida diffusione.
52. Questo non ha nulla a che fare con politici poco lungimiranti che cercano la rielezione. Esortare i politici a sacrificarsi e a fare ciò che “deve essere fatto” per il bene comune significa perdere di vista l’obiettivo della buona politica, ovvero la costruzione di maggioranze e consenso. Le politiche adottate solo in nome dell’abnegazione provocherebbero semplicemente tensioni sociali, polarizzazione e un’inversione di tendenza una volta che il politico in carica è stato spodestato. Si tratta di un’argomentazione che ho già avanzato in precedenza nella discussione delle riforme proposte per cambiare la struttura dell’economia, in particolare durante i programmi di aggiustamento strutturale in Europa (Terzi, 2017).
53. “La cultura ha influenzato la tecnologia sia direttamente, cambiando gli atteggiamenti verso il mondo naturale, sia indirettamente, creando e alimentando istituzioni che hanno stimolato e sostenuto l’accumulo e la diffusione di ‘conoscenza utile’” (Mokyr, 2016, p. 7).
54. Ritchie, “Wild Mammals Have Declined by 85 Percent since the Rise of Humans, But There
Is a Possible Future Where They Flourish”, Our World in Data, 20 aprile 2021, https://ourworldindata.org/wild-mammal-decline
55. Richiamando la tradizione giudaico-cristiana, questa visione rappresenta la moderna reinterpretazione del Libro della Genesi, con l’umanità che passa dal “dominio” alla gestione. La natura è la creazione di Dio e, come tale, deve essere trattata con rispetto.
56. Secondo l’“ipotesi Gaia”, proposta da James Lovelock e Lynn Margulis, la natura è insondabile perché tutto è interconnesso in modi che non possiamo assolutamente comprendere (Lovelock, 2000).
57. Uno di questi inquadramenti è stato chiamato “ecologismo”, un’ideologia che parte dall’assunto che il mondo non umano merita considerazione morale e che i sistemi sociali, economici e politici dovrebbero tenerne conto (Baxter, 1999). Per gli ecologisti, “La crisi ambientale è così grande [...] che solo una profonda riorganizzazione del sistema politico, sociale ed economico potrebbe portare a una soluzione. Ciò richiederebbe un cambiamento massiccio dei valori umani” (Harrison e Boyd, 2018, p. 275). Notano inoltre che, al contrario, “Gli ambientalisti ritengono che le questioni verdi, per quanto importanti, possano essere affrontate all’interno delle strutture politiche ed economiche esistenti. Per avere successo, ciò richiederebbe un governo saggio, una legislazione appropriata e l’adozione volontaria di pratiche ecologiche da parte dei consumatori” (p. 275). Queste due citazioni riassumono le posizioni ecologiche e ambientali divergenti che abbiamo esplorato in questo libro, soprattutto per quanto riguarda l’ecosocialismo e il capitalismo verde.
58. Mokyr (2016, p. 17).
59. Nel 2018, mentre facevo rafting nel Grand Canyon, ho avuto un’illuminante conversazione su questo tema con il biologo vegetale Jiří Friml. La nostra vicinanza alla parete del canyon, che evidenzia quasi due miliardi di anni di storia geologica della Terra, ha reso facile per lui esprimere il punto di vista delle scienze naturali secondo cui, nel grande schema delle cose, gli esseri umani non sono nulla di speciale. La nostra presenza sul pianeta per una minuscola frazione della sua storia non è in alcun modo paragonabile a quella di altri animali che si sono affermati come i trilobiti, presenti negli oceani per quasi 300 milioni di anni. Come scienziato sociale ho dovuto ribattere, sottolineando tutte le meraviglie del nostro progresso tecnologico, che con ogni probabilità ci renderà la prima specie a diventare multiplanetaria. Il dibattito non si è risolto, ma mi sono rimasti impressi due punti: che la nostra storia è molto più breve di quanto ci piaccia immaginare, e che la si può comprendere meglio alla luce della continuità, con parallelismi con altre forme organiche sulla Terra. Queste riflessioni hanno dato forma a questo libro.