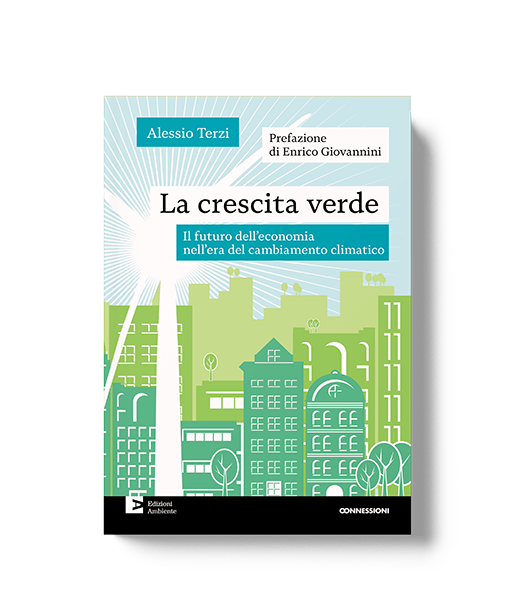
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
7. La lotta globale per il pianeta Terra
1. Galbraith (1958, p. 55); Boldizzoni (2020, p. 220). Come ha notato Max Weber, il Manifest der Kommunistischen Partei di Marx ed Engels è al contempo un risultato scientifico di altissimo livello e il testo fondante di una religione di salvezza. La seconda valenza rende impossibile cambiare le convinzioni dei suoi seguaci con argomentazioni razionali, come notato da Boldizzoni (2020, p. 56).
2. Mi vengono in mente le parole del rivoluzionario italiano Antonio Gramsci. Nei Quaderni dal carcere (1930), egli scrive che “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati” (Gramsci, 1971, p. 275-276).
3. Hardin (1968).
4. Hardin conclude che i soli appelli alla moralità non possono risolvere la tragedia dei beni comuni, sia per quanto riguarda l’ambiente sia per qualsiasi altra risorsa condivisa. Decenni dopo, William Nordhaus ha dimostrato quantitativamente, utilizzando la teoria dei giochi e il suo modello economico-climatico DICE, che la riduzione volontaria senza sanzioni può portare solo a un equilibrio non cooperativo e scarsamente efficace (Nordhaus, 2015).
5. Sachs (2008, p. 3). Raworth (2017, p. 198, p. 201) giunge a conclusioni simili: “Per molti secoli siamo stati incoraggiati a identificarci soprattutto come nazioni”, ma ora dovremmo compiere il passo, “inevitabile” nel XXI secolo, di considerarci parte di una comunità globale, aprendo così la possibilità di un disegno redistributivo universale. Di conseguenza, “nel secolo della famiglia planetaria, le tasse globali” si riveleranno inevitabili. Forse involontariamente, queste idee riecheggiano gli scritti del rivoluzionario e teorico politico marxista Leon Trotsky, che allo scoppio della Prima guerra mondiale osservò che “la guerra proclama la caduta dello stato nazionale” che “ ha seppellito sé stesso” (Trotsky, 1918, p. 21-22).
6. Per un esempio recente sulla pandemia e sul lancio dei vaccini, si veda Brown, et al. (2021). Nelle loro conclusioni, affermano tra l’altro che “poiché è necessario uno sforzo cooperativo e meglio coordinato a livello globale, i paesi ricchi devono interrompere le loro lotte intestine e forse rallentare il proprio consumo delle scorte di vaccini, attualmente limitate, per distribuirne di più ai luoghi di maggiore crisi del mondo il più presto possibile”.
7. Per onestà intellettuale, mi sembra giusto menzionare che in passato a volte mi sono schierato io stesso in questo campo, per esempio nel lavoro svolto con Jim O’Neill per riformare il G7 e il G20 in modo da renderli un comitato direttivo dell’economia mondiale (O’Neill e Terzi, 2014).
8. Goldin (2021, p. 176).
9. Sulle origini dell’Antropocene, John Robert McNeill e Peter Engelke concludono: “È meglio tornare al terreno più solido del passato, per cercare di capire come il presente sia arrivato a essere quello che è [...] Questo non ci permetterà di conoscere il futuro – niente lo farà, nemmeno il più sofisticato esercizio di modellazione – ma può aiutarci a immaginare la gamma di possibilità o, come diceva san Paolo, a vedere attraverso un vetro scuro” (McNeill ed Engelke, 2014, p. 6).
10. Per un’ampia trattazione delle sfide derivanti dall’adattamento al clima, si veda Kahn (2021).
11. Burke, et al. (2015, “Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production”) producono una mappa simile dell’impatto economico dei cambiamenti climatici nei vari paesi, a un livello di granularità inferiore e senza tener conto dell’adattamento. Cruz Alvarez e Rossi-Hansberg (2021), guardando al benessere in senso lato, confermano questi effetti, così come Desmet, et al. (2021), che si concentrano sui costi economici delle inondazioni costiere dovute ai cambiamenti climatici. Si veda anche Ricke, et al. (2018).
12. Noy, et al. (2021), esaminando le conseguenze fiscali dei terremoti a vari livelli di governo in Giappone, trovano, nei livelli di governo più bassi (città e paesi), uno schema di aumento a breve termine della spesa per i soccorsi, ma di riduzione a lungo termine di altre spese . Ai livelli di governo più alti, come le prefetture (regioni), la politica fiscale è abbastanza solida da impedire riduzioni indesiderate dei servizi pubblici. Per questo motivo, contro la minaccia di disastri naturali, è meglio unire le forze, proprio come fanno gli assicuratori mettendo in comune i rischi.
13. La migrazione è sempre stata uno dei modi principali con cui le persone rispondono allo stress ambientale (Butzer e Endfield, 2012; Boccaletti, 2021). L’avvento dell’ agricoltura e la creazione di insediamenti permanenti hanno reso più costoso spostarsi, ma l’effetto è stato solo quello di invertire l’analisi costi-benefici. In situazioni di necessità, e quando c’è poco da perdere, gli esseri umani continuano a migrare lontano dalle avversità. Burzyńskia, et al. (2019) stimano che nel XXI secolo ci saranno tra i 200 e i 300 milioni di migranti climatici, soprattutto a causa dell’innalzamento del livello dei mari.
14. Ciò è stato riconosciuto, tra gli altri, da Wadhams (2017), Dartnell (2015), Sachs (2008, p. 107) e Barrett (2007).
15. Per proteggere la città, è stato realizzato un sistema di protezione dalle inondazioni noto come MOSE, caratterizzato da una barriera mobile sottomarina lunga 1,6 chilometri. A dimostrazione del fatto che le conseguenze del cambiamento climatico possono essere contenute, ma che le soluzioni non saranno a buon mercato, questa infrastruttura di adattamento al clima è costata ben 5,5 miliardi di euro. Per maggiori dettagli, si veda https://www.mosevenezia.eu/h
16. Nella psicologia sociale, questa dinamica è stata accuratamente studiata fin dai primi lavori di Henri Tafjel sui pregiudizi osservabili anche in “gruppi minimi”, cioè in gruppi che non hanno storie precedenti e quindi non hanno legami psicologici o interpersonali significativi. Per maggiori informazioni sull’esperimento che coinvolge i bambini di cinque anni e i colori delle magliette, si veda Dunham, et al. (2011).
17. In Descent of Man, Darwin la mette in questi termini: “Non c’è dubbio che una tribù comprendente molti membri che, possedendo in alto grado lo spirito di patriottismo, la fedeltà, l’obbedienza, il coraggio e la empatia, fossero sempre pronti ad aiutarsi l’un l’altro e a sacrificarsi per il bene comune, sarebbe vittoriosa sulla maggior parte delle altre popolazioni; e questa sarebbe selezione naturale” (citato in Wilson, 2019, p. 77-78).
18. Christakis (2019, p. 277).
19. Come afferma Huntington (1996, p. 21): “Le persone usano la politica non solo per promuovere i propri interessi, ma anche per definire la propria identità. Sappiamo chi siamo solo quando sappiamo chi non siamo e spesso solo quando sappiamo contro chi siamo”. Per quanto triste e spiacevole possa essere questa realtà, non andrebbe ignorata. Le persone che cercano di rafforzare la propria identità cercheranno, o creeranno artificialmente, dei nemici.
20. Anderson (1983, p. 6).
21. È stato, infatti, suggerito che le religioni si siano evolute culturalmente per sfruttare questo aspetto della psicologia umana (Henrich, 2016, 204).
22. Analizzando la storia degli inni nazionali europei, Elgenius (2011, p. 141) ha rilevato che quelli adottati a partire dall’epoca delle guerre napoleoniche sono ricchi di riferimenti alla guerra, al conflitto, alla morte e alla fratellanza.
23. Émile Durkheim, fondatore della disciplina della sociologia, ha analizzato le bandiere nazionali come moderni oggetti di culto, e quindi come estensioni di una forma secolare di divinità. In effetti, il loro uso è regolato dalla legge e le azioni contro di esse considerati come atti di profanazione. L’uso delle bandiere da parte delle società umane risale almeno al 4000 a.C. L’impero romano decorava i propri stendardi con le immagini dell’imperatore e dell’aquila, che era considerata un animale sacro, riconosciuta ufficialmente all’interno del santuario del Pantheon romano, e la cui divinità è stata trasmessa all’impero. Si noti, inoltre, che il simbolismo legato al sangue è ampiamente diffuso: otto bandiere del mondo su dieci includono il colore rosso (Elgenius, 2011, p. 28-29, p. 91).
24. Per una trattazione teorica del legame tra conflitto e misure di dispersione come la polarizzazione e la disuguaglianza, si veda Esteban e Ray (2011). I parametri chiave che i due studiosi identificano sono il “grado di coesione all’interno del gruppo” e la quantità di beni pubblici da allocare.
25. Alesina e Glaeser (2004). Tra gli studi più importanti in questo campo vi sono Luttmer (2001) e Alesina e La Ferrara (2005), che forniscono entrambi una panoramica della letteratura. Altri studi sono stati condotti a livello subnazionale e cittadino negli Stati Uniti, giungendo a conclusioni simili, e in Europa (Alesina, et al., 2021). Negli anni Settanta, il premio Nobel Thomas Schelling (1978) ha proposto un “modello di quartiere delimitato” secondo il quale, superato un determinato punto critico, un gruppo etnico abbandona un quartiere per evitare di essere in minoranza. La chiara premessa di fondo è un “senso del Noi” legato all’etnia, che porta a una minore disponibilità a condividere un bene comune, in questo caso un quartiere.
26. L’antropologo evoluzionista Joe Henrich mostra che gli esseri umani si sono evoluti per identificare l’etnia – sintonizzandosi particolarmente su un insieme di fattori culturali tra cui la lingua o il dialetto – piuttosto che la razza, con la sua attenzione ai tratti morfologici tra cui il colore della pelle e il tipo di capelli. Nel mondo moderno, tuttavia, queste serie di indizi tendono a sovrapporsi fortemente (Henrich, 2016, p. 204-205).
27. Nel 2012, la prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences degli Stati Uniti d’America dedicò un numero speciale ai legami tra il collasso di antichi stati o civiltà e i cambiamenti climatici o ambientali. In esso, Butzer e Endfield (2012) sostengono che raramente lo stress ambientale ha inferto un colpo decisivo a una società. Piuttosto, nell’arco di un decennio, ha generalmente innescato dinamiche socioeconomiche che a loro volta hanno portato al collasso. Nelle loro parole, nei casi in cui furono colpite società “con bassa resilienza, le reazioni involutive a cascata possono destabilizzare il sistema attraverso carestie, conflitti interni e semplificazione politica, portando infine a crisi di sussistenza, rottura dell’ordine sociale e guerre civili” (p. 3630).
28. Sulla base dei dati meteorologici storici dell’Europa medievale e proto-moderna, Anderson, et al. (2017) dimostrano che durante il XV e il XVI secolo, nei periodi di temperature insolitamente fredde a cui era legata una scarsa resa dei raccolti, le probabilità che venisse espulsa una comunità ebraica erano maggiori. Questa correlazione è più forte per le città note per avere un suolo di scarsa qualità e stati deboli. Gli storici suggeriscono una spiegazione: gli ebrei erano comodi capri espiatori per i mali sociali ed economici. In modo simile, l’aumento del numero di processi per stregoneria in Europa durante la Piccola era glaciale è stato fortemente associato al calo delle temperature e al conseguente malessere economico (Oster, 2004). Una dinamica simile è stata identificata nella Tanzania moderna, che collega condizioni di pioggia estreme (siccità e inondazioni) all’uccisione di (presunte) streghe (Miguel, 2005).
29. Christakis (2019, p. 276) sostiene che i leader malvagi e assetati di potere possono sfruttare queste dinamiche di identificazione nel gruppo di appartenenza per promuovere attivamente l ’odio verso “l’altro”, intensificando le espressioni di xenofobia, razzismo e pregiudizio per creare dei capri espiatori.
30. Si veda Butzer e Endfield (2012).
31. Come osserva Wilson (2019, p. 222), il romanziere Joseph Conrad disse che uno dei motivi per cui gli piaceva scrivere storie di mare era perché la vita su una nave è così moralmente semplice: tutti a bordo sanno che l’imperativo comune è mantenere la nave a galla. Lo stesso fascino, ipotizza Wilson, potrebbe attirare verso avventure spaziali come Star Trek e Star Wars. Quando una catastrofe planetaria appare imminente, chiunque “comincerà a considerare l’intera Terra come la cerchia morale adeguata”.
32. Parker (2013). Si veda anche Fagan (2001).
33. Iyigun, et al. (2017, “The Long-Run Effects”; 2017, “Winter Is Coming” ).
34. Si veda Jia (2014) per l’analisi dei dati di 267 prefetture della Cina storica. Utilizzando ricostruzioni paleoclimatiche ad alta risoluzione per far coincidere gli eventi con l’incidenza dei conflitti in Cina nell’ultimo millennio, Zhang, et al. (2006) concludono che “la natura più ostile ha generato una ‘forza di spinta’, portando a guerre più frequenti tra stati, regioni e tribù, che potrebbero aver portato al collasso delle dinastie e un forte diminuzione della popolazione” (p. 459).
35. Miguel, et al. (2004).
36. Per esempio, il rafforzamento del ruolo delle autorità religiose di più alto rango in Egitto ha permesso loro di minacciare di ribellarsi alle autorità politiche (Chaney, 2013).
37. Utilizzando prove risalenti fino all’inizio dell’Olocene in Arabia Saudita, Petraglia, et al. (2020) dimostrano che, dopo l’estrema aridità dell’Ultimo massimo glaciale (avvenuta circa 20.000 anni fa), le pre cipitazioni sono aumentate circa 10.000 anni fa durante il periodo umido dell’Olocene . I dati mostrano, tuttavia, che dopo 6.000 anni si è verificato un nuovo ritorno verso l’aridità, culminato con l’instaurazione dell’ambiente desertico prevalente oggi. Grazie a questa grande fluttuazione è possibile analizzare come le società umane si siano adattate ai cambiamenti ambientali. Un aspetto affascinante del lavoro è che i periodi di siccità sono documentati nell’arte rupestre (per esempio nei petroglifi di Shuwaymis) con la raffigurazione del bestiame affamato. La competizione per il pascolo ha portato a un forte aumento dei conflitti, come documentato da una quota crescente di sepolture con vittime che mostrano segni di traumi fatali. Quando necessario, gli esseri umani migravano dall’entroterra desertico alle coste ricche di risorse.
38. Burke, et al. (2015, Climate and Conflict); si confronti con Carleton, et al. (2016).
39. In effetti, come molti hanno sottolineato, il G20 funziona bene in tempi di crisi ma male in tempo di pace. Prendendo in prestito un titolo classico del teatro dell’assurdo (del drammaturgo Luigi Pirandello), Angeloni e Pisani-Ferry (2012) definiscono i membri del G20 come “personaggi in cerca d’autore”. Una conferma recente di questo modello è stata la moratoria sul debito dei paesi poveri durante la crisi da COVID-19.
40. Per gli economisti, queste differenze all’interno del gruppo si ricollegano al problema della selezione avversa nelle assicurazioni, per cui chi è più a rischio è più propenso a cercare una copertura. Nel contesto della collaborazione sui cambiamenti climatici i paesi più poveri, che hanno di più da perdere data la loro esposizione a eventi negativi più frequenti e di maggiore entità, hanno maggiori probabilità di essere disposti a cooperare, ma anche di non avere le risorse necessarie per farlo. I paesi ricchi sono meno incentivati a partecipare allo sforzo di collaborazione.
41. Barrett (2007) delinea uno spettro di problemi globali in base al grado di cooperazione universale richiesto per risolverli . Da un lato ci sono problemi come la deviazione degli asteroidi, che in linea di principio potrebbero essere risolti dal solo paese interessato. All’altro estremo ci sono sfide come l’eradicazione delle malattie infettive. Barrett definisce le soluzioni in questa parte dello spettro come “anelli più deboli” tra i beni pubblici globali, perché per raggiungerle è letteralmente necessaria la cooperazione di tutti i paesi del mondo. Un paese che non riesce a combattere una pandemia, per esempio, può essere la fonte di una mutazione e di una ricomparsa del problema a livello globale. In base alla tassonomia di Barrett, il cambiamento climatico si avvicina di più alla seconda categoria di problemi, perché molti paesi, anche se non tutti, devono unirsi allo sforzo di collaborazione. La cooperazione dei paesi a basse emissioni, siano essi molto piccoli (per esempio, il principato di Monaco) o molto poveri (come l’Afghanistan), non è essenziale per evitare la catastrofe climatica.
42. Si noti che negli Stati Uniti questa politica è stata messa in atto dall’ amministrazione Trump ma mantenuta da quella Biden, nonostante il suo programma più internazionalista. Le forze che dettano questi comportamenti sono più profonde e più forti di un singolo leader.
43. Anche se le economie avanzate fossero state completamente vaccinate entro la fine del 2021, la loro ripresa economica sarebbe stata comunque frenata a causa dei loro legami commerciali e produttivi con le economie emergenti e in via di sviluppo. Secondo alcune stime, i costi si sarebbero aggirati tra i 400 e i 1.900 miliardi di dollari, ben al di sopra dei costi di produzione e distribuzione dei vaccini a livello globale (stimati in 27,2 miliardi di dollari). Gli autori dello studio hanno concluso che il coordinamento globale sui vaccini avrebbe avuto senso anche solo da un punto di vista strettamente economico, mettendo da parte le considerazioni morali (Çakmaklı, et al., 2021).
44. Purtroppo, quando sono in gioco diverse forze socioeconomiche, il fatto che una linea d’azione sia sensata dal punto di vista scientifico, morale e organizzativo non garantisce che venga intrapresa. Gli investimenti in ricerca e sviluppo ne sono un chiaro esempio. In settori che vanno dalla ricerca sul cancro all’esplorazione spaziale, alla tecnologia climatica, per non parlare dello sviluppo di vaccini contro le pandemie, unendo le forze a livello globale si potrebbero ottenere progressi più rapidi. I paesi potrebbero unire le proprie risorse per la ricerca di tecnologie innovative ed evitare sforzi ridondanti. Questo, tuttavia, si vede raramente. Invece, per esempio, per quanto riguarda la fornitura di vaccini contro il COVID-19, la Cina e la Russia hanno immediatamente colto l’opportunità per attuare la cosiddetta diplomazia dei vaccini, stringendo accordi per la fornitura basandosi su obiettivi geopolitici invece di dirigere le vendite e le donazioni verso i punti più critici dell’infezione. Chiunque si illuda che l’umanità sia in grado di unire le forze di fronte a minacce comuni dovrebbe prendere questi esempi come monito.
45. Ciò sembra riecheggiare le famose previsioni di Francis Fukuyama (1992). All’indomani del crollo dell’Unione Sovietica, egli riteneva che la democrazia liberale occidentale si sarebbe diffusa universalmente come forma definitiva di governo e che le guerre sarebbero finite, quantomeno tra le nazioni tradizionalmente riunite come potenze del primo e del secondo mondo. L’euforia seguita alla fine della Guerra fredda ha generato l’illusione di un’armonia globale, che si è rapidamente rivelata per quello che era. Questo sentimento è tipico della fine di conflitti su vasta scala, tra i quali la Prima guerra mondiale, che avrebbe dovuto essere “la guerra che pone fine a tutte le guerre”, e la Seconda guerra mondiale, che avrebbe dovuto essere seguita da un sistema universale di “nazioni amanti della pace” secondo il presidente Franklin D. Roosevelt (come riportato in Huntington, 1996, p. 31-32).
46. Per analogia storica, anche con l’avvento della benzina all’inizio del XX secolo, non abbiamo assistito alla scomparsa del carbone, la fonte energetica del secolo precedente. Al contrario, ancora oggi, anche nelle economie avanzate il carbone ha una quota generalmente piccola, ma comunque rilevante, nel mix energetico.
47. Si veda Yergin (2020). Ne abbiamo già avuto un assaggio nel 2010 quando, nel contesto di uno scontro geopolitico su alcune isole contese, la Cina ha sospeso l’esportazione verso il Giappone di alcune terre rare, utilizzate per fabbricare prodotti come automobili ibride, turbine eoliche o missili teleguidati. Pur ospitando circa il 36% delle riserve mondiali, la Cina detiene attualmente circa il 90% della produzione mondiale di terre rare, il che offre al paese una forte leva per avere la meglio in situazioni geopolitiche tese (Tagliapietra 2020, Global Energy Fundamentals, p. 129).
48. In una certa misura, la forte presenza della Cina in Africa, in particolare nella gestione delle riserve di cobalto e rame della Repubblica Democratica del Congo, e più in generale la vasta Belt and Road Initiative, nota anche come Nuova via della seta, possono essere lette anche attraverso queste lenti geopolitiche.
49. La Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi più poveri al mondo. Come ampiamente discusso dall’economista dello sviluppo Paul Collier, la scoperta o la maggiore importanza delle risorse naturali può essere un’arma a doppio taglio per un paese povero. Da un lato, infatti, promette un consistente afflusso di denaro e, con esso, la possibilità di sollevare molti dalla povertà. Dall’altro, il paese sarà esposto al rischio di corruzione e frode dilaganti. Collier propone una serie di regole internazionali per ridurre questo rischio ( Collier, 2011).
50. Un’altra tendenza in atto in parallelo è l’accelerazione delle tecnologie digitali, compreso l’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale. Questo, proprio come la transizione verde, implicherà un allontanamento dalla proprietà delle risorse materiali e rafforzerà l’importanza cruciale del dominio tecnologico.
51. Allison (2017). Studiosi precedenti hanno fatto lo stesso ragionamento; si veda, per esempio, Mearsheimer (2001).
52. In un controverso articolo, il premio Nobel Thomas Schelling ha rotto con la narrazione prevalente di “lasciare un pianeta migliore ai nostri figli”, sottolineando che, da una prospettiva strettamente economica, la mitigazione del clima implica affrontare dei costi oggi per raccogliere i benefici (o evitare i costi catastrofici) domani. Se combiniamo questa prospettiva con la richiesta che i costi maggiori siano sostenuti dai paesi ricchi e industrializzati – la cui popolazione rappresenta oggi meno del 20% del totale globale, e nei prossimi decenni diminuirà ancora – è facile capire che la spesa per la mitigazione del clima funzionerà come una sorta di macchina di implicita redistribuzione globale (Schelling, 1995).
53. Sen (2006).
54. “Con il declino del potere occidentale, diminuisce anche la capacità dell’Occidente di imporre i propri concetti di diritti umani, liberalismo e democrazia alle altre civiltà e diminuisce anche l’attrattiva di questi valori per le altre civiltà” (Huntington, 1996, p. 92). L’imposizione culturale non è un’abitudine esclusivamente occidentale. Nel corso della storia, l’aumento del potere ha quasi sempre significato l’imposizione di valori, pratiche e istituzioni ad altre società.
55. Banca Mondiale (2008).
56. Le esportazioni svolgono un duplice ruolo nel consentire un rapido sviluppo. In primo luogo, aprono uno spazio nel conto delle partite correnti. In parole povere, il fatto di esportare di più significa avere la possibilità di importare di più senza destabilizzare la propria valuta. Questo, a sua volta, permette di importare macchinari o fattori produttivi dall’estero e produrre progressivamente bene a più alto valore aggiunto. In secondo luogo, le esportazioni implicano l’accesso a un’ampia domanda. L’alternativa è affidarsi al mercato interno, ma in un paese in via di sviluppo questo sarà per definizione piccolo e potrà crescere solo lentamente. Terzi, “Is the Golden Age of Globalization Over?”, World Commerce Review, primavera 2020, https://www.worldcommercereview.com/publications/article_pdf/1828
57. Un’altra parte dell’agenda standard della decrescita, che comporta profonde conseguenze per le prospettive di uno sviluppo rapido, è l’idea di promuovere la produzione locale e di spezzare le catene globali del valore. L’apertura commerciale non è una garanzia di sviluppo rapido, nonostante le solite argomentazioni del Washington Consensus. Tuttavia, senza apertura commerciale, è improbabile che si verifichino miracoli economici.
58. Ostrom (1990, p. 26). Discutendo un decennio più tardi il problema del cambiamento climatico globale, Elinor Ostrom conclude che “È ovviamente molto più facile trovare soluzioni ai problemi di azione collettiva connessi con risorse comuni su scala ridotta che per i beni comuni globali”. Inoltre, sostiene l’autrice, “Un’ampia ricerca empirica sull’azione collettiva [...] ha ripetutamente identificato un necessario nucleo centrale di fiducia e reciprocità tra le persone coinvolte, associato ai livelli di successo dell’azione collettiva. Se fosse adottata su scala globale una sola politica relativa al cambiamento climatico, sarebbe particolarmente difficile accrescere la fiducia che cittadini e imprese devono avere nel fatto che altri cittadini e imprese sparsi in mezzo mondo stiano adottando azioni simili a quelle intraprese ‘in casa’” (Ostrom, 2009, p. 13, p. 35). In un altro testo (Ostrom, 2012, p. 356), afferma che “ deve essere ripensato l’affidarsi interamente agli sforzi internazionali per risolvere i problemi climatici globali ”.
59. A Ostrom V., Tiebout e Warren (1961) si deve il pionieristico articolo che ha utilizzato per la prima volta il termine “ policentricità” nel contesto della governance metropolitana, per descrivere, come ha riassunto in seguito l’autore principale, un sistema di “(1) molte unità autonome formalmente indipendenti l’una dall’altra, (2) che scelgono di agire in modi che tengono conto degli altri, (3) attraverso processi di cooperazione, competizione, conflitto e risoluzione dei conflitti” (Ostrom V., 1991, p. 225). Si veda anche Dorsch e Flachsland (2017). Per quanto riguarda il cambiamento climatico, questo approccio decentralizzato si basa sulla consapevolezza che le iniziative a livello subnazionale contribuiscono a una rete di politiche in continua evoluzione , guidate da imprese, gruppi della società civile e individui, che spesso si organizzano in reti transnazionali. Un approccio policentrico può anche incoraggiare la sperimentazione locale, particolarmente utile quando problemi complessi come la totale decarbonizzazione richiedono sperimentazione e soluzioni che possono essere successivamente portate a livelli di governance più elevati.
60. Sachs (2008, p. 112-114).
61. Montreal ha imposto sanzioni commerciali a chi si rifiutava di adeguarsi una volta che un quorum di paesi avesse firmato. Barrett (2007) sottolinea invece che Kyoto è stato concepito per essere applicato solo ai 38 paesi più ricchi. Questo ha dato a più di altri 150 paesi un incentivo a comportarsi in modo opportunistico e non ha garantito ai paesi ricchi che i loro sforzi sarebbero stati sufficienti a risolvere il problema a lungo termine.
62. Rodrik (1997).
63. Si veda, per esempio, Creutzig (2020).
64. Tra gli altri, anche il geografo Karl Butzer ha esaminato casi storici di civiltà che hanno affrontato un forte stress ambientale. La sua conclusione è che gli stati autoritari rendono più difficile l’emergere di opzioni dal basso, mettono a tacere il dissenso e soffocano l’iniziativa. Nel frattempo, la tolleranza per le nuove idee potrebbe aver aiutato le società dell’Europa occidentale a evitare il collasso nei tre secoli (tra il periodo caldo medievale e la fine della Piccola era glaciale) di perturbazioni climatiche estreme (Butzer, 2012).
65. Il protocollo di Kyoto era in linea di principio vincolante, ma quando il Canada non ha rispettato i suoi obblighi e si è ritirato dal trattato, non sono state applicate sanzioni. Inoltre, i paesi sviluppati che non raggiungevano gli obiettivi di CO2 potevano semplicemente pagare per compensare le emissioni extra attraverso il “meccanismo di sviluppo pulito” previsto dal Protocollo.
66. Per una spiegazione molto approfondita del funzionamento di questo processo per l’Unione europea nel mondo, si veda Bradford (2020).
67. Il Marocco e la Tunisia hanno il potenziale per diventare importanti hub di energia rinnovabile, dato che l’Unione Europea si impegna per diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050 (Bennis, 2021). Più in generale, grazie all’idrogeno prodotto con energie rinnovabili come il solare e l’eolico, il Nord Africa potrebbe diventare un fornitore di energia per l’Europa , così come vasti paesi limitrofi come l’Ucraina (Leonard, et al. 2021).
68. Sebbene la cooperazione nel campo dei cambiamenti climatici, sulla falsariga dell’Accordo di Parigi, crei un importante quadro globale, dovremmo ammettere che l’azione avverrà inevitabilmente a livello nazionale (Tagliapietra, 2020, Global Energy Fundamentals, p. 77-78).
69. Per quanto riguarda i pesci, si veda Sala (2020), che sostiene che il 35% degli oceani mondiali dovrebbe essere un’area protetta. Per quanto riguarda la terraferma, si veda Strassburg, et al. (2020) sul modo in cui selezionare i luoghi per la protezione e il ripristino degli ecosistemi.
70. Si vedano, per esempio, Leonard, et al. (2021) e Tagliapietra e Wolff (2021). Per i fondamenti teorici dell’idea, si veda Nordhaus (2015), in particolare sull’utile contributo dei club climatici. In definitiva, “Le radici della cooperazione economica sono nella comunanza culturale” (Huntington, 1996, p. 135).
71. Dimostrando un’impressionante capacità di intuire le tendenze emergenti, Martin Wolf, scrivendo nel 2007 quando green non era affatto la parola d’ordine, giunse alla conclusione, sorprendentemente simile, che il Grande arricchimento aveva allontanato l’umanità da un mondo a somma zero e, in questo processo, aveva trasformato le relazioni internazionali. Wolf ha avvertito che, se la crescita dovesse finire, “seguirebbero giorni bui”. Martin Wolf, “The Dangers of Living in a Zero-Sum World Economy”, Financial Times, 19 dicembre 2007.
72. Wilson (2019, p. 111).