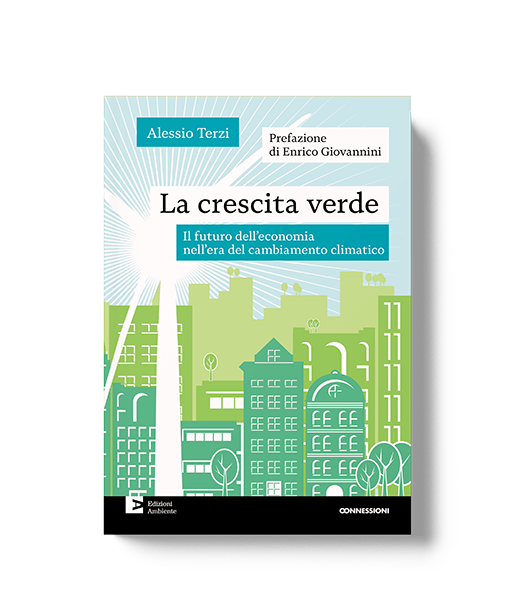
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
3. Utopia post-crescita
1. Studi più recenti, che affrontano le questioni della decrescita da una prospettiva ambientale piuttosto che sociale, enfatizzano l’imposizione di un tetto normativo al consumo di energia e materiali come leva politica per rallentare la crescita (Hickel, 2020, Less is More).
2. Secondo John Kenneth Galbraith, è proprio questo legame tra crescita e occupazione, e quindi riduzione della povertà, che ha convinto i liberali e la sinistra americana ad aderire all’obiettivo di espandere l’economia. Nel suo primo discorso inaugurale (4 marzo 1933), il presidente Franklin Delano Roosevelt dichiarò: “Il nostro più grande e principale compito è rimettere la gente al lavoro”. Negli anni Sessanta, la stessa questione portò Galbraith a sostenere la necessità di un “reddito minimo”.
3. Si noti che Piketty (2013) raggiunge questa conclusione da un’angolazione diversa, sostenendo che le accelerazioni nell’accumulo di ricchezza e nella disuguaglianza hanno origine dai rallentamenti della crescita economica. Allo stesso modo, “Il capitale è tornato perché è tornata la bassa crescita” (Piketty e Zucman 2014, p. 1260).
4. Per un’analisi che metta in relazione povertà e salute mentale, si veda Ridley, et al. (2020).
5. Sul legame tra agenda sociale e ambientale, l’attivista per il clima Chico Mendes avrebbe affermato: “L’ecologia senza lotta di classe è solo giardinaggio”.
6. In tutta la letteratura, “I fautori della decrescita marxisti sostengono che la decrescita smantellerebbe gli attuali modelli di proprietà e gestione aziendale, introducendo invece un’economia gestita in modo cooperativo nella quale il processo decisionale e i redditi siano più equamente condivisi” (Büchs e Koch 2019, p. 158). “Recessione e depressione sono possibili all’interno del capitalismo; la decrescita probabilmente no. Mentre in teoria la crescita potrebbe non essere necessaria o inevitabile all’interno del capitalismo, in pratica il sistema genera crescita attraverso dinamiche di concorrenza, proprietà privata e disponibilità di energia a basso costo” (Kallis et al. 2018, p. 300). Per “subordinare l’espansione del capitalismo legato alla proprietà a considerazioni ecosociali”, osserva van Griethuysen, “si potrebbero elaborare e attuare accordi istituzionali alternativi al regime di proprietà privata, come la proprietà statale e il possesso comune, con possibili articolazioni all’interno di un regime globale e multilivello” (van Griethuysen 2012, p. 268).
7. L’idea che i progressi tecnologici portino gli esseri umani a dedicare più tempo alle “proprie facoltà intellettuali e morali” è molto più antica di Keynes, poiché risale almeno alla Political Justice (1793) di William Godwin, anarchico del XVIII secolo.
8. Jackson (2009, p. 148).
9. Questo esempio è preso in prestito da Aghion, et al. (2021, p. 161-162).
10. Jackson (2009, p. 147-148); T. Jackson, “Let’s Be Less Productive”, New York Times, 26 maggio 2012.
11. Hickel (2020, Less is More, p. 249-288)
12. Smith (2016)
13. Fmi – Fondo monetario internazionale/IMF (2021)
14. Come piccola ma importante distinzione, si noti che la maggior parte delle aziende che sperimentano questa opzione sperano che una riduzione dell’orario di lavoro aumenti effettivamente la produttività dei dipendenti nelle ore rimanenti, il che non sarebbe un effetto auspicabile nell’ambito di un programma di decrescita.
15. Questo programma di governo particolarmente attivo nell’orientare la ricerca è stato reso popolare dal lavoro dell’economista Mariana Mazzucato (2013).
16. A Utopia, la ricchezza è comunque poco utile, dato che il denaro non ha alcun ruolo, se non quello di acquistare prodotti stranieri. Questo è un aspetto importante che anche i sostenitori della decrescita dovrebbero tenere presente, ovvero la dimensione internazionale della propria visione.
17. Già 400 anni prima di Keynes, Thomas More immaginava una giornata lavorativa ridotta a sei ore, il doppio di quanto previsto dall’economista del XX secolo.
18. Molte delle idee di Thomas More hanno una lunga tradizione, che risale almeno ai tempi di Platone. Per esempio, ne La Repubblica, la città ideale è quella in cui i cittadini trascorrono le proprie giornate discutendo di filosofia, senza farsi distrarre da desideri che vadano oltre i bisogni primari (Westacott, 2016, 59).
19. Per la Francia, si vedano Crépon e Kramarz (2002), Chemin e Wasmer (2009) ed Estevão e Sá (2008); per la Germania, Hunt (1999); per il Quebec, Skuterud (2007); per il Cile, Sanchez (2013).
20. Questo argomento è tratto da Bailey (2015). Nelle sue parole, “La fine della crescita provoca un momento di enorme tensione tra le simpatie ambientaliste della sinistra (e una più ampia critica sociale del Pil come misura del benessere) e la tendenza profondamente radicata della sinistra a vedere lo stato come uno strumento di politica progressista e di offerta di welfare” (p. 802).
21. Si veda, per esempio, Hickel (2020, Less is More, p. 20, p. 218).
22. Come ha osservato Wilfred Beckerman (1974, p. 14), “Non solo nessun economista sostiene la massima crescita economica come obiettivo oggi, ma non l’avrebbe mai fatto nemmeno in passato”.
23. Tra il 1965 e il 1995, la famiglia americana media ha guadagnato sei ore al giorno di tempo libero in più grazie alla riduzione dell’orario di lavoro, tutte dedicate a guardare la televisione (Cohen, 2018, p. 126).
24. Come ha scritto Wilfred Beckerman (1974, p. 13), “Questa idea di contrasto tra il grossolano materialismo della scuola pro-crescita e la sensibilità squisitamente raffinata di quella anti-crescita si ripresenta continuamente”.
25. Pecchi e Piga (2008). Per una discussione sull’influenza del Bloomsbury Group, si veda l’introduzione dei curatori, p. 11-12.
26. Fry e Parker, “Early Benchmarks Show ‘Post-Millennials’ on Track to Be Most Diverse, Best-Educated Generation Yet”, Pew Research Center, 15 novembre 2018, https://www.pewresearch.org/social-trends/2018/11/15/early-benchmarks-show-post-millennials-on-track-to-be-most-diverse-best-educated-generation-yet/
27. Thomas More ne era ben consapevole. In Utopia (1516), chi vuole lasciare la città per andare a trovare un amico deve chiedere un permesso, che viene concesso solo se non vengono intaccate le esigenze della società.
28. L’azione individuale di maggior impatto per ridurre l’impronta di carbonio è avere meno figli, superiore di almeno un ordine di grandezza rispetto alla seconda in classifica, cioè il vivere senza un’auto (Wynes e Nicholas, 2017). Nel nostro contesto, questo ci porta a chiederci se anche questa decisione, che finora è stata personale e privata, debba essere in qualche modo regolamentata in un mondo in cui le riduzioni quantitative sono lo strumento principale per limitare l’impatto umano sul clima.
29. Anche la tribù degli Achuar, citata come fonte di ispirazione da Jason Hickel, pur essendo in pace con l’ambiente è costantemente in guerra con i gruppi vicini (Chacon e Mendoza, 2012).
30. “Nei paesi avanzati [...] l’aumento della produzione è un’alternativa alla distribuzione. E, come indicato, è stato il grande solvente delle tensioni associate alla disuguaglianza [...] Quanto è meglio concentrarsi sull’aumento della produzione, un programma sul quale sia i ricchi sia i poveri possono essere d’accordo, poiché va a beneficio di entrambi” (Galbraith, 1958, p. 78). Secondo l’economista Daniel Cohen (2018, p. 1): “La crescita economica [...] è l’elisir che allevia il dolore del conflitto sociale”.
31. Il presidente Franklin Delano Roosevelt varò il suo New Deal nel pieno di una recrudescenza della xenofobia e dell’antisemitismo. Per fare un esempio più ampio, Benjamin Friedman (2005) mostra che, ciclicamente, quando la crescita economica condivisa è diminuita, i sentimenti di nativismo e intolleranza sono cresciuti nelle economie avanzate, come negli anni Ottanta del XIX secolo e nel XX secolo in America.
32. Si discute ancora se Hobbes deva essere considerato un pensatore liberale o illiberale, dato che la sua visione del mondo mescola elementi di entrambe le posizioni. Per i nostri scopi, Hobbes non pone vincoli al governo, esclude la divisione dei poteri, preferisce l’assolutismo e l’autoritarismo, è anticostituzionalista e ostile alla democrazia (Malcolm 2016).
33. Buch-Hansen (2018). Questo tipo di fuga dalla realtà sociale ha una lunga tradizione, che risale almeno al filosofo greco Epicuro, che consigliava ai suoi discepoli di “ritirarsi dal mondo; evitare i dolori e i pericoli del coinvolgimento; cercare la propria sicurezza e la serenità”. Si isolò poi in una comunità (il Giardino) con loro e con altri amici per godere delle poche cose fondamentali per una vita felice.
34. Utilizzando il lessico del Capitolo 2, l’Unione Sovietica si è dimostrata efficace nella crescita estensiva, ma subottimale sul fronte di quella intensiva. Si vedano, per esempio, Easterly e Fischer (1995); Ofer (1987).
35. Pur sostenendo il principio della vita frugale, che può essere visto come un incoraggiamento all’autosufficienza, il filosofo Emrys Westacott (2016, p. 22) osserva che: “Potremmo coltivare un orto, imparare a fare il pane e costruire una o due librerie. Queste attività non sono da disprezzare; a parte il risparmio di denaro, possono essere intrinsecamente gratificanti. Ma, a meno che non si traducano in uno stile di vita complessivo, non dovremmo illuderci di fare qualcosa di più che giocare all’autosufficienza”.
36. Nel 1844, i seguaci di Charles Fourier fondarono nell’Ohio sudoccidentale una comunità intenzionale chiamata Utopia, per poi vederla spazzata via da una piena del fiume Ohio nel 1847. La comunità fu poi riorganizzata, ma con la guerra civile e l’aumento dei prezzi dei terreni, il progetto non poté essere sostenuto.
37. Anche se le emissioni dovessero cessare domani, il mondo dovrebbe comunque continuare ad adattarsi per i prossimi secoli ai gas serra emessi in passato. L’adattamento climatico è in qualche modo inevitabile. Dartnell (2015, 31); Sachs (2008, 107); Wadhams (2017).
38. Pur essendo diventata sempre più parte del sentire comune, questa idea è di per sé problematica. La domanda che dovremmo tenere a mente è: essenziale per che cosa? Durante la pandemia da COVID-19, questo rispondeva alla semplice logica della sopravvivenza a breve termine. Molte attività che sicuramente non vorremmo veder scomparire del tutto, per esempio il comparto della cultura e dell’istruzione superiore (compresa la ricerca), sono state ritenute non essenziali nel periodo del lockdown del COVID-19.
39. I dispositivi medici sono un valido esempio. Secondo alcune stime, il 96% dei dispositivi medici donati ai paesi in via di sviluppo non funziona più dopo soli cinque anni, a causa della mancanza di manutenzione o di pezzi di ricambio; il 39% non ha funzionato fin dall’inizio, per mancanza di formazione, manuali e accessori (Malkin 2007; Perry e Malkin 2011).
40. Per sapere di più sull’intreccio tra lavoro, know-how e mansioni, si veda Dartnell (2015).
41. Ricardo Hausmann, “Secrets of Economic Growth”, World Economic Forum, 10 marzo 2015, https://www.youtube.com/watch?v=2FeugaLv5Bo
42. Un’eccezione degna di nota è Fotopoulos (2010), che riconosce che la decrescita non è solo una rivoluzione culturale, ma richiederà anche un “nuovo sistema [...] al di là dell’economia di mercato internazionalizzata" (p. 114).
43. Analogamente, Milanovic (2019, p. 187) considera la possibilità (remota) che un paese abbandoni autonomamente il “capitalismo ipercommercializzato”.
44. Alla fine del Settecento, Joseph Priestley, scienziato e filosofo della natura, espresse la convinzione che il commercio “tenda molto a espandere la mente e a guarirci da molti pregiudizi dannosi”. Montesquieu osservò che “è una regola quasi generale che ovunque ci siano costumi cortesi ci sia il commercio, e che ovunque ci sia il commercio ci siano costumi cortesi” (Friedman 2005, p. 40).
45. Gli immigrati in paesi meno equi tendono a essere mediamente più qualificati rispetto alla popolazione non immigrata (Parey, et al., 2017). Per esempio, gli immigrati messicani negli Stati Uniti sono più istruiti e la maggior parte di essi si colloca nella fascia alta della distribuzione dei salari in Messico (Chiquiar e Hanson, 2005). Ciò è in linea con l’ipotesi della selezione positiva. Per le prove dell’elevato spirito imprenditoriale dei migranti, si veda Kerr e Kerr (2020). Infine, gli inventori di punta tendono a migrare da paesi ad alta tassazione a paesi a bassa tassazione, e quindi a welfare ridotto (Akcigit, et al., 2016).
46. M. Wolf, “Last Chance for the Climate Transition”, Financial Times, 18 febbraio 2020.
47. Ne abbiamo avuto un’idea nel 2020. A fronte della peggiore contrazione economica dai tempi della Grande depressione, le emissioni di CO2 a livello globale sono diminuite a malapena del 6,4% rispetto al 2019. Ciò suggerisce che affrontare le emissioni di CO2 attraverso riduzioni quantitative dell’attività economica richiederebbe un’enorme contrazione dell’economia globale e del reddito pro capite.
48. Friedman (2005, p. 17).
49. Si veda, per esempio, Glaeser (2012).
50. Al giorno d’oggi, le collaborazioni internazionali sono all’origine dei lavori ad alta rilevanza, mentre la produzione di ricerca puramente a livello nazionale si è stabilizzata in termini di quantità e qualità (Adams, 2013; Adams e Gurney, 2018).
51. La Cina è un caso interessante: a un ritmo serrato, il paese è riuscito a recuperare il ritardo rispetto alle economie avanzate ed è ora un leader tecnologico, in parte grazie ai massicci finanziamenti per ricerca e sviluppo. Allo stesso tempo, è improbabile che l’organizzazione politica cinese, se rimane invariata, si dimostri molto attraente per i leader dell’innovazione e gli scienziati nel lungo periodo. Questo potrebbe rivelarsi un ostacolo importante nel percorso di transizione verso un modello di crescita guidato dall’innovazione.
52. Si vedano, per esempio, Bloom e Canning (2007); Rosero-Bixby e Dow (2016). Per un contributo fondativo, si veda Preston (1975).
53. “Prima del 1870, la salute nei paesi ricchi e in quelli poveri era molto simile, ma dopo il 1870 è progredita nei paesi ricchi mentre i miglioramenti nei paesi poveri sono iniziati solo dopo il 1930. Ciò è coerente con l’idea che le innovazioni tecnologiche siano impiegate prima nei paesi ricchi e si diffondano dopo nelle società più povere” (Bloom e Canning, 2007, p. 498).
54. Per una panoramica approfondita sulle dimensioni (vita, salute, prosperità, sicurezza, pace, conoscenza e felicità) che negli ultimi decenni sono migliorate in tutto il mondo, non solo nelle economie avanzate, si veda Pinker (2018).
55. Ciò si estende anche a categorie non ovvie ma di grande interesse, come lo sport. Per esempio, “il Pil reale è il miglior indicatore di previsione della performance olimpica di un paese" (Bernard e Busse, 2004, p. 413). Il conteggio delle medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sembrerebbe confermare questo schema.
56. Il Pil è stato concepito per tracciare solo i beni e i servizi scambiati sul mercato, perché la maggior parte dei bisogni della società è soddisfatta attraverso il lavoro specializzato e gli scambi sul mercato, piuttosto che tramite l’autoproduzione o la carità degli altri. Sebbene fornisca una ricompensa occasionale a chi la offre e a chi la riceve, la benevolenza difficilmente funzionerebbe come meccanismo efficiente per organizzare la società in generale, come ha notato Adam Smith (1776, p. 10): “Nessuno, tranne i mendicanti, sceglie di dipendere principalmente dalla carità dei propri concittadini”.
57. Coyle (2014) osserva che diversi studi hanno stabilito che il tempo impiegato a pendolare è un forte fattore predittivo della felicità soggettiva.
58. Jones e Klenow (2016), utilizzando una nuova e ampia metrica del benessere che tiene conto di consumi, tempo libero, mortalità e disuguaglianza, trovano che la correlazione del “ben-essere”, come da loro definito, con il Pil pro capite è quasi perfetta: 0,98.
59. Rodrik (2011, p. 135-136).
60. Il World Happiness Report (Helliwell, et al., 2021) riporta i primi dieci paesi sulla base dei dati raccolti nel 2020 come segue: Finlandia, Islanda, Danimarca, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia, Germania, Norvegia, Nuova Zelanda e Austria. Gli Stati Uniti figurano in quattordicesima posizione. Il paese a reddito medio più alto è l’Arabia Saudita, in ventunesima posizione.
61. Descrivendo la stessa interazione, Andrew McAfee (2019, p. 4) fa riferimento ai “quattro cavalieri dell’ottimismo”, ovvero il capitalismo e uno stato efficiente, integrati dal progresso tecnologico e dalla consapevolezza pubblica.
62. Adam Smith inizia la sua indagine su The Wealth of Nations proprio facendo riferimento a ciò che determinerà se “la nazione sarà meglio o peggio rifornita di tutte le necessità e le comodità di cui ha bisogno” (Smith, 1776, p. 1).
63. Nella Metafisica (Libro I, Parte 1), Aristotele afferma che “tutti gli uomini per natura desiderano conoscere”.
64. Le preferenze delle élite economiche americane hanno un impatto di gran lunga maggiore nel determinare la politica rispetto a quelle del cittadino medio: “Quando la maggioranza dei cittadini è in disaccordo con le élite economiche o con gli interessi organizzati, in genere perde. Inoltre, a causa del forte pregiudizio sullo status quo insito nel sistema politico statunitense, anche quando una maggioranza abbastanza ampia di americani è favorevole a un cambiamento politico, in genere non lo ottiene” (Gilens e Page, 2014, p. 576). Iversen e Soskice (2019) fanno un ragionamento simile.
65. Alesina, Glaeser e Sacerdote (2005).
66. Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale hanno standard di vita abbastanza simili in termini di maggiore aspettativa di vita, maggiore tempo libero e minore disuguaglianza, nonostante l’Europa abbia un Pil pro capite pari a circa il 70% di quello degli Stati Uniti (Jones e Klenow, 2016). Nei primi anni Duemila, i livelli di produttività in Europa e negli Stati Uniti erano simili, con l’aumento europeo del tempo libero piuttosto che del reddito a guidare le differenze nel Pil complessivo (Blanchard 2004).
67. È forse in questo senso che si può leggere l’appello di Dani Rodrik al populismo economico “buono” (Rodrik, 2018).
68. In The Theory of Moral Sentiments, Adam Smith (1759, p. 313) scrive che “prima di poter provare qualcosa per gli altri, dobbiamo essere in qualche misura a nostro agio. Se la nostra povertà ci opprime molto, non abbiamo tempo per occuparci di quella del nostro prossimo”. Secondo i sostenitori della decrescita, i cittadini saranno a proprio agio e, poiché la scarsità sarà abbracciata volontariamente, non causerà neanche un pizzico di povertà (Kallis, 2019).