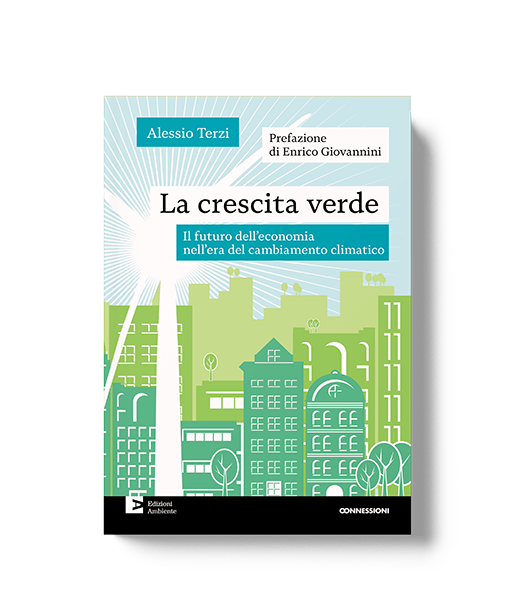
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
1. I limiti della crescita economica
1. McAfee (2019, 54).
2. Meadows, et al. (1972) ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, è stato tradotto in 30 lingue ed è stato ripubblicato in versioni aggiornate 20 e 30 anni dopo.
3. Latouche (1989).
4. Demaria, et al. (2013) usano il termine generico “decrescita” per un insieme di movimenti accademici, politici e sociali radicali che sottolineano la necessità di ridurre la produzione e il consumo e di definire obiettivi diversi dalla crescita economica. Per Buch-Hansen (2018), “I principali sostenitori del progetto della decrescita sono piccole frazioni della base popolare dei partiti di sinistra e dei sindacati, nonché accademici e altri cittadini preoccupati per l’ingiustizia sociale e la natura insostenibile per l’ambiente delle società nelle regioni ricche del mondo" (162). Secondo Paul Krugman, “La decrescita è una posizione marginale della sinistra europea”, come riportato da Weiss e Cattaneo (2017, 229).
5. Questo approccio multidisciplinare e olistico deve molto ad Aurelio Peccei, la mente del Club di Roma. Egli credeva fermamente che i maggiori problemi dell’umanità – il deterioramento ambientale, la povertà, le malattie endemiche, il degrado urbano, la criminalità – non dovessero essere affrontati in modo isolato o come “problemi in grado di essere risolti uno per uno”. Le soluzioni potrebbero venire solo da un impegno a livello di sistema e su più fronti davanti a una “problematica” complessa. Questa prospettiva è molto presente in Meadows, et al. (1972).
6. La letteratura sulla decrescita è ampia, soprattutto perché abbraccia diversi decenni e differenti discipline. Inoltre, include diversi punti di vista, tra i quali la decrescita tout court, ma anche la “non-crescita”, nota anche come ricerca di un’economia stazionaria, o una posizione agnostica che semplicemente rifiuta la crescita come obiettivo politico. Per presentare una panoramica organica dei principi fondamentali del movimento, attingo da molti testi, ma senza pretese di completezza: Easterlin, et al. (2010), Schor (2010), Wiedmann (2020), Daly (2014), Göpel (2016), Hickel (2020), Van den Bergh (2017), Lipsey (2019), Kallis, et al. (2018), Kallis, et al. (2012), Kallis (2019), Jakob, et al. (2020), Demaria, et al. (2013), Jakob e Edenhofer (2014), Büchs e Koch (2019), Buch-Hansen (2018), Hoffmann (2015), Gough (2015), Newell e Paterson (2011), Newell (2011), Victor e Rosenbluth (2007), Victor (2012), Raworth (2017), Park (2015), Jackson e Victor (2015), Binswanger (2009), Klitgaard e Krall (2012), Nordhaus (1973), Ehrlich (1968), Fotopoulos (2010), Hardt e O’Neill (2017), Weiss e Cattaneo (2017), Klein (2019, 2015) e Trainer (2012).
7. Il pianeta dispone già di pozzi naturali di assorbimento, ossia di sistemi che assorbono più carbonio di quanto ne emettano. Questi comprendono il suolo, le foreste e gli oceani. Insieme, si stima che essi possano rimuovere tra le 9,5 e le 11 Gt di CO2 all’anno. Per rendere l’idea, le emissioni globali di CO2 hanno raggiunto le 37,1 Gt nel 2017. Questo significa, in primo luogo, che la riduzione delle emissioni di carbonio rimane necessaria ed estremamente elevata; in secondo luogo, che stabilire un obiettivo di zero emissioni entro il 2050 è una semplificazione, ma dà un’idea utile di quanto sia necessario fare.
8. Jevons (1865) osservò che il consumo di carbone in Inghilterra aumentò in modo vertiginoso dopo che James Watt introdusse il suo motore a vapore, che migliorava notevolmente l’efficienza del precedente progetto di Thomas Newcomen. Le innovazioni di Watt resero il carbone una fonte di energia più conveniente e il motore a vapore si diffuse rapidamente in un’ampia tipologia di industrie. In questo modo, il consumo totale di carbone aumentò anche se la quantità di carbone richiesta per ogni singola applicazione era diminuita. Questo portò Jevons a prevedere che il carbone si sarebbe esaurito rapidamente, cosa che chiaramente non accadde.
9. Jackson (2009, 102).
10. Si veda, per esempio, Gillingham, et al. (2013, 2016).
11. Hall, et al. (2014).
12. Un’estensione di questa argomentazione riguarda il concetto di Energy Return on (Energy) Investment, reso popolare da Charles A. S. Hall negli anni Ottanta; l’EROI (o EROEI) è il meccanismo fondamentale assunto nel modello informatico World3 utilizzato da Meadows, et al. (1972). Per maggiori informazioni sul legame tra EROI e crescita economica, si veda l’Appendice A.
13. Rockström, et al. (2009).
14. “Thomas Jefferson to the Republicans of Washington County, Maryland, 31 March 1809”, Founders Online, National Archives, https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0088
15. Kuznets (1934, 7).
16. Jackson (2009, 151).
17. Questa critica ha profonde radici storiche e filosofiche, che risalgono almeno ai tempi di Jeremy Bentham (la cui filosofia utilitaristica è fondamentale per la moderna economia del benessere) e di John Stuart Mill (teorico dell’economia stazionaria e occasionale punto di riferimento per gli studiosi della decrescita). Bentham affermava che le attività hanno la stessa utilità se offrono lo stesso piacere. Mill sosteneva che alcuni piaceri sono qualitativamente migliori di altri; per esempio, è più utile apprendere che giocare a dadi. Tuttavia, quella di Mill è una proposizione difficile da dimostrare (Westacott, 2016, p. 69-71). Come sostengo altrove (Terzi, 2021, “Economic Policy-Making beyond GDP”), la natura parsimoniosa della misurazione del Pil è proprio il motivo per cui questo indicatore è stato così ampiamente accolto e continua a essere usato. Altri indicatori compositi del benessere economico, come il Genuine Progress Indicator (Indicatore del progresso reale, N.d.R.) di Herman Daly, riflettono inevitabilmente giudizi di valore in quanto assegnano pesi relativi a diverse dimensioni. Questo rende estremamente difficile la loro sopravvivenza ai cambiamenti di leadership politica (Chancel, Thiry e Demailly, 2014). Pertanto, una delle critiche più aspre rivolte al Pil, ossia il fatto che non distingua tra produzione “morale” e “immorale”, né attribuisca giudizi di valore, potrebbe essere più un tratto distintivo che un difetto.
18. Per una recente rassegna delle problematiche legate alla misurazione del prodotto interno lordo, si veda Ocse (2020).
19. Robert F. Kennedy, “Remarks at the University of Kansas”, 18 marzo 1968, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-march-18-1968
20. Alcuni studiosi che hanno cercato di stimare il punto di appiattimento della felicità nella distribuzione empirica concludono che il punto di svolta potrebbe essere intorno ai 10.000 dollari. Per rendere l’idea, il Pil pro capite degli Stati Uniti nel 2017 era quasi sei volte tanto. I paesi che si trovano al “livello ottimale di sussistenza” comprenderebbero Namibia, Dominica e Armenia.
21. Smith (1776), Libro IV, Capitolo II, paragrafo IX.
22. Bregman (2020, 19).
23. Questo punto è ripreso da The Limits to Growth nel suo aggiornamento per il trentennale (Meadows, Randers e Meadows, 2004).
24. John Maynard Keynes (1930) aveva previsto che nell’arco di un secolo avremmo raggiunto la settimana lavorativa di 15 ore. Questo presupponeva sia che la produttività del lavoro (e quindi gli stipendi) sarebbe aumentata notevolmente, grazie all’innovazione e alla tecnologia, sia che le persone avrebbero desiderato lavorare di meno. Non molto tempo dopo, nel 1932, il filosofo Bertrand Russell propose una giornata lavorativa di quattro ore e attaccò l’etica occidentale del lavoro, affermando che “è stata fatta una grande quantità di danni nel mondo moderno dalla convinzione che il lavoro sia virtuoso” e che “la strada per la felicità e la prosperità risiede in una diminuzione organizzata del lavoro”. Russell, “In Praise of Idleness”, Harper’s Magazine, ottobre 1932.
25. Raworth (2017, 282).
26. Graeber (2019, 8).
27. Per alcuni esempi della crescente copertura mediatica della decrescita, soprattutto in seguito alle politiche contro il COVID-19 e ai lockdown, si veda Meredith, “A Guide to Degrowth: The Movement Prioritizing Well-Being in a Bid to Avoid Climate Cataclysm”, CNBC, 19 febbraio 2021; Cassidy, “Can We Have Prosperity without Growth?”, New Yorker, 10 febbraio 2020; Osaka, “Can We Learn to Live With Less? Covid-19 and the Debate on ‘Degrowing’ the Economy”, Rolling Stone, 12 agosto 2020; Rathi, “How ‘Degrowth’ Pushes Climate and Well-Being over GDP”, Bloomberg, 18 settembre 2020; Russell, “Five Things You Need to Know about Degrowth”, Deutsche Welle, 10 novembre 2020; Rotman, “Capitalism Is in Crisis. To Save It, We Need to Rethink Economic Growth”, MIT Technology Review, 14 ottobre 2020.
28. Wallace-Wells D., “Vaclav Smil: We Must Leave Growth Behind”, New York Times Magazine, 24 settembre 2019. Per consultare altri esperti di energia favorevoli all’abbandono della crescita economica, oltre a Smil (2019), si vedano anche Foxton (2018), Alston (2020), Herrington G., citato in N. Ahmed, “MIT Predicted in 1972 that Society Will Collapse This Century. New Research Shows We’re on Schedule”, Vice, 14 luglio 2021; Parisi G., “L’aumento del Pil si scontra con la lotta al riscaldamento globale”, citato in Giovannetti, “Clima, il Nobel Parisi: ‘L’aumento del Pil è in contrasto con la lotta al riscaldamento globale’”, La Repubblica, 8 ottobre 2021; Chu S., “You have to design an economy based on no growth or even shrinking growth”, citato in Goering L., “John Kerry Calls on Scientists to Lead Fight against Climate Change Denial”, Reuters, 27 aprile 2021; Higgins M.D., presidente della Repubblica d’Irlanda, “Climate Action and the Role of Engineers”, discorso alla Engineers Ireland Annual Conference, 21 ottobre 2020; European Environment Agency, “Growth without Economic Growth”, Briefing no. 28/2020, AEA, Copenaghen, 11 gennaio 2021, https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth. Papa Francesco (2015) scrive che “[...] l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a ‘spremerlo’ fino al limite e oltre il limite” (p. 106) e “Per questo è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti” (p. 193).
29. Questi primi studiosi americani della decrescita furono influenzati anche dall’esperienza dell’Unione Sovietica, vista come un sistema fallito la cui crescita aveva provocato uno spaventoso impatto ambientale.
30. Jackson (2009, 202) sembra aver riconsiderato la questione, visto che il suo ultimo libro sulla decrescita si intitola Post Growth: Life after Capitalism (2021).