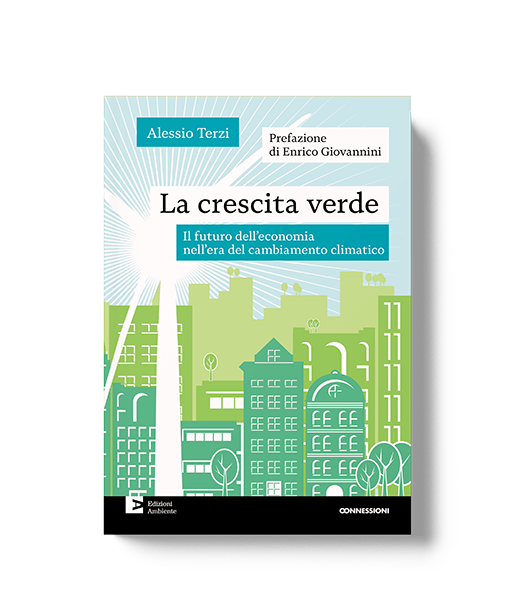
La crescita verde
Il futuro dell'economia nell'era del cambiamento climatico
5. Le vere origini dell’imperativo della crescita
1. Hickel (2020, Less is More, p. 209, p. 239). Questo principio si basa su profonde radici storiche. Per esempio, William Godwin, anarchico del XVIII secolo, credeva che il “male nell’uomo” fosse semplicemente dovuto all’influenza corruttiva delle condizioni sociali e che, una volta cambiate queste condizioni, si sarebbe rivelata la reale bontà degli esseri umani (Godwin, 1793). È interessante notare che Thomas Malthus, un altro punto di riferimento intellettuale per l’attuale comunità della decrescita, considerava irrimediabilmente utopica la visione del mondo di Godwin (Malthus, 1798).
2. Questa critica del capitalismo, visto come un sistema totalitario che genera falsi bisogni attraverso la realtà costruita degli spot pubblicitari, è stata resa popolare dal filosofo marxista Herbert Marcuse (1964).
3. L’esempio classico è quello delle lampadine, che già negli anni Venti del Novecento avrebbero potuto essere prodotte (più costosamente) per durare più a lungo, ma erano state progettate per ridurre la loro durata massima, da circa 2.000 ore a 1.000, secondo lo standard stabilito dal “cartello Phoebus” (sciolto nel 1939). Un altro esempio di questo tipo, risalente ai primi anni del Novecento, è il frigorifero, che avrebbe potuto basarsi sulla tecnologia ad assorbimento anziché su quella a compressore. Ciò avrebbe ridotto il numero di parti mobili e il rischio di guasti, rendendo gli apparecchi meno soggetti a manutenzione (Dartnell, 2015, p. 92).
4. La pubblicità è sicuramente importante, ma l’idea che da sola possa generare vendite sostenute è chiaramente falsa. La storia dell’economia è piena di prodotti lanciati con grande clamore, ma che poi non sono riusciti a catturare i consumatori. Gli esempi provengono anche dai maestri del marketing, come la Coca-Cola con la débâcle della New Coke nel 1985, la Ford con la Edsel nel 1957, il Newton di Apple nel 1993, l’assistente software Bob di Microsoft nel 1995, l’hamburger Arch Deluxe di McDonald’s nel 1996, il Fire Phone di Amazon nel 2014 e i Google Glass nel 2013. Non c’è da stupirsi che, quando i fondi venture capital e gli angel investor incontrano i fondatori di startup, la loro domanda più frequente sia “Quale bisogno non ancora sfruttato state cercando di soddisfare?” e non “Quale bisogno state cercando di creare?”.
5. Poiché la pubblicità può in parte aiutare le imprese a eludere la dura logica dell’“innovare o morire”, la R&S e la pubblicità sono in un certo senso investimenti alternativi per un’azienda. Cavenaile e Roldan-Blanco (2021) dimostrano che vietare la pubblicità, come raccomandano i sostenitori della decrescita per contenere i consumi e il Pil, farebbe aumentare (controintuitivamente) il Pil statunitense di ben 0,22 punti percentuali, poiché stimola l’innovazione.
6. Bregman (2020). Molti libri recenti, che combinano scienze cognitive, neuroscienze, psicologia sociale, antropologia e biologia evolutiva, rifiutano la dicotomia semplicistica tra buoni e cattivi e indagano invece sulle origini culturali ed evolutive del comportamento umano. Tra questi Sapolsky (2017) e Wrangham (2019). Si veda anche Buss (2001).
7. Questa dicotomia ha profonde radici storiche. Nell’antica Grecia, Epicuro distingueva tra desideri “naturali”, per esempio il cibo, e quelli “non naturali”, come la musica (Westacott, 2016, p. 89). Più di recente, una dicotomia simile si è affermata durante la pandemia da COVID-19, in particolare durante i picchi dei lockdown, tra lavoratori essenziali e non essenziali. I primi sono quelli che lavorano per soddisfare i “bisogni”.
8. Dal punto di vista strettamente evolutivo, ciò che serve sono solo le risorse necessarie per sopravvivere e riprodursi, in modo che i geni di un organismo vengano trasmessi alla discendenza, garantendo la sopravvivenza dei geni dell’individuo.
9. Il concetto di consumo ostentativo non è stato scoperto, ma piuttosto reso popolare da Veblen (1899). Nell’antica Roma, Orazio rifletteva già sull’argomento, così come Alexander Pope nel XVIII secolo e John Rae e John Stuart Mill nel XIX. Mill scrisse: “Io non accetto alcun ascetismo, e non desidero affatto che venga scoraggiata, né per legge né per opinione, una soddisfazione ricercata per la genuina inclinazione per la cosa stessa, o per il suo godimento; ma una gran parte delle spese delle classi alte e medie nella maggior parte dei paesi [...] non viene sostenuta per il piacere offerto dalle cose per le quali si spende il denaro, ma per il rispetto dell’opinione e per l’idea che ci si aspettino da loro determinate spese, come appendice della posizione” (Mill, 1849, p. 425-426).
10. Richard Layard considera come esternalità negativa l’insoddisfazione sociale creata dalle persone ricche che si dedicano al consumo ostentativo. Dato che fa sentire gli altri meno degni, suggerisce di tassarli fino al 30% per ripristinare l’efficienza economica (Layard, 2006). Per una discussione più teorica, si veda anche Fleurbaey (2009).
11. Questo problema corrisponde a una situazione chiamata “dilemma del prigioniero”. Due complici criminali vengono catturati, ma le prove sono scarse, sufficienti per far sì che entrambi ricevano una breve pena detentiva. I complici sono tenuti in celle separate e le autorità sperano che almeno uno di loro si rivolti contro l’altro. A ciascuno viene offerta la libertà in cambio di prove che dimostrino la colpevolezza dell’altro, in modo che il complice riceva una condanna pesante. È chiaro che la coppia trarrà il massimo vantaggio se entrambi resisteranno a questa offerta. Ma, individualmente, è più probabile che ciascuno tragga vantaggio dall’implicare l’altro. Confessando, se il complice rimane in silenzio, il primo se la cava; se il complice confessa, confessando riceve una pena più breve che rimanendo in silenzio. Non sapendo come si comporterà l’altro, ciascuno fornisce le prove del crimine dell’altro. Per tornare al problema del consumo ostentativo, in linea di principio le persone starebbero meglio se avessero un accordo collettivo per non consumare. A livello individuale, tuttavia, c’è un incentivo a derogare.
12. Per un esame più formale di questo argomento, si vedano, per esempio, Amaldoss e Jain (2005); Corneo e Jeanne (1997); Frank (1985, 2011); Frank, et al. (2014) sulle “spese a cascata”. Per un articolo pionieristico al riguardo, si veda Leibenstein (1950).
13. Anche il medesimo atto può essere classificato come un bisogno o un’esigenza, a seconda della situazione. Se vivete a New York e prendete un aereo ogni fine settimana per andare a festeggiare a Key West in Florida, molti lo definirebbero un lusso stravagante. Ma se prendete lo stesso volo ogni fine settimana perché vostra madre vive da sola in Florida e ha problemi di salute, questo potrebbe essere considerato un bisogno, o per lo meno non sarebbe criticato come una spesa inutile ed egocentrica.
14. Le tecnologie meno recenti possono essere utilizzate per dare un senso particolare a un evento, come le carrozze trainate da cavalli per i funerali solenni e le candele per le cene romantiche (Dartnell, 2015, p. 106). Altri esempi possono essere le penne stilografiche usate dai presidenti degli Stati Uniti per firmare i disegni di legge, i caminetti usati per l’atmosfera piuttosto che per il calore e persino le lettere scritte a mano nell’era delle e-mail e di Whatsapp.
15. Il “tapis roulant dell’innovazione” ha funzionato anche per quanto riguarda l’energia, con le classi più abbienti disposte a pagare cifre maggiori per soluzioni migliori e più pulite. Per esempio, nel Regno Unito dei primi anni del Novecento, teatri, ristoranti e ricchi proprietari erano disposti a pagare per il nuovo “lusso”, l’illuminazione elettrica, piuttosto che per l’uso di lampade a gas o a cherosene, senza badare al prezzo molto più alto. L’illuminazione elettrica era di 25 volte più costosa per unità di energia rispetto al gas, ma solo sette volte più efficiente. Nel 1920, l’illuminazione elettrica divenne l’opzione più economica disponibile, aprendo la strada a un’adozione diffusa (Fouquet, 2010). Si veda anche Fouquet (2014, 2008).
16. Come ben illustrato nel documentario Netflix del 2020 The Social Dilemma, i social media come Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest mirano deliberatamente al bisogno psicologico delle persone di uniformarsi e distinguersi, generando tendenze alla dipendenza e riuscendo a spingere gli utenti a trascorrere in media oltre due ore al giorno sulle proprie piattaforme.
17. La stessa osservazione è stata fatta dall’economista Robert Frank (2007, p. XX): “Nessuno nega che un’auto che negli anni Cinquanta veniva percepita come dotata di forte accelerazione, oggi sembrerebbe lenta alla maggior parte degli automobilisti. Allo stesso modo, è più probabile che una casa di determinate dimensioni sia considerata spaziosa se è più grande rispetto ad altre abitazioni della stessa zona. E un abito adatto per un colloquio è quello che si confronta vantaggiosamente con quelli indossati da altri candidati per lo stesso lavoro. In breve, la valutazione dipende sempre e ovunque dal contesto”.
18. Questo esempio è tratto da Coyle (2014, p. 65).
19. Langgut (2017).
20. Smith (1776, Libro II, p. 352).
21. Sen (1999).
22. Secondo le parole di Sen: “I livelli di capacità accettati come ‘minimi’ possono essere essi stessi rivisti verso l’alto man mano che la società diventa più ricca e sempre più persone raggiungono livelli di capacità in precedenza raggiunti da pochi. Queste variazioni aumentano ulteriormente la necessità di avere più reddito nei paesi più ricchi, per evitare quella che viene considerata povertà in termini di ‘standard contemporanei’" (Sen, 1985, p. 26).
23. Nelle parole di Joseph Schumpeter: “Quando si raggiungono standard più elevati [...] i desideri si espandono automaticamente e ne emergono o ne vengono creati di nuovi” (Schumpeter, 1942, p. 116). Cinquant’anni prima, Alfred Marshall (1890, p. 60) aveva osservato che “I desideri e le voglie dell’uomo sono innumerevoli e molto vari come tipo: ma sono generalmente limitati e possibili da soddisfare. L’uomo non civilizzato non ne ha molti di più dell’animale selvaggio; ma ogni passo avanti del suo progresso aumenta la varietà dei suoi bisogni insieme a quella dei suoi metodi per soddisfarli. Egli desidera non solo maggiori quantità di ciò che è stato abituato a consumare, ma anche una migliore qualità di quelle cose; desidera una maggiore scelta di oggetti, e vuole che soddisfino i nuovi bisogni che crescono in lui”. Hirsch (1976) approfondisce il tema dell’utilità interna ed esterna. Come altri, però, Hirsch è caduto nell’errore di separare il mondo in bisogni (utilità intrinseca) e desideri (utilità estrinseca). Ritenendo che l’utilità intrinseca fosse già soddisfatta, concluse che l’unica opzione per le persone fosse quella di accumulare quelli che chiamò “beni posizionali”, caratterizzati esclusivamente dall’utilità estrinseca. Inoltre, escludeva quello che io chiamo in questo libro il processo di democratizzazione del consumo. Questo lo portò a concludere (erroneamente) che esistevano dei rigidi limiti sociali alla crescita economica, che in fin dei conti era spinta solo da rivali sociali che si contendevano una risorsa ancora scarsa: lo status.
24. Ecco perché in questo libro faccio spesso riferimento alla scarsità “percepita”.
25. A livello di paese, in tutto il mondo, il reddito nazionale pro capite è il miglior indicatore della soddisfazione media nazionale di vita. Al netto del reddito, tuttavia, anche i cambiamenti nell’aspettativa di vita fanno aumentare la felicità, indipendentemente dal fatto che l’aspettativa iniziale sia alta o bassa. Il progresso, a quanto pare, alimenta la felicità (Deaton, 2008).
26. Nel 1529, in occasione delle nozze tra Ercole II d’Este, duca di Ferrara, e Renée di Francia, per esempio, per il banchetto furono realizzate 25 statue di zucchero raffiguranti le prove di Ercole (Marshall, 2015).
27. Si veda Douglas e Isherwood (1979), riportato in Jackson (2009).
28. Per il classico argomento secondo cui la simbologia dello status, spesso dipinta come un prodotto dell’età moderna o del capitalismo, ha profonde radici storiche, si veda Reinhold (1969).
29. Due archeologi in particolare sostengono che l’apposizione di un marchio alle merci non è emerso con il capitalismo globale contemporaneo, ma risale invece agli inizi della vita urbana (Bevan e Wengrow, 2010).
30. Braudel (1992, 1, p. 313-315). Braudel sostiene che mentre i ricchi guidavano il gruppo, la borghesia in ascesa e persino i poveri non erano insensibili alla moda e la seguivano per imitazione, anche se a distanza.
31. Una delle iscrizioni scolpite sul tempio di Apollo a Delfi, in Grecia, era μηδὲν ἄγαν (“niente di troppo”). Il principio riappare negli scritti di Socrate, Platone e Aristotele. In un certo senso, il mito greco di Icaro, che voleva volare verso il sole ma nel farlo le sue ali di cera si sciolsero e lui cadde dal cielo, insegna questa lezione fondamentale. Sulla moderazione nell’antica Grecia, si veda anche Kallis (2019).
32. Westacott (2016, p. 1).
33. A testimonianza di questo processo di trasmissione culturale, più di un secolo dopo, Orazio scrisse il famoso verso Graecia capta ferum victorem cepit: la Grecia vinta vinse a sua volta il feroce vincitore.
34. L’Utopia di Thomas More (1516) fu redatta come critica dell’epoca. A causa della sproporzionata disuguaglianza di reddito e ricchezza, l’ordine sociale europeo era descritto come una “cospirazione dei ricchi”, percepiti come avidi ghiottoni senza scrupoli.
35. Questa è la cosiddetta “ipotesi del rango sociale da disuguaglianza di reddito”. Si veda, per esempio, Bricker, et al. (2020) sull’acquisto di auto di lusso, o Walasek e Brown (2015) sulle ricerche su internet. Lo stesso punto è stato sollevato da Wilkinson e Pickett (2010).
36. I social media e i reality show giocano un ruolo in questo senso, abbattendo le precedenti barriere visive e mostrando, a scopo di intrattenimento, il modo in cui le persone ricche e la loro prole sprecano il denaro (Cohen, 2018).
37. Mi aspetterei che la classifica vedesse come soluzione migliore la riduzione della tendenza del mercato alla concentrazione del reddito e della ricchezza, per esempio con forti misure di politica della concorrenza nei confronti delle aziende di tecnologia digitale. Le misure di seconda scelta comprendono la redistribuzione attraverso tasse e sussidi; queste sono leggermente meno favorite perché probabilmente genererebbero maggiori tensioni nella società rispetto alla soluzione di prima scelta. Una decisione meno auspicabile è anche, a mio avviso, la tassazione dei beni di lusso, perché è verosimile che la domanda di questi beni da parte dei ricchi aumenti (o al massimo rimanga costante) al crescere del prezzo. Per i “beni Veblen”, la domanda è alimentata dal prezzo elevato e dalla scarsità. In una società con elevata disuguaglianza, tassare i beni di lusso non aumenterà la democratizzazione dei consumi né farà diminuire il senso di squilibrio all’interno della società. Una via di mezzo tra la redistribuzione e la tassazione dei beni di lusso è l’imposta progressiva sui consumi, sostenuta da Frank (2011), che tuttavia rischia di incontrare problemi di attuazione.
38. Si veda in particolare Chancel (2020, p. 95-108).
39. Milanovic (2019, p. 180-184).
40. Secondo le sagge parole del miliardario cinese Jack Ma, “Quando hai un milione di dollari, sei una persona fortunata. Quando hai 10 milioni di dollari, hai dei problemi e molti grattacapi. Quando hai più di un miliardo di dollari, o 100 milioni di dollari, è una responsabilità che hai: è la fiducia della gente nei tuoi confronti, perché la gente crede che tu possa spendere i soldi meglio degli altri”. Maria Tadeo, “Jack Ma: The Richest Man in China on How to Be Happy and Successful in Business”, Independent, 24 settembre 2014. Questo stesso concetto è però antico, in quanto risale addirittura alla Bibbia (Luca 12:48): “A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più”.
41. L’amore per il possesso, la ricchezza, il potere e il lusso potrebbe far aumentare la paura della perdita, rendendo gli individui più egoisti, meno generosi e meno coraggiosi. Pertanto, la frugalità completerebbe la serie di caratteristiche che promuovono la moralità umana cooperativa (Westacott, 2016, p. 55-56).
42. La presenza di filantropi su vasta scala, come Bill Gates, George Soros o Warren Buffet, riduce in qualche modo il pessimismo di Branko Milanovic (2019) sul fatto che singoli individui compiano azioni morali, associate a un intervento sistemico apparentemente irrealizzabile. John Kenneth Galbraith (1958, p. 76) sostiene, invece, che un ritorno alla moralità è già avvenuto in passato, dopo gli incredibili eccessi di sfarzo del primo capitalismo in America.
43. Ciò solleva l’annoso dibattito sul ruolo della filantropia, in particolare negli Stati Uniti. La filantropia contribuisce positivamente alla società, ma non può sostituire la redistribuzione attraverso la tassazione perché i singoli filantropi si concentrano tipicamente sulle cause che stanno loro a cuore, senza valutare le priorità della società. Per esempio, un quartiere potrebbe ritrovarsi con una biblioteca di alta qualità finanziata dalla filantropia, ma senza cibo, servizi igienici o alloggi.
44. Gli individui “esprimono una preferenza per i profili salariali che aumentano nel tempo, anche se questi hanno valori attualizzati inferiori rispetto a profili alternativi con salari costanti o decrescenti. Questa osservazione è molto difficile, se non impossibile, da far quadrare con una funzione di utilità fissa che non dipende dai redditi passati", Clark, et al. (2008, p. 102).
45. Se dovete leggere un solo articolo su questo argomento, vi consiglio la panoramica di Clark, et al. (2008). Altri studi che sostengono alcune delle mie affermazioni sulla teoria del reddito relativo sono di Luttmer (2005), Perez-Truglia (2019) e Neumark e Postlewaite (1998).
46. Questo esempio proviene da Solnick e Hemenway (1998). Esperimenti e indagini simili riportano risultati analoghi. Si veda Cohen (2018, p. 134-135).
47. Max Weber (1905, p. XXXI) ha espresso la stessa convinzione, usando parole molto forti: “L’impulso all’acquisizione, alla ricerca del guadagno, del denaro, della maggior quantità possibile di denaro, non ha di per sé nulla a che fare con il capitalismo. Questo impulso esiste ed è esistito tra camerieri, medici, cocchieri, artisti, prostitute, funzionari disonesti, soldati, nobili, crociati, giocatori d’azzardo e mendicanti. Si può dire che è stata comune a tutti i tipi e a tutte le condizioni di uomini in tutti i tempi e in tutti i paesi della terra, ovunque ne sia o sia stata data la possibilità oggettiva. Si dovrebbe insegnare nell’asilo della storia della cultura che questa idea ingenua del capitalismo deve essere abbandonata una volta per tutte”.
48. Matteo 20:1-16.
49. “Two Monkeys Were Paid Unequally: Excerpt from Frans de Waal’s TED Talk”, https://www.youtube.com/watch?=meiU6TxysCg. Per prove più formali, si veda Chen, et al. (2006).
50. Pur non utilizzando questo specifico quadro analitico, ciò era già stato accennato da Galbraith (1958, p. 80).
51. Nel 1883, William K. Vanderbilt diede un ballo che costò l’equivalente odierno di 6,4 milioni di dollari (Galbraith, 1958, p. 50). Nel 1897, nel bel mezzo di una depressione economica nazionale, Bradley Martins organizzò quella che venne definita “la festa più sfarzosa della storia degli Stati Uniti”, trasformando la sala da ballo dell’Hotel Waldorf in una replica della reggia di Versailles, per l’equivalente odierno di 12,5 milioni di dollari. Uno degli invitati si sarebbe presentato con un’armatura intarsiata d’oro del valore di 314.000 dollari al prezzo odierno. M. Galante e G. Lubin, “The Most Ostentatious Party in US History”, Business Insider, 6 novembre 2012, https://www.businessinsider.com/bradley-martin-ball-of-1897-2012-11.
52. Ricardo (1817)
53. Hobbes (1651, p. 89). Un elemento che potrebbe rafforzare la stabilità di una società del modello in basso a destra in figura 5.1. potrebbe essere un sistema di valori premoderno in cui la posizione sociale (aristocratico o contadino, padrone o servo della gleba) è determinata alla nascita ed è in gran parte fuori dal proprio controllo.
54. Questi esempi sono tratti da Henrich (2016, p. 22-33).
55. Perché la Grande divergenza prese il via in Europa e non in Cina, che aveva un livello paragonabile di sviluppo tecnologico, diritti di proprietà e amministrazione pubblica funzionante? Mokyr (2016) ipotizza una serie di ragioni, tra cui il fatto che l’Europa fosse composta da paesi vicini in costante competizione e che si fosse orientata verso una mentalità scientifica e illuminista. Il primo di questi motivi si basa su Landes (1998), il quale osserva che la competizione favoriva la libertà di pensiero, dato che un uomo di scienza poteva facilmente trovare un impiego presso una corte rivale. Si veda anche l’Appendice B.
56. Questo punto viene sottolineato con forza da Fouquet e Broadberry (2015), che si basano su dati dettagliati per i paesi europei.
57. Il famoso orologio Su Sung, forse l’orologio ad acqua più avanzato mai costruito, richiese otto anni di lavoro nell’XI secolo. Quando i gesuiti arrivarono in Cina, 400 anni dopo, il know-how della sofisticata tecnologia di costruzione degli orologi era scomparso (Mokyr, 2016, p. 319). Gli antichi Romani inventarono il cemento idraulico, che permise loro di costruire banchine, bacini idrici, fondazioni di fari e porti su tutta la costa settentrionale dell’Africa (priva di porti naturali) e quindi di assicurarsi il controllo militare ed economico del Mediterraneo. Con la caduta dell’impero romano, tuttavia, questo know-how andò quasi perduto. Nessuna fonte medievale ne fa menzione e le grandi cattedrali gotiche furono costruite usando solo malta di calce (Dartnell, 2015, p. 126). L’acciaio Damasco del III e IV secolo era rinomato per la sua qualità, ma veniva prodotto con un metodo che è andato perso nella storia. Walter Sullivan, “The Mystery of Damascus Steel Appears Solved”, New York Times, 29 settembre 1981.
58. Morris (2013) esamina separatamente l’Occidente e l’Oriente, dato che la sua argomentazione si basa sull’evidenza che queste due grandi civiltà si sono sviluppate in parallelo. Riporto i dati relativi all’Occidente. Le due regioni, in ogni caso, mostrano tendenze piuttosto simili fino alla rivoluzione industriale.
59. La crescita costante della popolazione ha portato a un aumento automatico del numero di idee in circolazione. Secondo Jones (1992, p. 2), “Il numero di nuove idee prodotte in un anno aumenta di 110.000 volte [...] tra il 25000 a. C. e il XX secolo. Un fattore 108 di questo aumento è dovuto al fatto che il XX secolo ha una base di popolazione più ampia dalla quale attingere gli inventori”. Questo porta Jones alla conclusione che un qualche tipo di rivoluzione industriale era inevitabile: era solo questione di tempo e di luogo.
60. Questa tesi è stata avanzata per la prima volta dall’economista Esther Boserup (1965). Più recentemente, il premio Nobel Michael Kremer ha supportato la teoria di Boserup con prove empiriche. Questo lavoro integra la teoria di Malthus, che guardava all’altra faccia della medaglia: come la crescita della popolazione dipendesse dalla tecnologia disponibile per la produzione alimentare (Kremer, 1993).
61. Oltre alle storie dei Maya e degli abitanti dell’Isola di Pasqua, Diamond (2004) racconta quelle dell’antica civiltà cambogiana Khmer di Angkor, di quella pre-incaica Tiwanaku intorno al lago Titicaca, del grande centro urbano di Tenochtitlan nell’antico Messico centrale e degli Anasazi nel Sud-Ovest americano. Tutte queste civiltà sono decadute a causa di un cambiamento climatico, di siccità prolungate o intense o del disboscamento. Su scala più piccola, i Norreni della Groenlandia sono scomparsi perché non si sono adattati alla Piccola Era Glaciale. Si vedano anche Boccaletti (2021) e Fagan e Durrani (2021).
62. “La crescita, in forme diverse, è stata una caratteristica dell’umanità fin dagli inizi [...] È vero, un certo numero di civiltà si è fermato, alcune sono addirittura scomparse, ma la forza del processo complessivo era tale che la popolazione mondiale continuava a crescere” (Cohen, 2018, p. 62).
63. Una serie di recenti articoli mette in discussione l’opinione diffusa secondo cui i Millennial hanno preferenze molto diverse rispetto alle generazioni precedenti, per esempio per quanto riguarda il possesso di un’auto e i chilometri percorsi. Le differenze osservate tendono a essere correlate al ritardo dei Millennial nel formare una famiglia e ai redditi inferiori, conseguenza dell’ingresso nel mercato del lavoro durante la Grande recessione (Leard, Linn e Munnings, 2019; Kurz, Li e Vine, 2018; Knittel e Murphy 2019). Negli Stati Uniti non emerge un chiaro effetto generazionale sulle emissioni di anidride carbonica, mentre in Francia lo si osserva e lo si attribuisce in gran parte alle restrizioni economiche rispetto ai Baby Boomer piuttosto che ai maggiori timori di crisi ecologica (Chancel, 2020, 98-101).
64. Terzi (2020, “Crafting an Effective Narrative on the Green Transition”).
65. Galbraith (1958, p. 91).
66. Karl Marx nel 1846 metteva in relazione il tenore di vita con la “sostituzione del dominio delle circostanze e del caso sugli individui con il dominio degli individui sul caso e sulle circostanze” (Sen, 1984, p. 87).
67. Questo elemento assume una connotazione negativa, che si ricollega in particolare alle crudeli azioni del colonialismo. Eppure, i paesi ricchi e democratici sono costantemente invitati a stigmatizzare le violazioni della democrazia e dei diritti umani in tutto il mondo e ad agire. Anche questa è una forma di proiezione di sistemi di valori, e la sua efficacia si basa sul potere politico ed economico.
68. Al di là dei casi di completo collasso della civiltà, la differenza cruciale nei modelli di crescita economica tra paesi avanzati ed emergenti non è il tasso di crescita assoluto, ma piuttosto la volatilità. I paesi poveri alternano periodi di crescita estremamente elevata (generalmente inedita nel mondo sviluppato) a bruschi crolli, mentre i paesi ricchi mostrano tassi di crescita più lenti, caratterizzati però da una bassa volatilità anno dopo anno (Pritchett, 2000). Questo è un altro indicatore di come la crescita economica e il progresso tecnico contribuiscano alla resilienza. Per un mio contributo scientifico su questo tema, si veda Peruzzi e Terzi (2021).
69. “La verità ultima e nascosta del mondo è che è qualcosa che creiamo noi, e che potremmo facilmente creare in modo diverso” (Graeber, 2015, p. 89). Tim Jackson (2009, p. 183-184) fa eco a queste parole, sostenendo che “l’economia è un artefatto della società umana [...] Noi elaboriamo le regole del gioco e ne stabiliamo i costumi. Costruiamo e regolamentiamo le istituzioni che lo servono. I suoi guardiani sono i protagonisti di un dramma che abbiamo creato noi stessi. Riscrivere il loro ruolo è interamente di nostra competenza”.
70. Una linea di argomentazione simile viene avanzata dal biologo evoluzionista Lonnie Aarssen (2015).