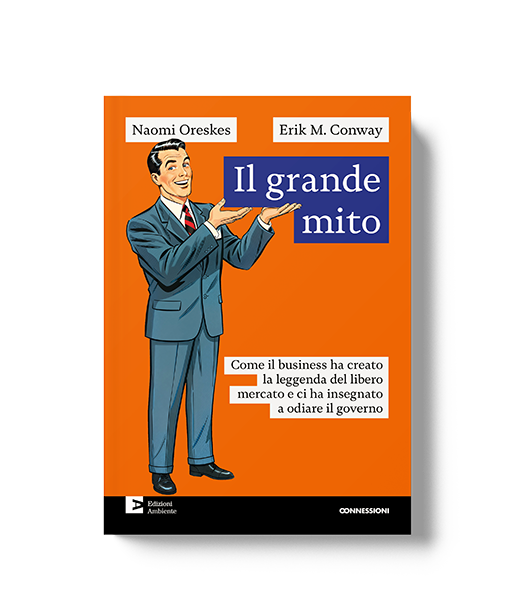
Il grande mito
Come il business ha creato la leggenda del libero mercato e ci ha insegnato a odiare il governo
9. Alla guida della Scuola di Chicago
1. Hayek F.A., The Road to Serfdom: Text and Documents, con prefazione e introduzione di Bruce Caldwell, University of Chicago Press, Chicago 2003, 99
2. Phillips-Fein K., Invisible Hands: The Businessmen’s Crusade Against the New Deal, W.W. Norton, New York 2010, 41
3. Ibidem, 29. Si veda anche Nash G.H., The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945, 30th anniv. ed., Intercollegiate Studies Institute, Wilmington, DE, 2006
4. Phillips-Fein K., Invisible Hands, 29
5. Eow G.T., “Fighting a New Deal: Intellectual Origins of the Reagan Revolution, 1932-1952”, tesi di dottorato, Rice University, Houston 2007, la spiega così: “Uno sguardo più attento alle origini della Scuola di Chicago, tuttavia, rivela che l’attivismo politico, piuttosto che la ricerca, ha portato alla creazione di questa scuola di pensiero” (9)
6. Nash G.H., The Conservative Intellectual Movement, cit., 11
7. Phillips-Fein K., Invisible Hands, cit., 31
8. Ibidem, 30
9. In realtà, gli intoppi erano due. Phillips-Fein K., Invisible Hands, cit., 43, osserva che Crane aveva alcune riserve: temeva che Hayek fosse ebreo, che avrebbe condiviso la caratteristica simpatia ebraica per il collettivismo, e che fosse troppo disposto a scendere a compromessi su questioni come il salario minimo. Ma poi venne a sapere che Hayek non era ebreo e le altre preoccupazioni evidentemente svanirono.
10. Phillips-Fein K., Invisible Hands, cit., 40-52, citazione a 42
11. van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics and the Birth of Neoliberalism”, in The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, Mirowski P., Plehwe D. (a cura di), Harvard Press, Cambridge, MA, 2009, 141
12. Ibidem, 149-50
13. Ibidem, 150. Caldwell conclude che proprio durante il tour del 1945 per la presentazione del libro di Hayek sono stati gettati i semi della Scuola di Chicago. Questa affermazione dipende da come questa viene definita, dato che Knight, Simons e Viner erano già presenti, così come Milton Friedman, Aaron Director e Rose Friedman (all’epoca Rose Director). È certamente vero che sotto l’influenza di Luhnow la Scuola di Chicago si è mossa in una direzione più dottrinaria e apertamente politica.
14. Caldwell B., introduzione a Hayek F.A., The Road to Serfdom, cit., 20
15. van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 141
16. Su Simons, si veda “Biographical Note”, Guide to the Henry C. Simons Papers 1925-1972, University of Chicago Library, consultato il 6 aprile 2021, https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.SIMONS. Lo studioso condivideva la visione negativa di Knight sul New Deal ma, in contrasto con l’ipocrisia di molti suoi colleghi, si preoccupava di tutte le forme di concentrazione di potere, comprese le corporazioni e le organizzazioni commerciali, così come i grandi sindacati e i monopoli (si vedano van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 142-143; Eow G.T., “Fighting a New Deal”, cit., 76-78). Ammise anche che il laissez-faire non significasse “inattività del governo”, ma che il governo proteggesse e sostenesse la concorrenza, e che la redistribuzione del reddito potesse a volte essere giustificata (Eow, 76, 79). Il tono di Simons, tuttavia, era spesso sorprendentemente poco moderato. Si veda, per esempio, Simons H.C., A Positive Program for Laissez Faire: Some Proposals for a Liberal Economic Policy, Public Policy Pamphlet N° 15, University of Chicago Press, Chicago 1934, 14-16, che Eow caratterizza come “una polemica manifesta” (74). Nel 1936, Simons avrebbe insistito sul fatto che l’unica scelta era “tra un sistema competitivo e un collettivismo autoritario” (Eow, 84)
17. Eow G.T., “Fighting a New Deal”, cit., 96-98
18. Ibidem, 99, osserva che la University of Chicago in un primo momento si era opposta all’idea di un think tank apertamente politico e di parte. Non è chiaro perché abbiano accettato la seconda volta, se per i soldi di Luhnow o per l’idea di collocarlo nella facoltà di Legge.
19. van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 165, citano Nef J., Search for Meaning: The Autobiography of a Nonconformist, Public Affairs Press, Washington, D.C., 1973
20. Ibidem, 151
21. Ebenstein L., Chicagonomics: The Evolution of Chicago Free Market Economics, St. Martin’s Press, New York 2015, 76
22. Henry Simons, citato in Ebenstein L., Chicagonomics, cit., 145. Eow G.T., “Fighting a New Deal”, cit., osserva che ad Harvard Joseph Schumpeter continuava a sostenere il laissez-faire, ma era sempre più isolato. “In effetti, il trionfo dell’idea di pianificazione economica fu così rilevante negli anni Trenta che lo storico Sidney Fine identificò il periodo come la fine di una battaglia cinquantennale tra i sostenitori del laissez-faire e quelli del welfare state” (8). Il resoconto di Fine sulla morte del laissez-faire era prematuro.
23. van Horn R., “Henry Simons’ Death”, History of Political Economy, 46, n° 3, settembre 2014, 529
24. Cowles Foundation for Research in Economics, “About Us”, consultato il 6 aprile 2021, https://cowles.yale.edu/about-us. Sulla Commissione Cowles, si vedano Ebenstein L., Chicagonomics, cit., cap. 6; Bernstein M.A., A Perilous Progress: Economists and Public Purpose in Twentieth-Century America, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2001, 95-100
25. van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 164
26. Ibidem.
27. Eow G.T., “Fighting a New Deal”, cit., 99
28. Tutto ciò ha gettato i semi di quello che è diventato il programma in Diritto ed Economia: si veda Medema S.G., “Chicago Law and Economics”, in The Elgar Companion to the Chicago School of Economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2010, 160-174. Tra i suoi membri di spicco c’erano Richard Posner, Ronald H. Coase e Gary Becker. Erano intransigenti sostenitori dei poteri del libero mercato e critici nei confronti della regolamentazione governativa, anche se negli anni successivi Posner affrontò più seriamente il problema del fallimento del mercato. Particolarmente importante per i nostri scopi è Coase, che cercò di confutare la tesi di Pigou. Basandosi su Friedman, sottolineò i rischi per i diritti di proprietà derivanti da un approccio pigouviano, sostenendo che una tassa sull’inquinamento “distoglie l’attenzione dagli altri cambiamenti del sistema inevitabilmente associati alla misura correttiva, cambiamenti che possono benissimo produrre più danni della carenza originale” (43). R.H. Coase, “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, 3, ottobre 1960, 1-44
29. van Horn osserva che, nelle prime discussioni, Aaron Director suggerì di discutere sia i benefici sia i limiti del libero mercato, ma è chiaro che Luhnow non era interessato a delineare questi ultimi. Si veda van Horn R., “Henry Simons’ Death”, cit., 529
30. van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 152
31. Ibidem.
32. Negli anni successivi, George Stigler sottolineò che la storia dell’economia era “l’ultimo settore di ricerca non sovvenzionato in economia”. Eppure non mostrava alcun interesse a considerare come le fonti di tali sussidi influenzassero il lavoro svolto. Si veda Rosenberg N., “Adam Smith’s Best Friend”, Journal of Political Economy, 101, n° 5, ottobre 1993, 833
33. van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 146
34. Ibidem, 152-153
35. Ibidem, 154
36. Sull’incontro di Luhnow con Hutchins, si veda van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 165. Sulla relazione tra questa battuta d’arresto e la morte di Henry Simons, si veda van Horn R., “Henry Simons’ Death”, cit.
37. Miller H.S., Dollars for Research: Science and Its Patrons in Nineteenth-Century America, University of Washington Press, Seattle 1970. In alcuni campi, i finanziamenti provenivano anche da agenzie statali, per esempio le indagini geologiche statali che sostenevano la ricerca dei geologi accademici o i servizi sanitari pubblici statali.
38. Dieter Plehwe fa notare che i neoliberisti spesso si considerano “indipendenti” se non prendono finanziamenti dallo Stato, ma non vedono alcun problema nell’accettare denaro da mecenati privati con programmi politici espliciti. Plehwe D., introduzione a The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, Mirowski P., Plehwe D. (a cura di), Harvard University Press, Cambridge, MA, 2009, 31-32. La logica è che lo Stato è onnipotente – o almeno potenzialmente tale – mentre gli imprenditori sono un gruppo eterogeneo con interessi diversi e quindi non possono lavorare con il tipo di obiettivo unico che può avere un governo, o non è probabile che lo facciano. Questo ideale è smentito dalla storia qui raccontata, così come dalla disorganizzazione quotidiana e dalle lotte intestine della maggior parte dei governi. Plehwe nota anche che la Scuola di Chicago ha violato grottescamente l’attenzione che Hayek e la Mont Pelerin society ponevano sullo Stato di diritto quando iniziò a sostenere la prospettiva giuridico-economica secondo cui i giudici applicano una regola di “ragione economica”. Si trattava proprio di quel tipo di discrezionalità soggettiva che la dichiarazione originaria della Mont Pelerin society aveva individuato con approvazione. Sull’influenza dell’argomentazione della Scuola di Chicago circa la “regola della ragione” nell’applicazione (o non applicazione) della legge antitrust, si veda Ervin S.J., Ramsey C., The Role of the Supreme Court: Policymaker or Adjudicator?, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, D.C., 1970
39. Plehwe D., introduzione a The Road from Mont Pèlerin, cit., 21; van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 158-163
40. Caldwell B., introduzione a Hayek F.A., The Road to Serfdom, cit., 20
41. Sull’assunzione di George Stigler, si veda Appelbaum B., The Economists’ Hour: False Prophets, Free Markets, and the Fracture of Society, Little, Brown, New York 2019, 140
42. Plehwe D., introduzione a The Road from Mont Pèlerin, cit., 29
43. Hayek F.A., citato in Caldwell, introduzione a Hayek F.A., The Road to Serfdom, cit., 20. La Scuola di Chicago divenne anche molto più antisindacale della maggior parte dei neoliberisti europei (Plehwe D., introduzione a The Road from Mont Pèlerin, cit., 30). Dati gli atteggiamenti fortemente antisindacali di Crane, Luhnow e dei loro associati – e il modo in cui avevano insistito sul fatto che i sindacati erano una forma di monopolio, non diverso da quello di una ferrovia o di un’azienda di servizi – sembra ragionevole concludere che la loro influenza abbia avuto un qualche ruolo in questo sviluppo.
44. Per una trattazione completa, si vedano Ebenstein L., Chicagonomics, cit.; Appelbaum B., The Economists’ Hour, cit.; Stedman Jones D., Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012
45. The Nobel Prize, “George J. Stigler: Facts”, 1° maggio 2021, https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1982/stigler/facts/
46. Un’edizione in facsimile del 1966 è stata pubblicata in due volumi, ciascuno di oltre 500 pagine: Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Augustus M. Kelley, New York 1966
47. Smith A., The Wealth of Nations, cit., libro 1, cap. 2, 21-22
48. Smith A., The Wealth of Nations, cit., 250. Questo passaggio è particolarmente significativo perché è uno dei pochi in cui Smith usa la parola “restrizione” in un contesto positivo; la maggior parte delle sue analisi sulle restrizioni, per esempio nel contesto del mercantilismo nel libro 4, è critica. Si veda in particolare il libro 4, cap. 3, in cui discute l’“irragionevolezza” delle restrizioni mercantilistiche al commercio. Dobbiamo a Ronald F. Hoffman, ex membro dello staff del Council of economic advisers sotto il presidente Nixon, il merito di aver richiamato la nostra attenzione su questo passaggio. È stato discusso anche in Naggar T., “Adam Smith’s Laissez Faire”, American Economist, 21, n° 2, 1977, 36, e in Viner J., “Adam Smith and Laissez Faire”, Journal of Political Economy, 35, n° 2, aprile 1927, 224-225
49. Smith A., The Wealth of Nations, cit., 224. Questo passaggio è citato anche da Amartya Sen per sostenere che Smith sottolinea la necessità di virtù diverse dall’interesse personale per il funzionamento dell’economia di mercato, e ancor meno della società nel suo complesso. Si veda Sen A., “Uses and Abuses of Adam Smith”, History of Political Economy, 43, n° 2, estate 2011, 266
50. Smith A., The Wealth of Nations, cit., 229
51. Ibidem, 228-230
52. Ibidem, 233-234
53. Ibidem, 247
54. Ibidem, 248-249
55. Ibidem, 250
56. Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 259. Sen osserva che Smith era impressionato dal potere e dal dinamismo dei mercati, e fornisce un resoconto convincente del modo in cui quel dinamismo funzionava, ma tutto ciò è ben lontano dal considerare i mercati come completi, e non c’è nulla in Smith che indichi che egli credesse nell’autosufficienza dell’economia di mercato.
57. Viner J., “Adam Smith and Laissez Faire”, cit., 227
58. Smith A., The Wealth of Nations, cit., 61
59. Ibidem, 62
60. Sulle variazioni dei salari, si veda Ibidem, 86-101
61. Adam Smith, citato in Rothschild E., “Adam Smith and Conservative Economics”, Economic Historical Review, 45, n° 1, 1992,74-96; Smith A., The Wealth of Nations, cit., 70. Si veda anche Steinberg J., “To Be Themselves Tolerably Well Fed, Cloathed, and Lodged”: Liberalism, The Humanization of Labor, and Adam Smith’s Protests Against the Injustice of Working Class Poverty and Misery, BookLocker.Com, Inc, St. Petersburg, FL, 2019
62. Smith A., The Wealth of Nations, cit., 71
63. Adam Smith, citato in Rothschild E., “Adam Smith and Conservative Economics”, cit.; Smith A., The Wealth of Nations, cit., 70. Si veda anche Steinberg J., “To Be Themselves”. Questo passaggio ci ricorda il fatto importante, sottolineato anche da Sen, in base al quale, anche se nel 1776 il capitalismo era agli inizi, molti dei suoi fallimenti stavano già diventando chiari. “Anche per Adam Smith [...] gli enormi limiti dell’affidarsi interamente all’economia di mercato e solo al motivo del profitto erano assolutamente chiari” (Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 260). Sen vede in questo la spiegazione del perché Marx potesse ammirare Smith e allo stesso tempo disprezzare John Stuart Mill. Dennis C. Rasmussen sostiene che Smith vedeva la società commerciale come la migliore di un menù di opzioni sbagliate. Si veda Rasmussen D.C., The Problems and Promise of Commercial Society: Adam Smith’s Response to Rousseau, Penn State University Press, University Park, PA, 2008
64. Smith A., The Wealth of Nations, cit.
65. Ibidem, 73-74
66. Adam Smith, citato in Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 262. Sen sottolinea che Smith credeva che l’interesse personale fosse una motivazione potente e utile per l’attività economica, ma non pensava affatto che fosse l’unica valida, o addirittura l’unica esistente, per l’azione umana, come molti liberisti di oggi hanno bizzarramente sostenuto.
67. Rothschild E., “Adam Smith and Conservative Economics”, cit., 84
68. Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 262
69. Ibidem, 625
70. Ibidem, 634-635
71. Per esempio Huemer M., “Is Taxation Theft?”, Libertarianism.org, consultato il 7 aprile 2021, https://www.libertarianism.org/columns/is-taxation-theft
72. Smith A., The Wealth of Nations, cit., 634
73. Ibidem, 625. Non siamo studiosi di Marx, ma il linguaggio è così simile che sembra ragionevole chiedersi se Marx abbia tratto da Smith la sua famosa affermazione “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”.
74. La visione selettiva di Stigler è evidente anche nel suo atteggiamento verso la razza. Nel 1962 scrisse un pezzo sorprendente in cui dava la colpa della situazione degli afroamericani a loro stessi, includendo questo passaggio: “Il Negro [sic] è escluso da molte occupazioni a causa delle varie barriere che i pregiudizi possono innalzare [...] Ma è escluso da un numero maggiore di occupazioni a causa della sua stessa inferiorità come lavoratore [...] Considerate il Negro [sic] come un vicino. È spesso respinto ed evitato dall’uomo bianco [...] perché la famiglia negra [sic] è, in media, un gruppo disorganizzato, moralmente lassista, e porta con sé un rapido aumento della criminalità e del vandalismo”. L’esperienza contrastante di ebrei e neri, sosteneva Stigler, dimostrava che i problemi di questi ultimi avevano perlopiù origine da loro stessi. Stigler G., “The Problem of the Negro”, New Guard, 1960, ristampa: https://www.bradford-delong.com/2019/05/weekend-reading-george-stigler-in-1962-on-the-problem-of-the-negro.html. Le potenziali confutazioni di questa posizione sono numerose. Una, ovvia, è il massacro di Tulsa del 1921; un’altra è l’allontanamento dei proprietari di case e degli imprenditori neri e il sequestro delle loro proprietà a Manhattan Beach, in California. Si veda Fortin J., “This Black Family Ran a Thriving Beach Resort 100 Years Ago. They Want Their Land Back”, New York Times, 11 marzo 2021. Questo è un esempio di ciò che il sociologo Woody Doane nota come tendenza delle classi privilegiate a sostenere “un quadro interpretativo in cui le spiegazioni dei bianchi per la disuguaglianza si concentrano sulle caratteristiche culturali (per esempio, motivazioni, valori) dei gruppi subordinati [...] Dal punto di vista politico, questa colpevolizzazione per la loro posizione economica inferiore serve a neutralizzare le richieste di iniziative antidiscriminatorie o di ridistribuzione delle risorse”. Citato in Mills C.W., “White Ignorance”, in Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, Proctor R.N., Schiebinger L. (a cura di), Stanford University Press, Stanford, CA, 2008, 230-249
75. Viner J., “Adam Smith and Laissez Faire”, cit., 228
76. Ibidem, 231, citato anche in Naggar T., “Adam Smith’s Laissez Faire”, cit., 37
77. Viner J., “Adam Smith and Laissez Faire”, cit., 218
78. Ibidem, 218. Viner sottolinea anche che, a volte, Smith sembra suggerire che il governo sia parte dell’ordine naturale, e non una sua distorsione, un’idea che i suoi successivi adoratori respinsero con fermezza!
79. L’ostilità di Smith nei confronti dei docenti di Oxford potrebbe essere legata alla sua animosità nei confronti della religione istituita, dal momento che le università e i college dell’epoca erano tutte istituzioni ecclesiastiche. Sulle opinioni di Smith in merito alla religione costituita, si veda Rothschild E., “Adam Smith and Conservative Economics”, cit., 91. Può invece semplicemente essere che fosse malato e infelice mentre era a Oxford. Si veda Rae J., Life of Adam Smith, Macmillan, New York 1895
80. Stigler G.J., Selections from The Wealth of Nations Smith, Harlan Davidson, Inc., Wheeling, IL, 1957, 108-109
81. Ibidem, 113
82. Stigler G.J., Selections, cit., 110
83. Naturalmente esiste una soluzione normativa a questo problema, a cui Smith accenna: lo Stato potrebbe imporre la trasferibilità dei crediti e/o la trasportabilità delle borse di studio.
84. La ricerca su Google Books rivela diversi altri usi del verbo “regolare”, ma nessun altro uso del sostantivo “regolazione”, consultato il 7 aprile 2020, https://www.google.com/books/edition/Selections_from_The_Wealth_of_Nations/hPNjBAAAQBAJ?hl=en&gbpv =1&bsq=regulation
85. Rosenberg N., “Adam Smith’s Best Friend”, cit.; Rosen S., “George J. Stigler and the Industrial Organization of Economic Thought”, Journal of Political Economy, 101, n° 5, ottobre 1993, 809-817
86. Rothschild E., “Adam Smith and Conservative Economics”, cit.
87. Per un’eccellente sintesi, si veda Adam Smith institute, “The Theory of Moral Sentiments”, consultato il 7 aprile 2021, https://www.adamsmith.org/the-theory-of-moral-sentiments
88. Sen sottolinea che per Smith il mercato era un’istituzione sociale importante, ma non l’unica. Le istituzioni non di mercato svolgono un ruolo cruciale nel fornire beni pubblici, mentre lo Stato ha un ruolo unico nel regolare i mercati quando necessario. Si veda Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 258-259
89. Ibidem, 258
90. Freedman C., “Was George Stigler Adam Smith’s Best Friend? Studying the History of Economic Thought”, Journal of the History of Economic Thought, 29, n° 2, giugno 2007, 173
91. Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 258
92. Ibidem.
93. Eow G.T., “Fighting a New Deal”, cit., 83
94. Sen A., “Uses and Abuses”, cit., 258
95. Si può andare più a fondo. Smith non ci dice come definire la sicurezza e l’incolumità, né riflette su quanto debba essere ridotta la minoranza per giustificare la violazione della sua libertà a favore di altri. Non anticipa neppure il problema di che cosa fare quando le azioni della generazione attuale minacciano il futuro, e tanto meno vi risponde. Ma queste ulteriori domande non sarebbero state poste dagli studenti che leggono lo Smith di Stigler, perché non avrebbero saputo che Smith accettava la necessità di violare la libertà.
96. In effetti, come sottolineano van Horn e Mirowski, per essere dei capitalisti questi uomini erano sorprendentemente insensibili ai propri obblighi contrattuali! van Horn R., Mirowski P., “The Rise of the Chicago School of Economics”, cit., 166
97. John McGee citato in Wu T., The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age, ed. illustrata, Columbia Global Reports, New York 2018, 85. Spesso ci si riferisce a questa ipotesi come all’“ipotesi del mercato efficiente”. Per una discussione critica, si veda Cox H., The Market as God, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2016, 29
98. Kitch E.W., “The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Economics at Chicago, 1932-1970”, Journal of Law and Economics, 26, n° 1, 1983, 183
99. Come avrebbe detto in seguito Friedman, “un liberista ha fondamentalmente paura della concentrazione di potere”. Friedman M., Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962. La Scuola di Chicago non temeva però le concentrazioni di potere private, ma solo il potere governativo.
100. Per una recente discussione su Bork e sul suo ruolo nel minare l’applicazione delle norme antitrust, si veda Appelbaum B., The Economists’ Hour, cit., 149-154. Appelbaum concorda sul fatto che la teoria di Bork richieda una riscrittura della storia e definisce giustamente pro-monopolio la posizione di Bork.
101. “Economist, Hoover Fellow Aaron Director Dies at 102”, Stanford University, 22 settembre 2004, http://news.stanford.edu/news/2004/september22/obit-director-922.html
102. Sherman M., Associated Press, “Bork: Nixon Offered Next High Court Vacancy in ‘73”, Seattle Times, 26 febbraio 2013, https://www.seattletimes.com/seattle-news/politics/bork-nixon-offered-next-high-court-vacancy-in-73/
103. Questo argomento sarebbe stato invocato nel 2021 dal giudice federale che ha respinto la causa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Facebook, in parte sulla base del fatto che, essendo Facebook libero, non si poteva sostenere che la sua posizione monopolistica “costasse” qualcosa ai clienti. Si veda Zakrzewski C., Lerman R., “Court Says FTC Hasn’t Provided Evidence Facebook Is a Monopoly, Dismisses Lawsuit”, Washington Post, 28 giugno 2021 https://www.washingtonpost.com/technology/2021/06/28/ftc-facebook-antitrust-complaint-dismissed/
104. Questo punto è stato sottolineato nel 2022 dal viceprocuratore generale Jonathan Kanter, quando ha annunciato un rinnovato impegno del Dipartimento di Giustizia nell’applicazione delle norme antitrust: “Per anni studiosi e opinionisti hanno impiegato enormi energie per discutere il significato di espressioni che non compaiono nello statuto: l’effimero ‘standard di benessere del consumatore’. Secondo i miei calcoli, sono stati scritti 831 articoli accademici che invocano lo standard del benessere del consumatore, dei quali più di 200 dal 2020. È il regalo accademico che continua a dare i suoi frutti”. Ma non è stato solo un regalo accademico: è stato un dono alle industrie impegnate in pratiche predatorie, che hanno giustificato le proprie attività potenzialmente illegali sostenendo che andavano a vantaggio dei consumatori. Kanter J., “Antitrust Enforcement: The Road to Recovery”, intervento allo Stigler Center della University of Chicago, 21 aprile 2022, https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-jonathan-kanter-delivers-keynote-university-chicago-stigler #_ftn1
105. Bork R.H., “Legislative Intent and the Policy of the Sherman Act”, Journal of Law and Economics, 9, n° 1, gennaio 1966, 7-48; una discussione più completa è contenuta in Bork R.H., The Antitrust Paradox, Basic Books, New York 1978
106. Solo di recente è stata messa seriamente in discussione, per esempio in Khan L.M., “Amazon’s Antitrust Paradox”, Yale Law Journal, 126, n° 3, 2017, 564-907
107. Hofstadter R., “The Paranoid Style in American Politics”, Harper’s Magazine, novembre 1964, 199-200. Si vedano anche Wu T., The Curse of Bigness, cit.; Lande R.H., “Wealth Transfers as the Original and Primary Concern of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged”, Hastings Law Journal, 34, n° 1, settembre 1982, 65-151
108. John Sherman, citato in U.S. Congressional Record, S. 2460, 51° Congresso, 1° sessione, vol. 21, parte 12, 21 marzo 1890
109. Ibidem.
110. Ibidem.
111. Questo punto è elaborato in White R., Railroaded: The Transcontinentals and the Making of Modern America, W.W. Norton, New York 2011
112. Wu T., The Curse of Bigness, cit., 89
113. Friedman M., Capitalism and Freedom, cit., 2
114. Si veda la discussione nel capitolo 8
115. Wu T., The Curse of Bigness, cit., 91. A dire il vero, anche a sinistra c’è stato chi ha difeso il monopolio, per esempio quando John Kenneth Galbraith suggerì che il governo potesse dirigere il monopolio privato per servire gli interessi pubblici. Stoller M., Goliath: The 100-Year War Between Monopoly Power and Democracy, Simon & Schuster, New York 2019